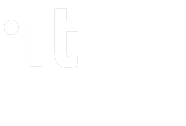Apiaceae
FAMIGLIA Apiaceae
Famiglia subcosmopolita molta ricca in specie, presenti allo stato spontaneo soprattutto nelle aree temperate del pianeta (circa 3500 raggruppate in più di 400 generi); si tratta per lo più di piante erbacee (raramente legnose). Molte sono velenose (ed anche mortali), ma numerose sono anche quelle utilizzate a fini alimentari, aromatizzanti, medicinali o anche ornamentali. Per poter giungere ad una corretta determinazione delle varie entità è essenziale poter osservare il seme, molto diversificato nelle varie specie, ma sarebbe utile contemporaneamente poter disporre anche dell’intera infiorescenza, dei fiori e delle foglie. I fiori sono disposti caratteristicamente in ombrelle (raramente in capolini o verticilli) e sono generalmente ermafroditi ed attinomorfi (a volte quelli periferici dell’infiorescenza sono zigomorfi, unisessuali o sterili); il calice manca di lembo o esso è rappresentato da 5 brevi dentelli; la corolla presenta 5 petali, a volte bilobi, di vario colore; le ombrelle sono spesso dotate di un involucro (verticillo di brattee) e composte di più ombrelle semplici di secondo ordine (ombrellette o umbellule) che a loro volta possono essere dotate di involucretto (verticillo di bratteole); le foglie sono composte (raramente semplici), alterne, senza stipole; spesso il picciolo risulta dilatato in una guaina. Il frutto secco è un diachenio, ovvero è formato da due “semi”, detti mericarpi, inizialmente riuniti attraverso la faccia interna; si dividono poi a partire dal basso, restando sospesi ad una struttura filiforme (carpoforo); ognuno di essi presenta da 5 a 9 coste longitudinali più o meno pronunciate (separate da solchi detti vallecole) e che a volte si presentano alate o spinulose; alla base degli stili, posti all’apice del mericarpo, vi è un ingrossamento, dove spesso vi si trova il nettare, detto stilopodio, differenziato nelle varie specie.
Il genere Aegopodium
ha distribuzione europea ed asiatica e conta ca. 7 specie erbacee (1 in Italia). Le sue piante presentano foglie composte da foglioline dentellate acutamente, petali da bianchi a rosati, assenza di involucro (o quasi) e involucretto, frutto più lungo che largo, privo di calice persistente e con stilopodio largo ca. la metà e stilo lungo ca. un terzo dell’achenio stesso.
-Aegopodium podagraria L. GIRALDINA SILVESTRE
G rhiz – Eurosiber. - IV-VII – Abbastanza comune e diffuso soprattutto nelle aree boschive.
Erbacea spesso formante colonie ± numerose, glabra, alta fino a 80-100 cm; le foglie inferiori, a lungo picciolo, sono biternate a segmenti lanceolati e dentellati; le cauline sono sessili; i piccoli fiori bianchi (o rosati) sono riuniti in ombrelle a 10-20 raggi, privi di involucro e involucretto; il frutto è ovoide, canalicolato, lungo 3-4 mm, non alato.
Habitat: ambienti fresco-ombrosi, come boschi e foreste, dalla pianura alla montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana, a W del Tabernacolo di Gavigno (2020) (Cantagallo); Montepiano, sopra Tavianella (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946, Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009, Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Giraldina silvestre): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: lungo i fossi su suoli abbastanza freschi e profondi.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: E’ specie commestibile ed officinale.
Il genere Aethusa
è composto da una sola specie erbacea con due sottospecie. Presenta caratteristici segmenti dell’involucretto: in numero da 1 a 5 (per lo più 3), più lunghi dei pedicelli, di forma lineare e pendenti; inoltre i petali rivolti all’esterno si mostrano maggiori degli altri, il frutto è privo di ali e dotato di coste dorsali rilevate.
-Aethusa cynapium L. subsp. elata (Friedl. ex Fisch.) Schübl. et Martens CICUTA AGLINA
H bienn – Eurosiber. - VIII-IX - Rara e localizzata.
Erbacea bienne - a differenza della subsp. nominale che è annuale - alta da 80 a 200 cm; il fusto, finemente striato, è eretto, maculato e ramificato in alto; le foglie sono tre volte divise con gli ultimi segmenti linaeri; ombrelle terminali a piccoli fiori bianchi, con diametro superiore a 4,5 cm e formate da 10-20 raggi, prive di involucro (raramente 1-2 piccole brattee) e con involucretto a 2-3 evidenti e lunghe bratteole rivolte all’esterno ed in basso; frutto ovato e canalicolato, lungo 3-4 mm.
Habitat: ambienti ombrosi e fresco-umidi (la subsp. nominale in habitat più aperti e luminosi).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009-Gestri & Peruzzi 2016: lungo il rio Fornelli e alle Ventose (Cantagallo).
NB: si tratta di una delle Cicute presenti allo stato spontaneo in Italia, e, anche se forse meno pericolosa di Conium maculatum, è fortemente sconsigliato il suo consumo per i pericolosi alcaloidi in essa presenti, fra i quali, sembra, la coniina.
Una curiosità è legata ad un particolare tipo di intossicazione che può colpire le popolazioni mediterranee durante il periodo di migrazione delle quaglie (primavera), quando vengono catturate e consumate. I sintomi corrispondono a quelli dell'intossicazione da Cicuta; per questo si è ipotizzato, dato che anche il periodo corrisponde a quello della maturazione dei semi di questa pianta, che le quaglie si nutrano abbondantemente e senza danni di questi semi, ma divenendo esse stesse velenose per coloro che se ne cibano (avvelenamento secondario). L'intossicazione è detta "coturnismo" proprio dal nome scientifico della quaglia (Coturnix coturnix).
Il genere Ammi
consta di 3-4 specie erbacee a distribuzione mediterranea (1 in Italia). Si tratta di piante simili a quelle del genere Visnaga (vedi): presentano fiori a petali bianchi o rosei, ombrelle terminali con numerosi peduncoli (meno di 60) non dilatati in alto e involucro con più di 4 brattee; le foglie sono 1 pennatosette, le cauline hanno lunghezza inferiore o uguale agli internodi corrispondenti, mentre le basali mostrano le ultime divisioni dentellate e larghe più di 2 mm.
-Ammi majus L. RIZZOMOLO
T scap – Euro-Medit. - V-VII – Non comune.
Pianta glaucescente, a fusto eretto e ramificato, alto 10-80 cm; le foglie appaiono da mono- a bi-pennate, le inferiori 3-4 pennatosette, a segmenti serrati, ellittici o ovati, dentellati con alla sommità denti cartilaginei e biancastri; le ombrelle sono costituite da 15-30 o più raggi, con involucro di brattee divise in 3-5 segmenti lineari; i fiori sono bianchi; frutto piccolo (1-2 mm) a 5 coste fini.
Habitat: campi coltivati.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: anche in area ofiolitica: campi delle ville Baylon e Ciabatti, ex-cava di Gello, (Prato), sentiero Patriarchi, (Montemurlo).
- Pianura: oss. Gestri 2017 Wikiplantbase#Toscana: campi coltivati (Montemurlo); nuovi ritrovamenti: nei campi coltivati a margine della ciclabile di Galcetello e Maliseti, presso Casale, Viale Fr. Cervi ed altrove (2023) (Prato).
PS: la pianta contiene furanocumarine, prodotti chimici che, sotto esposizione ai raggi UV, hanno la capacità di stimolare la pigmentazione della pelle nell'uomo. E' stata per questo utilizzati nel trattamento della leucodermia (o vitiligine) soprattutto per uso topico e sempre sotto attenta sorveglianza medica, per la possibilità di gravi effetti collaterali. La fotosensibilizzazione indotta dalle furanocumarine può provocare gravi dermatiti ed inoltre anche seri danni generali con comparsa di cefalea, vomito, diarrea ecc. In più l'uso prolungato può arrecare lesioni oculari, epatiche e favorire lo sviluppo di neoplasie: sono state infatti bandite le creme abbrozzanti a base di questa pianta!
Il genere Anethum
è rappresentato da piante erbacee annuali o perenni, a volte aromatiche, di cui non è possibile valutare il numero di specie per le differenze di interpretazione tassonomica esistente fra i vari autori (le specie di cui parleremo di seguito fino a poco tempo fa erano inserite nel genere Foeniculum, anzi addirittura ambedue considerate sottospecie di Foeniculum vulgare Mill.). A questo genere appartiene una specie coltivata a fini culinari: l’aneto. I fusti di queste piante sono eretti e articolati in nodi ed internodi; le foglie, disposte a spirale, sono più volte divise in segmenti lineari; i piccoli fiori hanno calice ridotto a 5 dentelli, corolla a petali gialli e sono riuniti in ombrelle a 5-30 raggi, privi di involucro e involucretto; mericarpi a 5 coste salienti con le due marginali ± alate.
-Anethum foeniculum L. FINOCCHIO SELVATICO
H bienn (H scap) – S-Medit. - VI-VIII – Comune.
Erbacea aromatica spesso bienne, alta fino a 1-2 m, glabra e glauca, a fusto robusto, striato e ramificato; foglie 3-4 pennatosette a segmenti terminali filiformi e assai allungati; guaine fogliari allungate; i fiori gialli sono riuniti in ombrelle lungamente peduncolate di 10-30 raggi uguali fra loro; acheni con sapore di anice, lunghi ca. 4 mm.
Habitat: ambienti aridi anche coltivi e margini stradali mediterranei.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri 2018 (sub Foeniculum vulgare Mill.): Cantagallo e Vernio; nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2019) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Foeniculum vulgare var. capillaceum).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Foeniculum vulgare); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Foeniculum vulgare Mill.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Finocchio comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Foeniculum vulgare Mill.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Foeniculum vulgare); Biagioli & al. 2002 (sub Foeniculum vulgare Mill.): non su ofioliti.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Foeniculum vulgare Mill.) (C/S).
- Pianura: oss. Pinzani 2022 Wikiplantbase#Toscana (sub Foeniculum vulgare Mill.): presso autostrada di Prato zona le Badie.
NB: Si tratta del famoso finocchio selvatico usato in Toscana soprattutto per insaporire i “ballotti”, ma non solo…
-Anethum piperitum Ucria FINOCCHIO PIPERITO
H scap – Medit. - VI-VIII – Molto raro.
A. piperitum è pianta aromatica dal sapore particolarmente piccante (da cui il nome dal greco peperi). Ha fusto abbastanza gracile, ma può raggiungere e superare i 2 m di altezza; le foglie, da 3 a 4-pennate, presentano le ultime divisioni assai sottili e divaricate, le superiori hanno guaina corta e larga; i fiori gialli sono riuniti in ombrelle brevemente peduncolate a 4-10 raggi generalmente assai corti ed ineguali; il frutto è lungo circa 5 mm, di forma ovata e di sapore acre-piccante.
Habitat: ambienti erbosi, anche coltivi e margini stradali mediterranei.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Foeniculum vulgare subsp. vulgare); Gestri & Lazzeri 2021 (sub Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Bég.)
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021 (sub Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Bég.): incolto presso la Fattoria.
NB: i frutti sono utilizzati, come quelli della specie precedente, per aromatizzare liquori o alimenti; in molte regioni vengono utilizzati in cucina anche i giovani germogli.
Il genere Angelica
consta di più di 110 specie erbacee (per lo più robuste) con distribuzione olartica (2 in Italia). Le sue piante nella Famiglia si caratterizzano per le foglie composte con i segmenti terminali dentellati su tutto il margine e più larghi di 7 mm, i fiori a petali bianchi (rosei, o verdastri) raggruppati in ombrelle a più di 10 raggi (20-50 di uguale lunghezza) e ombrellette (con involucretto a più bratteole) assai ravvicinate, infine per le coste dell’achenio con le marginali più sviluppate delle dorsali, fino a divenire alate a maturità.
-Angelica sylvestris L. ANGELICA SELVATICA
H scap – Eurosiber. - VI-VII – Rarissima.
Erbacea perenne, glabrescente, a fusto eretto, robusto, ramificato in alto, spesso soffuso di violaceo e finemente puberulo sotto l’infiorescenza, alta fino a 2 m; foglie con picciolo cavo allargato in guaine rigonfie e inguainanti il fusto, 2-3 pennatosette, con le basali assai lunghe (fino a 60 cm) e larghe, le foglioline appaiono ovate e dentate; infiorescenza ad ombrelle assai grandi di 20-30 raggi e prive di involucro (involucretto con una decina di segmenti filiformi); fiorellini bianchi o rosei con sepali non dentati; frutto (ca. 3 mm) ovoide e con ali ondulate e violacee.
Habitat: boschi fresco-umidi, presso fossi e torrenti.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Angelica selvatica): AMPIL del Monteferrato.
Il genere Anthriscus
è costituito da una quindicina di specie erbacee, di cui 5 presenti in Italia; solo 2 sono state segnalate nel territorio provinciale pratese. Si caratterizza per: le foglie 2-3 pennatosette a segmenti ovali o lanceolati; i fiori bianchi a petali acuti e ricurvi, riuniti in ombrelle a 3-16 raggi di analoga lunghezza, senza involucro (o a 1-3 segmenti), con involucretto a 2-5 segmenti patenti o riflessi; il calice è privo di lembo e non persistente sul frutto; quest’ultimo si presenta più lungo che largo e assottigliato in alto; gli acheni sono lisci (senza solchi o coste, solo eventualmente verso l’apice).
NB: le piante appartenenti a questo genere somigliano assai a quelle del genere Chaerophyllum, dal quale si distinguono per avere gli acheni arrotondati e lisci sul dorso, privi cioè di solchi e coste, ed inoltre per i petali ad apice acuto e non bilobi.
?-Anthriscus caucalis M. Bieb. CERFOGLIO LAPPOLA
T scap – Paleotemp. - V-VII – Segnalato solo da Maugini 1946 al Bargo di P. a Caiano.
Pianta erbacea maleodorante, alta 20-60 cm, a radice a fittone e che si caratterizza per le ombrelle glabre, a 3-7 raggi, laterali (opposte alle foglie), sessili o quasi; inoltre per il frutto, ovato-acuto e coperto di piccole spine uncinate con un cerchio di peli in basso; l’involucro è nullo, l’involucretto a 4-5 segmenti lanceolati e patenti; le foglie sono 3-4 pennatosette e sparsamente pelose.
Habitat: ruderale e di ambienti incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Barco di P. a Caiano: segnalato da Maugini 1946 (sub Torilis anthriscus) e successivamente non ritrovato.
-Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. CERFOGLIO SELVATICO
H scap – Paleotemp. - VI-VII – Abbastanza raro sul nostro territorio.
Pianta con odore fetido che ricorda un po’ la carota, alta 50-120 cm, pelosa in basso; si caratterizza per le ombrelle tutte terminali, lungamente peduncolate, a 7-15 raggi di analoga lunghezza, con involucro nullo e involucretto a 5 segmenti evidenti, lanceolati e riflessi; il frutto, verde-brunastro, è liscio, oblungo-lineare, di ca. 7 mm e finemente scabro; foglie 3 pennatosette con picciolo lungo come il lembo o poco meno e segmenti subacuti; i fiori sono grandi con gli esterni raggianti.
Habitat: ruderale, presso orti, campi, prati falciati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 e Bettini & al. 2009: Cascina Le Barbe presso il ruscello; Arrigoni & al. 2005: Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo.
Il genere Bifora
è composto da 3 specie annuali erbacee, 2 presenti in Italia ed una americana. Si caratterizza per: i fiori bianchi con calice privo di lembo; le foglie 1-2 pennatosette a segmenti lineari, stretti meno di 2 mm; ombrelle a 2-7 raggi privi di involucro e involucretto (o con 1 segmento presto caduco); achenio ± sferico (non compresso) con frutto didimo, glabro, più largo che lungo (fino al doppio).
-Bifora radians Bieb. CORIANDOLO PUZZOLENTE
T scap – Asiatica (neofita?) – IV-VI – Compare periodicamente in alcuni campi coltivati.
Erbacea glabra, che emana un caratteristico odore sgradevole di cimice, a fusto eretto e solcato, alta 10-60 cm; le foglie inferiori sono 3 pennatosette e le superiori 2 pennatosette a segmenti sottili e lineari; i fiori bianchi (con i petali esterni più grandi) sono riuniti in ombrelle a 5-7 raggi, lunghi 2-3 cm, sono prive di involucro (o con un solo segmento) e con involucretto a 2-3 segmenti sottili, frutto caratteristicamente didimo.
Habitat: campi coltivati a cereali.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Sommier e Levier 1891, Baroni 1897-1908: Prato.
- Pianura: Gestri 2022: campi coltivati a Galcetello (Prato).
NB: questa pianta in alcuni anni fa la sua comparsa, anche con un discreto numero di individui, nei campi coltivati di Galcetello a Prato, mentre in altri anni manca completamente. Il cattivo odore che emana si diffonde anche nell’ambiente di crescita ed è assai caratteristico e riconoscibile anche a distanza.
Foto di M. Miglio de L'Aquila
?-Bifora testiculata (L.) Spreng. CORIANDOLO SELVATICO
T scap – Medit. - III-V – Rarissima, probabilmente scomparsa nel nostro territorio.
Erbacea di odore fetido, a fusto ramificato e alta 10-30 cm, che si diversifica da B. radinas per le ombrelle a 2-3 soli raggi, i petali dei fiori tutti pressoché uguali, i frutti con lo stilo lungo 0,2 mm (invece di 1-1,5 mm) e con un tubercolo arrotondato in alto.
Habitat: campi coltivati a cereali.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Sandri & Fantozzi 1895, (1908): in un campo...sotto Pietramarina” (Carmignano); ma non ritrovata in seguito (Gestri & Peruzzi 2013a).
Il genere Bunium
conta una cinquantina di specie erbacee a distribuzione paleotemperata (5 presenti in Italia). Le piante si presentano con radice rigonfia in forma di bulbo rotondeggiante, le foglie (2-3 pennatosette) basali emergono dal terreno ad una certa distanza dal fusto, i fiori, a calice nullo o subnullo e a petali smarginati bianchi, sono riuniti in ombrelle a 3-20 raggi con involucro mancante o a fogliolina intera e involucretto a più segmenti; mericarpi a 5 coste uguali e a faccia commessurale piana.
-Bunium bulbocastanum L. BULBOCASTANO COMUNE
G bulb – W-Europ. - IV-VII – Poco comune.
Pianta erbacea dotata di un tubero subgloboso (1-2,5 cm di diametro), a fusto eretto, gracile, finemente solcato, alta 20-90 cm, con poche foglie cauline sessili o quasi, bipennate e dotate di guaina, le superiori a lacinie lineari; le foglie basali sono 2-3 pennatosette a lungo picciolo inserito sul bulbo; fiori a petali bianchi di ca. 1 mm, inseriti su ombrelle a 8-20 raggi sottili, di ca. uguale lunghezza (2-2,5 cm), con involucro e involucretto a 6-10 segmenti lineari; il frutto oblungo-ovato è costituito da due mericarpi di 3-5 mm, coste filiformi, assottigliati in alto, neri a maturità ed aromatici.
Habitat: radure di bosco, campi, incolti, soprattutto su terreno calcareo (ma non solo).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890 e 1908 (sub Carum bulbocastanum Koch.): Poggio a Petto presso Montepiano; Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Val di Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: valle Limentra e Limentrella; nuovi ritrovamenti: Montepiano, prato di crinale verso la Scoperta (2020), prato all'Alpe di cavarzano (2024) (Vernio); Tabernacolo di Gavigno e sopra la Cascina di Spedaletto (2021) (Cantagallo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
NB: è pianta commestibile: il bulbo ha sapore che ricorda la castagna (da cui il nome), le foglie si possono utilizzare a mo’ di prezzemolo e gli acheni come il cumino.
Il genere Bupleurum
comprende un centinaio o più di specie nel mondo, diffuse soprattutto nelle zone temperate e fredde (più raramente tropicali). In Italia le specie segnalate sono una quindicina. Si tratta di erbacee (annuali o perenni) glabre, con foglie intere e a nervature parallele, le cauline si presentano sessili o abbraccianti; i piccoli fiori gialli, pentameri e attinomorfi, sono riuniti in ombrelle per lo più piccole, a 2-20 raggi, con involucro assente o formato da 1-8 segmenti, involucretto a segmenti multipli. Per la determinazione delle varie specie è fondamentale esaminare il frutto composto da 2 mericarpi a 5 coste longitudinali; i semi hanno le facce commessurali piane.
-Bupleurum baldense Turra BUPLEURO ODONTITE
T scap – Euro-Medit. - V-VIII – Relat. comune.
Erbacea annua a fusto gracile ed eretto (in alto con due sottilissime ali cartilaginee), a ramificazioni quasi dicotomiche, alta 10-30 (a volte fino a 60) cm; foglie basali sottili e spatolate (larghezza massima verso l’apice), le cauline inferiori con larghezza massima al centro; i minuscoli fiori gialli sono riuniti in piccole (ca. 1 cm) ombrelle dense a 2-5 raggi disuguali, con involucro a larghi segmenti ovato-laceolati, eretti e più lunghi dei raggi, e involucretto a segmenti lanceolati con 5 evidenti nervature ed aristati, pur essi eretti a nascondere i fiori e poi i frutti.
Habitat: prati aridi, schiarite boschive, macchie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sentiero CAI 58 da Gorandaccio a P. Mezzana, Montepiano, strada per Luciana (2021) (Vernio) e strada per Gavigno (2023) (Cantagallo); Schignano strada per Migliana (2023) (Vaiano).
- Calvana: Arrigoni e Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano
- Montalbano: Sandri & Fantozzi (1895) e (1908) (sub B. aristatum Bartl.): Montalbano sotto Pietramarina; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
?-Bupleurum lancifolium Hornem. BUPLEURO A FOGLIE LANCEOLATE
T scap – Medit.-Turan. - III-VI – Rarissimo, probabilmente scomparso.
Erbacea annua, alta da 10 a 50 cm, caratterizzata dalle foglie cauline ovali ed arrotondate ampiamente abbraccianti il fusto (più allungato - quasi a “punto di lancia” - che nel simile B. rotundifolium), dall’ombrella a 2-3 raggi, priva di involucro e dall’involucretto costituito da segmenti ovali e cuspidati, patenti anche dopo la fioritura; il frutto, tubercoloso-granuloso, è lungo 3,5-6 mm.
Habitat: terreni coltivati, ambienti aridi e caldi.
Distribuzione sul territorio:
- Colline di Montemurlo: zona ex-Campi solari (Montemurlo), ritrovata da N. Messina nel 2019.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: nei coltivi pedecollinari, non su serpentino.
-Bupleurum odontites L. BUPLEURO DI DESFONTAINES
T scap – SE-Medit. - V-VI – Rarissimo (trovato solo una volta).
Pianta alta 5-30 cm, simile a B. baldense dal quale si differenzia per i segmenti dell’involucretto (2 x 12-14 mm) mucronati, traslucidi con venature trasverse pennate e ripiegate verso l’apice.
Habitat: prati e incolti aridi.
Distribuzione sul territorio.
- Colline di Montemurlo: segnalato una sola volta da Antonino Messina, trovato a ca. 320 m nel giugno del 2020 (chi volesse osservarne le foto, consulti il forum Acta plantarum su internet).
?-Bupleurum subovatum Link ex Spreng. BUPLEURO SEMIOVATO
T scap – Cosmop. - IV-VI – Probabilmente scomparso (o confuso con B. lancifolium molto simile!).
Erbacea molto simile a B. lanciflolium, distinto solamente per le dimensioni del frutto 2-2,5 x 3,2-5 mm (invece di 1,5-1,7 x 2,2-3,5 mm) e dello stilopodio 1,2-1,5 (in lancifolium più breve!); da B. rotundifolium si distingue per l’ovario e il frutto tubercolato.
Habitat: zone erbose, campi e radure.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub B. protractum Hoff. & Link): fra Montelupo e Verghereto (Somm. herb.) (Carmignano); non ritrovato nelle erborizzazioni successive (Gestri & Peruzzi 2013a).
?-Bupleurum rotundifolium L. BUPLEURO PERFOLIATO
T scap – archeofita di origine asiatica – IV-VI – Rarissimo, forse scomparso dal nostro territorio.
Erbacea glabra, annuale, a fusto eretto che si ramifica in alto, alta 20-50 cm; è caratterizzato dalle ampie foglie, a nervature raggianti, che abbracciano completamente il fusto, di forma largamente ellittica, e terminanti in un piccolo mucrone; hanno ombrelle a 4-8 brevi raggi, prive di involucro, ma con involucretto formato da 5-6 segmenti eretti, largamente ellittici e mucronati che superano le ombrellette; queste sono formate da piccoli fiori giallastri e quindi da frutti oblunghi (ca. 3 mm) a coste assai evidenti. Si differenzia da B. longifolium e subovatum soprattutto per avere ovario e frutto lisci (non tubercolati).
Habitat: campi di cereali soprattutto su terreno calcareo in ambiente submediterraneo.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Bupleuro perfoliato): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub B. r. L. var. tipicum Wollf.) e Biagioli & al. 2002: nei coltivi pedecollinari, non su serpentino.
-Bupleurum tenuissimum L. BUPLEURO A GRAPPOLO (75)
T scap – Euro-Medit.- VII-X – Non raro.
Erbacea alta 10-40 cm, a fusto molto esile e di dimensioni contenute in ogni sua parte. Ha foglie intere, semplici, lineari-acuminate a tre nervature; i fiori sono gialli e riuniti in piccole ombrelle a (1) 2-4 raggi (brevi e ineguali) terminali o ascellari fin quasi alla base del caule; l'involucro è costituito da 1-4 segmenti ineguali, involucretto a 3-5 lineari-acuminati; i frutti lunghi circa 2 mm (con peduncolo di 1-2) sono subglobosi, papillosi, a coste salienti un po' ondulate.
Habitat: luoghi incolti e aridi, radure boschive e di macchia.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Migliana verso le Cavallaie (2022) (Cantagallo); a N di Montecuccoli (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub B. semicompositum L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la Fattoria di Javello (2021), sentiero dalla Fattoria di Javello alle Cavallaie (2012).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (herb. Levier) (sub B. t. L. subsp. eustenuissimum Wollf. var. genuinum Wollf. f. longibracteatum Wollf.); non ritrovato in Biagioli & al. 2002, ma (nuovi ritrovamenti) riconfermata la presenza da chi scrive nel 2021.
- Monte Le Coste e Poggio Le Croci: GP13 (C/S).
NB: per il suo aspetto esile e contenuto è difficile talvolta individuarlo fra le altre erbe; inoltre il periodo di fioritura, a estate inoltrata, lo fanno ritenere talvolta più raro di quanto non lo sia nella realtà.
Il genere Cervaria
consta di 3 specie a distribuzione euro-asiatica (1 in Italia). Le sue piante, per lo più glauche e molto simili a Peucedanum (vedi), si caratterizzano per i segmenti primari delle foglie [2-(3) pennatosette] larghi almeno 1 cm e lunghi fino a 2, inoltre gli ultimi hanno contorno dentato-spinuloso; l’involucro è costituito da 4-10 foglioline.
-Cervaria rivini Gaertn. IMPERATORIA CERVARIA
H scap – Eurosiber. - VII-IX – Abbastanza comune.
Erbacea perenne, glabra, a fusto robusto, eretto e striato, alta da 30 cm a più di 1 m; grandi foglie basali 2-3 pennatosette, picciolate e a foglioline da ovate a lanceolate, acutamente dentellate e spinescenti; le superiori via via più piccole fino a presentare solo la guaina; fiori a 5 petali bianchi o rosati, riuniti in ombrelle a 15-30 raggi con involucro e involucretto dotati di segmenti riflessi lanceolati e a bordi membranacei; lo stilo supera in lunghezza lo stilopodio; frutto ellittico, lungo sui 5 mm un po’ compresso e brevemente alato.
Habitat: zone boschive, macchie, arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: a E di Cascina di Spedaletto (2019) (Cantagallo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.); Gestri 2009 (sub Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Cervaria): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Peucedanum cervaria); Messeri 1936 (sub Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.); Biagioli & al. 2002 (sub Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.):frequente anche sulle ofioliti.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: argine Bardena a Maliseti (2022) (Prato).
Il genere Chaerophyllum
è costituito da ca. 35 specie erbacee perenni o bienni, presenti in Europa, Asia, N America e N Africa (9 in Italia). Le entità di queste genere hanno foglie ± vellutate ed eleganti (il nome deriva dal greco: chairon = elegante e phyllon = foglia) 2-3 pennatosette; i fiori a petali (in alcune specie ciliati) bianchi o rosei sono riuniti in ombrelle a 5-20 raggi con involucro assente o di 2-3 segmenti e involucretto a 5-8 segmenti lanceolati e riflessi; il frutto, scuro, glabro e liscio, ha forma allungata (4-15 mm) con mericarpi a 5 coste evidenti per tutta la lunghezza.
-Chaerophyllum aureum L. CERFOGLIO DORATO
H scap – Orofil. N-Medit. - V-VII – Non raro sull’Appennino principale (assente altrove).
Erbacea ± vellutata, a fusto eretto, angoloso e ramificato, alta da 40 a 120 cm; foglie a contorno triangolare, le inferiori 3 pennatopartite a segmenti terminali dentellati; i fiori - a petali bianchi privi di tomento e con gli stami riflessi e più lunghi dello stilopodio non marginato - sono riuniti in ombrelle a 10-15 raggi, prive di involucro e con involucretto formato da 6-7 segmenti allungati, riflessi, aristati, a margine membranoso e ciliati; frutto lungo da 8 a 12 mm e di colore giallastro.
Habitat: boschi e zone prative montane.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890: verso P. di Petto; Levier & Sommier 1891, Baroni 1897-1908: verso l’Alpe di Cavarzano sopra Montepiano; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Montepiano, subito prima del paese a dx della strada, monte della Scoperta (2018), sopra Badia, Fossato, strada da Montepiano a Gasperone e oltre fino all’Alpe (2019) (Vernio); Tabernacolo di Gavigno (2018) Cantagallo.
-Chaerophyllum hirsutum L. CERFOGLIO IRSUTO
H scap – Orofila CS-Europ.-Caucas. - V-VIII – Assai raro e presente solo sull’Appennino principale.
Erbacea alta 30-70 cm a fusto eretto con peli sparsi; foglie pelose sulle venature, le inferiori a contorno triangolare, 2-3 pennatosette, con picciolo lungo come la lamina; fiori bianchi (raramente rosei) a petali ciliati al margine e riuniti in ombrelle di 10-20 raggi prive di involucro (raramente 1-2 segmenti) e con involucretto a segmenti sottili, pelosi e riflessi; frutto di 4-20 mm, affusolato (larghezza massima nella metà inferiore) e con coste evidenti; stilopodi in forma di cono che si prolungano negli stili eretti e divergenti ad angolo acuto, ambedue di colore biancastro.
Habitat: boschi, macchie e radure umide in montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890 e Baroni 1897-1908: (sub C. calabricum Guss.) negli acquitrini presso l'Alpe di Cavarzano (Somm.herb.) (Vernio); Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: CAI 20 sopra Le Soda (2021) (Vernio).
-Chaerophyllum temulum L. CERFOGLIO INEBRIANTE
T scap/H bienn – Eurasiat. - V-VII – Comune.
Pianta bienne o annua, alta 30-100 cm; fusto robusto, striato e rigonfio sotto i nodi; le foglie sono bipennatosette e mucronate; i piccoli fiorellini bianchi (o rosei) sono riuniti in ombrelle a 6-12 raggi ineguali; manca l'involucro, mentre l'involucretto è costituito da 5-8 segmenti ribattuti verso il basso; il frutto è liscio, lineare e lungo ca. 6-7 mm, con stilopodi ripiegati in basso e in fuori a maturità.
Habitat: boschi, macchie, incolti, anche in ambienti fortemente antropizzati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: nell’Alpe di Caverzano a Montepiano (Car. herb. !); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Fabbro (Vaiano) a Migliana, da Migliana alle Cavallaie, Acquiputoli (2018) (Cantagallo), sentiero CAI 16 versante S.Ippolito, sopra il Lago Verde (2019), sent. CAI 58 da Montepiano al Gorandaccio, da Montepiano a Gasperone, da Montepiano a Badia (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: estesi popolamenti nel bosco dei Patriarchi (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: è specie tossica, la sua ingestione provoca sintomi simili a quelli prodotti da una forte ubriacatura: da qui il nome volgare di Cerfoglio inebriante.
Il genere Conium
conta 6 specie distribuite in Europa, Asia e Africa (1 soltanto in Italia). Si tratta di piante erbacee bienni o perenni, a fusto eretto, rigido e cavo, spesso più alto di 80 cm e ramificato, foglie divise, fiori in infiorescenze a ombrella e ombrellule (involucretto ben sviluppato), frutto senza ali, più largo che lungo.
-Conium maculatum L. CICUTA DI SOCRATE
H scap (bienn) – Paleotemp. - VI-IX – Abbastanza rara.
Si distingue dalle altre Apiaceae simili per avere il fusto cavo e maculato di bruno-porpora; inoltre per l’odore fetido che emana. E' pianta bienne, alta anche più di 1 m; le foglie basali sono assai grandi e più volte divise; i fiori bianchi sono riuniti in ombrelle a 10-20 raggi ineguali; l'involucro è costituito da 3-5 segmenti brevi e riflessi, l'involucretto da 3-6 segmenti lanceolati, pure riflessi, spesso allargati e un po’ saldati alla base; il frutto, subgloboso, è piccolo, glabro e compresso.
Habitat: presso corsi d’acqua, zone incolte, anche ruderali, fresco-umide e ricche di materiale organico.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: confluenza delle Limentre.
- Calvana: Gestri 2009 e GL16: Cantagallo, Vaiano (spesso lungo torrenti ombrosi).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline sopra Figline: nuovi ritrovamenti: margine della strada per la Collina, sopra il laghetto di Cerreto (Prato).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zona delle Ville di Bagnolo (Montemurlo).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Poggio a Caiano sulle sponde dell’Ombrone (2018).
NB: si tratta della pianta con cui fu “giustiziato” il famoso filosofo greco Socrate (sembra però che nella mistura che gli fu propinata, oltre alla cicuta, ci fossero altre piante velenose). La vicenda è narrata da Platone, suo allievo, nel ”Fedone”, in cui vengono descritti con discreta precisione, i sintomi provocati dall’avvelenamento fino alla morte.
Il genere Daucus
è costituito erbe annuali, bienni o perenni (raramente arbustive) di cui si conoscono una settantacinquina di specie diffuse in tutto il mondo e di cui fa parte anche la carota coltivata (in Italia 9 specie ed alcune sottospecie). Le foglie si presentano più volte divise in segmenti lanceolati e prive di stipole, i fiori piccoli (gli esterni generalmente maggiori) sono pentameri e ermafroditi o unisessuali e riuniti in ombrelle composte da 8-40 raggi eretto-patenti con involucro di molti segmenti pennatosetti e involucretto a segmenti interi o trifidi; il frutto è un diachenio ovato o ellittico con mericarpi a 9 coste e provvisti di spinule.
-Daucus broteroi Ten. CAROTA DI BROTERO (botanico portoghese vissuto fra il XVIII° e il XIX° sec.)
T scap – Endemismo italiano – IV-VI – Rarissimo.
Erbacea alta da 10 a 50 cm, a fusto assai ramificato e caratterizzata da: segmenti delle foglie inferiori larghi meno di 1 mm (0,3-0,7), ombrelle contratte (a raggi brevi ca. della stessa lunghezza) e frutto con spinule più lunghe della larghezza dell’achenio.
Habitat: incolti aridi e assolati ed anche in aree coltivate.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano di P. a Caiano: Caruel 1860-64 (sub D. michelii Car.): fra Signa e P. a Caiano, “dove trovasi di frequente dopo le messi” ; Baroni 1897-1908 (sub D. michelii Car.): fra Montelupo e Verghereto (Somm. herb.); Gestri & Peruzzi 2013a: Poggetto di P. a Caiano.
-Daucus carota subsps. carota L. CAROTA SELVATICA
H bienn (T scap) – Paleotemp. - Comunissima un po’ ovunque nel nostro territorio.
Pianta aromatica bienne, alta 30-80 cm, a foglie bipennatosette con segmenti larghi almeno 1 mm, fiori bianchi o rosei (il centrale è quasi sempre porporino), riuniti in ombrelle a 20-40 raggi; l’involucro è formato da 7-10 segmenti sottili con 2 lacinie laterali, l'involucretto è costituito da segmenti lineari interi o trifidi; il frutto è ellittico e dotato di aculei lunghi quanto la larghezza del frutto stesso. A maturità l'infruttescenza si richiude e assume forma ovata.
Habitat: incolti, campi, zone marginali e ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano (Caruel. herb.); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2021) (Vernio).
- Bargo di P. a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub D.c. L. subsp. catota): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Carota selvatica): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Biagioli & al. 2002.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: PG13b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: via Brugnani loc. Bocca Vittoria (2023) (Prato).
NB: sembra che questa pianta sia la progenitrice della carota coltivata. E’ specie commestibile e dotata di proprietà fitoterapiche (diuretica, decongestionante ecc.).
PS: di questa specie si conoscono molte altre sottospecie non differenziate sul nostro territorio!
Il genere Eryngium
consta di circa 250 specie (14 in Italia) a distribuzione subcosmopolita. Le sue piante si caratterizzano all’interno della Famiglia per i fiori (sessili, bianchi o bluastri, a petali conniventi) non disposti in ombrella composta, ma in pseudocapolini contratti su un ricettacolo con pagliette e con involucro spinoso e a volte tinto di blu; inoltre le foglie sono coriacee e dotate di spine, i fusti sono fogliosi e il frutto è obovoide e scaglioso.
-Eryngium campestre L. CALCATREPPOLA DI CAMPO
H scap – Euro-Medit. - VI-IX – Non rara soprattutto in alcuni territori (preferisce i suoli calcarei).
Erbacea glabra e con fusto assai ramificato, alta 10-40 cm; foglie basali coriacee, picciolate, con lamina a contorno triangolare e divise in segmenti dotati di spine; le cauline sono ridotte ed amplessicauli; i fiori giallo- o bianco-verdastri, hanno calice a 5 segmenti spinescenti in alto e petali conniventi, sono riuniti in densi capolini arrotondati di 1-1,5 cm e peduncolati; l’involucro biancastro è formato da 4-6 segmenti lineari (interi o dentati), patenti, lunghi 1,5-4,5 cm; frutto ovato e dotato di scaglie acuminate.
Habitat: incolti aridi, prati-pascolo, zone rocciose (soprattutto su calcare).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Foggi & Venturi 2009: praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; Bettini & al. 2014; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi e M. Buriano (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la Quercia dei Termini (2020).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Calcatreppola): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: anche su ofioliti, ma soprattutto aree pedecollinari: laghetto di Galceti, ex-cava di Gello (Prato), Pineta di Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: sotto questa pianta (in realtà anche sotto altre Apiaceae) si può trovare, anche da noi, il pregiatissimo fungo che da essa prende il nome: Pleurotus eryngii (DC.) Quél.
Il genere Ferula
conta circa 180 specie distribuite in Asia e in ambito mediterraneo (7 in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni, aromatiche a radice a fittone, fusto eretto e robusto a ramificazioni alterne, opposte o verticillate; le foglie sono grandi, con guaina basale e più volte divise in segmenti spesso lineari (le cauline inferiori alle basali); fiori a sepali piccolissimi o assenti e petali gialli o giallo-verdastri, riuniti in ombrelle composte, con involucro e involucretto per lo più assenti; frutto ovato e compresso con costole prominenti.
-Ferula communis L. subsp. communis FERULA COMUNE
H scap – S.Euro-Medit. - V-VI – Rarissima.
Erbacea robusta, glabra, a fusto eretto striato e a ramificazioni verticillate o opposte, alta da 1 a 3 m; grandi foglie verde-chiare, più volte divise in segmenti lineari, le inferiori picciolate e lunghe 30-60 cm, le cauline dotate di grossa guaina membranacea; fiori piccoli a petali gialli, inferiori al mm, riuniti in grandi ombrelle (fino a 40 raggi) composte prive di involucro e involucretto, quella centrale grande è superata dalle laterali lungamente picciolate; frutto compresso, ovato o ellittico, lungo ca. 1,5 cm.
Habitat: incolti caldi e assolati, pascoli, garighe, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Gestri in Peruzzi & al. 2024: presso la cima del Monte Chiesino vers. SE (Prato).
- Pianura: tre oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: 1 Autostrada A11, alcuni km prima dell'uscita Prato Est e 2 nei pressi dell'uscita Prato Ovest (Prato), su scarpata autostradale.
Il genere Ferulago
conta circa 180 specie distribuite in Asia ed in area mediterranea (3 in Italia). Si tratta di piante erbacee generalmente perenni e glabre, a fusti robusti con guaine larghe (1) 2 cm, a foglie verde-chiare, divise in lacinie sottili; fiori a petali gialli riuniti in ombrelle di 5-40 raggi (i laterali più brevi dei centrali) con involucro assente o di 1 brattea caduca e involucretto spesso nullo; frutti ovati, compressi, glabri e alati ai margini.
-Ferulago galbanifera (Mill.) W.D.J.Koch (Ferulago campestris (Bresser) Grecescu) FERULA CAMPESTRE
H scap – SE-Europ.-Pontica – VI-VIII – Poco diffusa, ma non rara.
Erbacea alta da 30 cm a più di 1 m, a fusto eretto, glabro, striato e a rami quasi verticillati in alto; foglie 3-4 volte divise in segmenti sottili-filiformi, le inferiori picciolate, le superiori (minori) inserite sul fusto direttamente tramite una breve guaina; i piccoli fiori a petali gialli e revoluti sono riuniti in ombrelle (le centrali un po’ inferiori alle laterali) costituite da 5-12 raggi, con involucro a numerosi segmenti riflessi e lanceolati e involucretto a segmenti patenti, pure lanceolati; i frutti si presentano compressi, a 5 coste e oblunghi (1-2 cm ca), con stili patenti lunghi ca. come lo stilopodio.
Habitat: zone aperte e assolate di collina o bassa montagna (da noi su serpentino e calcare).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Ferulago campestris (Bresser) Grecescu): Vaiano (prati rocciosi e cespuglieti radi).
- Monteferrato: Caruel 1860-64 (sub Ferula ferulago L.), Fiori 1914 (sub Ferula ferulago), Messeri 1936 (sub Ferula ferulago L. var. typica Fiori), Biagioli & al. 1999 (sub Finocchiazzo), Biagioli & al. 2002 (sub Ferulago campestris (Bresser) Grec.).
Il genere Helosciadium
è costituito da 5-6 specie a distribuzione paleotemperata (3 presenti in Italia più una dubbia). Si tratta di piante erbacee perenni e acquatiche, a fusti glabri, prostrati e radicanti, foglie cauline aeree 1 pennatosette con segmenti più lunghi che larghi, fiori a petali bianchi o rosei, riuniti in ombrelle a raggi lunghi come o più dei peduncoli corrispettivi e segmenti dell’involucretto sempre presenti.
-Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch SEDANO D’ACQUA
H scap/I rad – Euro-Medit. - IV-VII – Comune nei corsi d’acqua e fossi.
Erbacea acquatica glabra, prostrata-ascendente, a fusto robusto, radicante in basso sui nodi, cavo, striato e ramoso, lungo 30-100 cm; foglie, più lunghe delle ombrelle e ad esse opposte; si presentano imparipennate a 5-13 segmenti ovato-lanceolati e dentellati; i piccoli fiori sono bianco-verdastri e riuniti in ombrelle, sessili o peduncolate, a 4-12 raggi, prive di involucro (o 1-2 segmenti rapidamente caduchi) e con involucretto a 5-7 segmenti lanceolati, biancastri sul bordo; frutto ovoide, compresso, con mericarpo a 5 coste e glabro.
Habitat: corsi d’acqua, fossi, zone con ristagno d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Usella verso il Santo (2022) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: strada bianca da Fornacette verso Fattoria Javello (2018) Montemurlo).
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908: Prato (Somm.herb.); Biagioli & al. 1999 (sub Sedanina d’acqua); Foggi & Venturi 2009 (sub Apium nodiflorum): zone umide in provincia di Prato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Apium nodiforum (L.) Lagasca): fossetti di sgrondo...anche in area ofiolitica.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: torrente Vainella (Prato) (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: letto del Bardena da Galcetello a Maliseti (2019), alveo del Bisenzio lungo V. Galilei (2024) (Prato).
Il genere Heracleum
è costituito da circa 130 specie a distribuzione olartica e orofila Africana (in Italia 6 specie ed alcune sottospecie). Le sue piante si caratterizzano per le loro dimensioni e robustezza (il nome del genere deriva appunto dal greco Heracleion = Ercole), sono specie erbacee perenni (o bienni) senza spine, con grandi foglie pennato-lobate o pennatosette a 3-9 segmenti, le cauline inferiori; i fiori - a petali bianchi, rosati o giallastri, ± smarginati con gli esterni bilobi e raggianti – sono riuniti in ombrelle di 3-40 raggi con involucro nullo o presto caduco e involucretto a più segmenti; frutto a 2 mericarpi compressi, di forma ovale e con 2 ali marginali traslucide.
-Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium PANACE COMUNE
H scap – Paleotemp. - V-VIII – Rarissimo e localizzato.
Erbacea aromatica, robusta, alta da 50 a 200 e più cm, eretta a fusto cavo e scanalato; foglie pure di grandi dimensioni (lunghe fino a 60 cm), 1-3-pennate a 3-5 segmenti dentati-crenati e con picciolo inguainante in quelle inferiori; fiori bianchi o rosati, a petali esterni maggiori, riuniti in grandi ombrelle (fino a 20 cm di diametro) a 10-30 raggi, generalmente privi di involucro e con involucretto a segmenti ciliati; frutti compressi, glabri da ellittici a tondeggianti.
Habitat: prati e boschi umidi in ambienti freschi (non in area mediterranea).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Caruel 1860-64: “M. Piano nel principio della Valle del Bisenzio (Bert.)”; Venturi 2006: alla confluenza delle Limentre.
Il genere Katapsuxis è monospecifico e si caratterizza per le foglie a divisioni terminali non sottilissime (non inferiori a 2 mm), i fiori a petali bianchi, uguali fra loro e riuniti in ombrelle a 20-45 raggi con evidente involucretto; frutto ovato, senza persistenza del calice e privo di ali e di coste rilevate.
-Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Reduron, Charpin & Pimenov CARVIFOGLIO DEI BOSCHI
H scap – SE-Europ. – V-VIII – Rarissima.
Erbacea perenne a fusto eretto, scanalato e ramoso, alta da 40 a 120 cm; le foglie 2-4 pennatosette a margine triangolare-allungato, con segmenti terminali da oblunghi a lanceolato-lineari, le superiori più piccole; i fiori, a petali bianchi di 1 mm, sono riuniti in ombrelle di 20-45 raggi sottili, prive per lo più di involucro (o a pochi segmenti caduchi) e involucretto a segmenti lisci sul bordo; frutto di ca. 4 mm, ovato e con mericarpi a 5 coste non rilevate.
Habitat: boscaglie rade, radure boschive, rupi, cespuglieti (ambienti xerofili).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Lazzeri & al. 2018: radura di faggeta al Monte della Scoperta versante SE (Vernio); nuovi ritrovamenti: su pendio roccioso a E di Luciana, Loc. Fornace d'Argeo a ca. 550 m slm (2024) (Vernio).
Il genere Myrrhis
è monospecifico, caratterizzato dai petali glabri e bilobati, dai frutti assai più lunghi (1,5-2,5 cm) che larghi, senza persistenza del calice e che diviene da verde nerastro a maturità, dagli acheni glabri con rilevate coste dorsali.
-Myrrhis odorata (L.) Scop. MIRRIDE DELLE ALPI
H scap - Orofila SE-Europ. - VI-VII - Molto rara.
Erbacea pubescente e aromatica (anice) a fusto eretto e assai ramificato, alta 50-120 cm; ha grandi foglie a contorno triangolare, poco consistenti e più volte divise a segmenti pennatifidi, le basali fino a 4-pennatosette e lunghe fino a 40 cm; i fiori, a petali bilobi e bianchi, sono riuniti in infiorescenza a ombrella a 6-15 raggi (alcuni di questi spesso collocati un po' più in basso), privi di involucro; involucretto a 5-8 segmenti lanceolati, membranosi e ciliati; i frutti oblunghi, larghi ca. 5 mm e lunghi 20-30, si presentano fortemente carenati longitudinalmente e divengono nero-lucidi a maturità.
Habitat: praterie e radure di montagna.
Distribuzione sul territorio:
Nuova segnalazione in corso di pubblicazione sugli Atti della Società Toscana di Scienze naturali di Pisa sulla rubrica “Contributi per una flora vascolare di Toscana” per il 2025.
Il genere Oenanthe
è costituito da specie erbacee, spesso velenose, annuali o perenni, in generale vegetanti in ambienti umidi; le radici mostrano la presenza di tubercoli, le foglie inferiori sono 2-3 volte divise, con segmenti lineari o ovati; i fiori - piccoli e bianchi (a volte rosei), con calice persistente e con denti lesiniformi - sono riuniti in infiorescenze a ombrello di 2-30 raggi, con involucretto a più segmenti e involucro nullo o a più segmenti; i frutti sono ovoidi e non compressi, con stilopodio a stili per lo più disposti a “V”.
ex-Oenanthe aquatica (L.) Poir. FINOCCHIO ACQUATICO
H scap – Eurasiat. - V-VI – Molto probabilmente scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea perenne, a grosso fusto eretto, alta 50-150 cm e caratterizzata dalle radici fibrose, dalle foglie inferiori spesso sommerse e a divisioni capillari; dalle ombrelle (cortamente) peduncolate ed opposte alle foglie del caule, con 5-10 raggi, prive di involucro e involucretto e a segmenti lanceolati non riflessi, dai fiori bianchi e dal frutto oblungo a stilo breve.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967: presente nelle risaie allora impiantate a scopo sperimentale nel Fondaccio a partire dal 1954; la pianta non è stata ritrovata nell’indagine di Gestri & Lazzeri 2021.
ex-Oenanthe fistulosa L. FINOCCHIO ACQUATICO TUBULOSO
H scap – Eurasiat. - V-VII – Molto probabilmente scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea perenne e stolonifera, a fusto cavo, eretto, spesso ingrossato ai nodi e poco ramificato, alta 20-80 cm; foglie 1-2 pennate con le ultime divisioni delle superiori sottili-lineari e a picciolo fistoloso; fiori bianchi (o rosati) riuniti in ombrelle a 2-4 raggi brevi e spessi, prive di involucro, e che assumono aspetto globoso alla fruttificazione; frutti cilindrici a stilo allungato.
Habitat: paludi, fossi e prati acquitrinosi.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Messeri 1936: presente in herb. Levrier, ma da lei e nelle ricerche successive non ritrovata.
- Poggio a Caiano: Parlatore 1889 e Baroni 1897-1908 (Barl. in Parl.).
??-Oenanthe peucedanifolia Pollich FINOCCHIO ACQUATICO NAPOLINO
H scap – Medit.-Atl. - V-VI – Probabilmente scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea alta 20-70 cm, a radici con tuberi ovato-oblunghi spesso addensati alla base del fusto, che è gracile, eretto e striato; è caratterizzata da: foglie bipennatosette, tutte simili fra loro, con segmenti terminali sottili e allungati; fiori bianchi, lunghi 2-3 mm (gli esterni raggianti), riuniti in piccole ombrelle a 5-10 raggi sottili, ad involucro assente (o a 1-3 segmenti) e involucretto lasso, a segmenti lunghi la metà del peduncolo; frutto fusiforme.
Habitat: prati umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: lungo fossetti di sgrondo. Non osservata recentemente.
- Poggio a Caiano: Caruel 1860-64.
-Oenanthe pimpinelloides L. FINOCCHIO ACQUATICO COMUNE
H scap – Medit.-Atlant. - V-VII – Comune in zone fresco-umide.
Erbacea a fusto eretto, fortemente solcato, alta 30-70 cm; essa è caratterizzata da: le foglie basali (bipennate a segmenti ovali) diverse da quelle superiori (pennatosette a segmenti lineari), i fiori bianco- giallastri, riuniti in ombrelle a 7-12 raggi (ispessiti alla fruttificazione), con involucro a 1-2 segmenti caduchi, involucretto a ombrellule fortemente ravvicinate alla fruttificazione e dai tuberi radicali ovoidi inseriti lontano dal fusto; il frutto è cilindrico con stilo abbastanza breve.
Habitat: prati, fossati, incolti fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Arrigoni & al. 2002: Fonte Acerelli (riserva naturale Acquerino-Cantagallo); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: zona di Migliana (2019) (Cantagallo); da Montepiano verso il Gasperone (2018), sopra il Gorandaccio verso Montepiano (2023) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartoloni 1997; Gestri 2009 e GP2016: Prato. Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra il paese presso un fossetto (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Finocchio acquatico comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Caruel 1860-64: M. Ferrato di Prato (Bart.); Fiori 1914; Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: presso il laghetto di Galceti ed altre zone umide (Prato, Montemurlo); Ricceri 2010.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Oenanthe silaifolia M. Bieb. FINOCCHIO ACQUATICO A FOGLIE STRETTE
H scap – Medit.-Atlant. - VI-VII – Molto rara.
Erbacea glabra a fusto eretto e cavo nella parte superiore, alta 40-80 cm; si caratterizza per le foglie superiori e inferiori simili (a base cuneiforme, che si restringono gradatamente divenendo assai sottili) e per i tuberi allungati e prossimi alla base del fusto; inoltre i fiori bianchi sono riuniti in ombrelle in numero di 30-50 in 5-10 raggi, con involucro assente e involucretto a numerosi segmenti lanceolati e patenti; frutto di 3-4 mm con stilo di analoga lunghezza.
Habitat: prati erbosi fresco-umidi, fossi, acquitrini.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Poggio a Caiano: Caruel 1888: presso Firenze a Poggio a Caiano; Gestri & Peruzzi 2013a: al Poggetto.
Il genere Opopanax
è costituito da 3 (4) specie erbacee a distribuzione S-Europea e W-Asiatica (2 in Italia). Si caratterizza per le piante a fusto peloso in basso, foglie 2-4 pennatosette, ramificazioni superiori subopposte o subverticillate, fiori a petali gialli riuniti in ombrelle a raggi di uguale lunghezza e frutti costituito da 2 mericarpi appiattiti, con stilopodio conico.
-Opopanax chironium (L.) W.D.J.Koch OPOPONACE COMUNE
H scap – Medit. - V-VIII – Localizzato.
Erbacea robusta, alta da 60 cm a più di 2 m, a grossa radice giallastra e fusto eretto a ramificazioni subopposte o subverticillate; foglie grandi, le inferiori a contorno triangolare, pennate o bipennate con segmenti terminali ovati e dentellati, le superiori semplici o ridotte alla guaina; fiori giallo-verdastri riuniti in ombrelle a 5-20 raggi gracili e glabri, con la presenza di involucro e involucretto a più segmenti lanceolati; frutto lungo ca. 6-7 mm, ellittico a mericarpi a 5 coste e alati.
Habitat: ambienti rocciosi e pascoli o radure aride.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub Pastinaca opopanax); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub Pastinaca opopanax L.), ma non ritrovato da Gestri & Lazzeri 2021.
Il genere Oreoselinum
è monospecifico.
?-Oreoselinum nigrum Delarbre IMPERATORIA APIO-MONTANA
H scap – Europ.-Caucas. - VI-VIII – Assai rara.
Erbacea glabra, con odore di prezzemolo, a fusto eretto e striato, in basso avvolto dai resti fibrosi delle foglie, alta da 40 a 100 cm; foglie inferiori 2-3 pennatosette, a contorno triangolare, picciolate con guaina e segmenti terminali trifidi con piccolo mucrone; fiori bianchi riuniti in ombrelle di 10-30 raggi, con involucro e involucretto di segmenti allungati e riflessi; frutto suborbicolare, lungo 4-5 mm e brevemente alato. Si distingue dall’affine Petroselinum austriacum (Jacq.) Rchb. oltre che per la presenza delle fibre alla base del fusto, per la larghezza dei segmenti fogliari terminali (2-3 invece di 0,5-1,2 mm) e la lunghezza della parte indivisa (5-8 invece di 10-12 mm).
Habitat: radure boschive e prati aridi (xerofilo).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005 (sub Peucedanum oreoselinum (L.) Meonch.): riserva naturale Acquerino-Cantagallo.
Il genere Orlaya
è costituito da 3 specie a distribuzione europea (presenti anche in Italia); sono erbacee annuali a fusti ramificati dal basso, foglie 2-3 pennatosette a segmenti brevi; i fiori, bianchi o rosei, sono riuniti in ombrelle opposte alle foglie, a 2-5 raggi con presenza di involucro e involucretto; frutti con mericarpi a 9 coste, dotate di aculei.
-Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. LAPPOLA BIANCA
Oggi viene inclusa in questa specie anche Orlaya daucoides (L.) Greuter.
T scap – C-Europ.-Pont. - V-VIII – Relativamente comune soprattutto su calcare.
Erbacea annuale a fusto eretto, alta 20-60 cm; foglie 3 pennatosette a segmenti terminali sottili e allungati, picciolate, le superiori sessili o ridotte alla sola guaina; i fiori, a petali bianchi, quelli circonferenziali (vessillari) bilobi e assai più lunghi e larghi degli altri (anche 7-8 volte), sono riuniti in ombrelle di 5-10 raggi ca. uguali, con involucro di 5-8 segmenti acuminati con bordo membranoso biancastro, più piccoli ma simili anche i segmenti dell’involucretto; frutto ovoide di ca. 8 mm con aculei uncinati e biancastri di 3 mm.
Habitat: incolti e zone erbose soprattutto su calcare e terreni argillosi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni e Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub O. daucoides (L.) Greuter per la maggior parte e O. grandiflora (L.) Hoffm.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Orlaya platycarpos W.D.J.Koch LAPPOLA MINORE
T scap – Medit. - V-VI – Rara.
Erbacea alta 10-30 cm e irsuta almeno in basso; foglie inferiori 2-3 pennatosette a segmenti terminali oblunghi; fiori bianchi (rosati) con petali della circonferenza più lunghi degli altri, ma solo 2-3 volte; sono riuniti in ombrelle di 2-3 (4) raggi, con involucro a 2-3 segmenti lanceolati e bordati di bianco, involucretto a segmenti ovati; frutto (1-1,5 cm) ad aculei arrossati e allargati alla base.
Habitat: incolti e coltivi.
Distribuzione sul territorio:
Calvana: Gestri 2009 (sub Caucalis platycarpos L.); Gestri & Peruzzi 2016 (sub O. daucoides (L.) Greuter in parte): Prato, Vaiano, Cantagallo.
Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: presso il sepolcro di C. Malaparte e presso la Paleosa.
Il genere Pastinaca
conta una quindicina di specie erbacee che popolano l’Europa e l’Asia (solo 2 sono presenti in Italia, più alcune sottospecie). Il nome deriva dal latino pastus = pasto, nutrimento, allusione alla radice a fittone di P. sativa che è commestibile e a volte, specialmente in passato, coltivata all’uopo. Le piante si caratterizzano per le foglie pennatosette a segmenti abbastanza larghi e dentato-incisi; i fiori a petali gialli, tronchi e revoluti, riuniti in ombrelle di 5-15 raggi senza involucro e involucretto (o quasi).
-Pastinaca sativa L. subsp. sativa PASTRICCIANI
H bienn – Subcosmop. - VII-IX – Relativamente comune almeno in alcuni ambienti.
Erbacea a pelosità ruvida, a fusto eretto, alta 40-100 cm, con radice a fittone con polpa profumata e biancastra; foglie unipennate a 5 foglie o più, larghe e dentate irregolarmente, le basali picciolate; fiori a petali gialli e revoluti, riuniti in ombrelle a raggi (5-20) disuguali, senza (o quasi) involucro ed involucretto; frutto ellittico con breve ala.
Habitat: margini stradali erbosi, prati e schiarite boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentrella orientale; nuovi ritrovamenti: strada da Vernio a Cantagallo (2020); Fonte del Romito; Gasperone di Montepiano; Alpe di Cavarzano (2021) (Vernio) dove in zona umida è presente la subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak.(caratterizzata da fusto pressoché cilindrico, raggi di lunghezza analoga e in numero max. di 5-7; ombrella terminale non più grande delle altre).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021: Bogaia, cassa di espansione.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e Poggio a Caiano.
NB: come si accennava, in passato (Medio Evo) era utilizzata in Europa a fini alimentari, soprattutto il tubero (a polpa biancastra e aromatica), ma è stata soppiantata in gran parte dalla patata al momento della sua comparsa nel vecchio Continente.
Il genere Petroselinum
è attualmente considerato monospecifico (vedi sotto).
-Petroselinum crispum (Mill.) Fuss PREZZAMOLO
H bienn – Coltivato di origine E-Medit. o Asiatica (?), a volte occasionale o naturalizzato – VI-VIII – Raro come naturalizzato.
Erbacea alta 30-100 cm, glabra, a fusti eretti, tubulosi, ramificati e striati; foglie alterne, a contorno triangolare, almeno le inferiori bi- o tri-pennatosette a segmenti terminali incisi; fiori a petali verde-giallastri, le ombrelle presentano un lungo peduncolo e sono composte da 8-20 raggi di uguale lunghezza con involucro di 0-3 segmenti, le ombrellette a più fiori e a raggi uguali hanno un involucretto a 5-8 segmenti lineari-oblinghi; frutto lungo 2-3 mm, subgloboso, con stili riflessi più lunghi dello stilopodio.
Habitat: le piante naturalizzate in incolti fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Pianura: nuovi ritrovamenti: relativamente ricca colonia a margine della ciclabile sul Bisenzio all'altezza di Viale Galilei (2024) (Prato).
PS: l'utilizzo come erba aromatica di questa specie è conosciutissimo e assai diffuso.
Il genere Peucedanum
conta attualmente 7 specie distribuite in Eurasia (4 presenti in Italia). Si caratterizza per le foglie con ultime divisioni molto più lunghe che larghe (sottili), i fiori a petali gialli, bianchi o rosei, l’ombrelle dei fusti terminali più grandi di quelle dei laterali, generalmente assenza di involucro (raramente 2-8 segmenti); peduncolo più lungo del frutto.
?-Peucedanum officinale L. PEUCEDANO OFFICINALE
H scap – Eurosiber. - VI-VIII – Fortemente dubbia la sua presenza nel nostro territorio.
Erbacea verde scura, glabra, eretta, alta da 40 a 100 cm; foglie basali grandi, più volte divise in segmenti assai sottili e triternati, a picciolo cilindrico; fiori giallastri riuniti in grandi ombrelle solo terminali con lungo peduncolo, a 12-25 raggi gracili e lunghi, con involucro a 2-3 segmenti caduchi e involucretto a numerosi segmenti sottili; frutto di 5-10 mm, ovoide, appiattito, a larga ala.
Habitat: boschi e luoghi erbosi fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999: (sub Finocchio porcino): AMPIL del Monteferrato.
Il genere Physospermum
consta di 2 specie, presenti in Europa, Asia e N-Africa (ed anche in Italia). Si tratta di piante a fusto sottili e non fistoloso, con foglie da pennato-lobate a pennatopartite a segmenti terminali più larghi di 1 cm, le cauline assenti o ridotte; fiori a petali bianchi riuniti in ombrelle con involucro persistente a più segmenti; frutti con persistenza dei rudimenti del calice, subglobosi con mericarpi a coste sottili.
NB: il nome deriva dal greco, physa (vescica) e spermum (seme), allusione all’aspetto dei semi “rigonfi”.
-Physospermum cornubiense (L.) DC. FISOSPERMO
H scap – Submedit.-subatlant. - VII-VIII – Non raro.
Erbacea perenne, alta 50-120 cm; le foglie inferiori sono più volte divise e ricordano quelle dell'aquilegia (è chiamata anche P. aquilegifolium); i fiorellini sono bianchi e riuniti in infiorescenze ad ombrella di 10-25 raggi, con involucro a piccoli segmenti patenti e involucretto di 1-5; frutto un po’ rigonfio, didimo e glabro.
Habitat: boschi e radure fresco-umide.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: M. Scoperta, Poggio di Petto, (2019) da Montecuccoli a Le Soda e a N de Le Soda (2021); bosco presso Badia di Montepiano (2019) (Vernio); Spuntoni sotto le Cavallaie (2024) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Danaa cornubiensis) e Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: a N della Fattoria Javello (2018) (Montemurlo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (Fisospermo di Cornovaglia): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sentiero dei Patriarchi (Montemurlo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: Poggio Alto, Le Sacca.
Il genere Pimpinella
è costituito da più di 170 specie a distribuzione euroasiatica e africana (8 in Italia). Le sue piante hanno foglie pennatosette con le cauline ridotte, i fiori a petali bianchi o rosei, privi di calice, bilobi e riuniti in ombrelle (ripiegate prima dell’antesi) a 6-30 raggi e per lo più senza involucro e involucretto; le ombrelle laterali hanno peduncolo più lungo della foglia ascellante; frutto lungo 2-3,5 mm e a coste poco pronunciate.
-Pimpinella peregrina L. TRAGOSELINO CALCATRIPPA
H bienn – Euro-Medit. - V-VII – Rarissima.
Erbacea a fusto pieno, eretto, ramoso, per lo più pubescente e a radice fusiforme, alta 40-100 cm; foglie di forma diversa: le inferiori pennate a 5-9 segmenti orbicolari, crenulate al bordo e cordiformi alla base, le medie dentato-incise e a segmenti cuneiformi all’inserzione, le superiori 2 pennatosette a segmenti lineari; i fiori, bianchi, sono riuniti in ombrelle ad 8-30 raggi e più, prive di involucro e involucretto; frutti piccoli, tondeggianti con peli patenti.
Habitat: incolti ed aree erbose o rocciose.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Ventose (Cantagallo).
Il genere Pteroselinum
è monospecifico, distinto da Peucedanum (nel quale era incluso fino a pochi anni fa) e dagli altri “generi vicini” per le ombrelle dei rami terminali ca. delle stesse dimensione di quelle dei rami laterali, involucro sempre presente a 3-8 segmenti riflessi alla fruttificazione, ultime divisioni fogliari lineari con parte apicale indivisa lunga 1 cm o poco più.
-Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb. IMPERATORIA AUSTRIACA
H scap – SE-Europ. - VII-VIII – Rarissima e localizzata.
Erbacea glabra e verde brillante, alta 40-80 cm, con fusto pieno e scanalato; le grandi foglie inferiori, a picciolo a sezione triangolare, si presentano 3 pennatosette con segmenti terminali sottili e mucronati; fiori bianchi sono riuniti in ombrelle di 20-30 raggi di diversa lunghezza, con presenza di involucro ed involucretto a segmenti lanceolati e riflessi; frutto lungo 8-10 mm, ovato-oblungo, appiattito ed alato, con stilo più lungo dello stilopodio.
Habitat: radure rocciose boschive soprattutto su substrato siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Colline di Montemurlo: Gestri & Peruzzi 2009: sopra le Banditelle, sentiero CAI 10 (43.971 N, 11.075 E).
Il genere Sanicula
consta di una quarantina di specie erbacee a distribuzione subcosmopolita (1 sola specie in Italia). Le sue piante si caratterizzano per non avere i fiori disposti in ombrelle e ombrellule regolari, ma in glomeruli globosi (con breve involucretto) a loro volte riuniti in ombrelle irregolari; foglie palmatopartite; fiori sessili, a petali smarginati; frutti quasi sferici dotati di aculei uncinati.
-Sanicula europaea L. ERBA FRAGOLINA
H scap (H ros) – Euras.-Medit. - V-VII – Relat. comune.
Erbacea glabra, a fusto singolo, eretto, poco foglioso, alta 20-50 cm; foglie lucide, palmate a 3-5 lobi bifidi o trifidi e dentati, le inferiori in rosetta e lungamente picciolate e le superiori sessili; fiori rosati o bianco-verdastri sessili e riuniti in glomeruli compatti a loro volta disposti in ombrelle irregolari a 3-5 raggi, con involucro di 2-4 segmenti acuti e involucretto breve; frutto rotondeggiante, coperto da aculei ad uncino.
Habitat: bosco soprattutto su terreno calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano sopra Prato (Somm.herb); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Bettini & al. 2009: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Cantagallo verso la Rasa (CAI 38) (2021), sopra Luicciana, Poggio Cicialbo (CAI 52), Alpe (2018), sopra Gavigno (CAI 64) (2019) (Cantagallo); verso le Cavallaie (2018) (Montemurlo); sul sentiero da Fonte del Romito a Fonte Canapale (2017), Passo della Crocetta verso Tavianella, sotto Le Barbe (2022), M. della Scoperta (2024) (Vernio).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra Reticaia (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sentiero dei Patriarchi e presso il torrente Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C).
NB: il nome generico Sanicula è legato alle innumerevoli proprietà fitoterapiche attribuite un tempo a questa pianta. In Francia è chiamata Erba di San Lorenzo, martire arso su una graticola, infatti, fra l’altro, le veniva attribuito un effetto cicatrizzante e lenitivo sulle ustioni cutanee.
Il genere Scandix
è composto da una ventina di specie erbacee (per alcuni Autori di più) a distribuzione euroasiatica e N-africana (3 presenti in Italia con diverse sottospecie). Le sue piante si caratterizzano per il frutto allungato e lineare, con becco uguale o maggiore del corpo, le foglie 2-4 pennatosette, i fiori bianchi riuniti in ombrelle a 1-5 raggi, involucro normalmente assente.
-Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris PETTINE DI VENERE
T scap – Euro-Medit. - IV-VI – Poco comune (abbondante in alcune stazioni).
Erbacea glabrescente, gracile, ramosa superiormente, alta da 10 a 40 cm; le foglie, picciolate, sono 3 volte divise con segmenti terminali sottili; i fiori sono bianchi e riuniti in ombrelle semplici opposte alle foglie, a 1-3(-5) raggi robusti e più brevi dei frutti (allungati e con rostro terminale distinto); involucro mancante e involucretto formato da 5 segmenti larghi, bi- o tri-fidi, oppure pennatosetti; frutti allunganti (15-80 mm) con becco fino a 60 mm, terminante in 2 stili di 1-2,5 mm nella subsp. nominale.
Habitat: coltivi ed incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Sassetta e a S di Vernio sul margine stradale (2023) (Vernio).
- Barco di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1014; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: Bogaia.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: coltivi ed incolti erbosi.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S); Figline inizio strada verso Cerreto.
- Pianura: oss. Gestri 2017 Wikiplantbase#Toscana: Figline margine strada dopo il cimitero (Prato); nuovi ritrovamenti: via di Galceti (2020) (Prato).
NB: spesso i nomi delle piante sono ispirati alla mitologia: in questo caso la forma delle infruttescenze, a lunghi segmenti, ha ricordato al botanico che l'ha denominata un pettine così grazioso da rappresentare quello utilizzato da Venere, la dea dell’amore.
Il genere Sison
consta di 3 specie a distribuzione paleotemperata (2 presenti in Italia). Simile a Pimpinella (vedi) dal quale si differenzia per la presenza costante di involucro a 1-5 segmenti (a volte però caduco alla fruttificazione) e involucretto pure a 1-5 segmenti; sono piante glabre (frutti compresi) con l’ombrella costituita da 2-6 raggi a fiori bianchi o rosei.
-Sison amomum L. AMOMO GERMANICO
H bienn – Subatant.-Submedit. - V-VII – Poco comune.
Erbacea aromatica (odore sgradevole), a fusto eretto e ramificato, alta da 30 a 50 cm; foglie inferiori imparipennate a 5-9 segmenti dentati al margine e di forma ovale (nelle superiori i segmenti sono lineari); i fiorellini bianchi sono riuniti in numerose piccole ombrelle a 3-6 raggi ineguali; involucro a 1-3 segmenti lineari e involucretto 1-5 molto piccoli; il frutto, piriforme e costoluto, è lungo 2-3 mm.
Habitat: zone fresco-umide di boschi e boscaglie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso fonte sulfurea Mercatale di Vernio, sopra Montepiano e verso P. di Petto (2020) (Vernio) e dal lago Verde verso Sant’Ippolito (2021) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Poggio a Caiano: Caruel 1860-64.
NB: il nome generico (Sison) deriva da una specie officinale della Siria ricordata da Dioscoride (medico-botanico greco, vissuto ai tempi di Nerone).
Il genere Sium
è costituito da una quindicina di specie distribuite in Europa, Asia, Africa e Nord America (2 in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni di zone umide, con fusti radicanti ai nodi, foglie pennatosette a segmenti ovali o lanceolati, dentati o incisi; fiori a petali bianchi riuniti in ombrelle a 5-35 raggi, con presenza di involucro e involucretto (a segmenti ineguali e spesso riflessi); frutti brevi e glabri.
??-Sium latifolium L. SEDANINA SELVATICA
Specie propria di zone umide segnalata per errore nell’Area protetta del Monteferrato (Biagioli & al. 1999): anche in Toscana è stato indicato pochissime volte in aree palustri e solo anticamente (Caruel 1860-64 e Baroni 1897-1908)!
Il genere Smyrnium
è costituito da meno di 10 specie soprattutto erbacee che vivono nella regione paleotemperata del globo e di cui 2 sono presenti nella flora italiana. Hanno foglie basali divise, picciolate e guainanti, prive di stipole; fiori verde-giallastri riuniti in ombrelle composte di 6-15 raggi, mancanti di involucro ed involucretto (quest’ultimo a volte rappresentato da segmenti assai ridotti); frutti rotondeggianti e rigonfi, glabri, costituiti da 2 mericarpi a 5 coste.
-Smyrnium olusatrum L. MACERONE
H bienn – Medit.-Atlant. - I-V – Localizzato
Erbacea a fusto cavo ed eretto, glabra, alta 30-120 cm; si differenzia dalla specie successiva per le foglie superiori del caule 1-2 pennatosette, presenza di involucretto a piccoli segmenti, frutto subgloboso, grosso (7-8 mm), nero e rugoso, con stilopodio uguagliante gli stili in lunghezza.
Habitat: anche in aree ruderali, in luoghi erbosi fresco-umidi, zone marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
NB: sui rilievi della Calvana la specie è presente, ma solo sul territorio di Calenzano (Firenze) (Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016).
-Smyrnium perfoliatum L. subsp. perfoliatum SMIRNIO PERFOLIATO
H bienn – Euro-Medit. - III-V – Localizzato (abbastanza diffuso solo in Calvana).
Erbacea a fusto pieno ed eretto, glabra e alta 30-120 cm; si differenzia da Smyrnium olusatrum per le foglie superiori del caule semplici, abbraccianti, di forma ovata o orbicolare, assenza (o con 1 segmento caduco) di involucretto, frutto più piccolo con stilo più breve dello stilopodio.
Habitat: boschi e luoghi rocciosi (da noi soprattutto su calcare).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: strada da Montepiano all’Alpe (prima del Gasperone) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: una sola stazione nel bosco dei Patriarchi (Montemurlo).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: bosco di Poggio Alto (Prato).
Il genere Tommasinia
comprende 1 (-2) specie Europea: pianta erbacea robusta e di grandi dimensioni che si distingue da quelle del genere Peucedanum (nel quale era inclusa fino a poco tempo fa) per le foglie 3-4 pennatosette a ultimi segmenti numerosi, ovati e dentati, fiori bianco-verdastri riuniti in ombrelle verticillate e con involucro nullo (o ad 1 brattea caduca).
-Tommasinia altissima (Mill.) Reduron IMPERATORIA DI TOMMASINI
H scap – Orof. S-Europ. - V-VIII – Localizzata, oltre una certa altitudine.
Erbacea eretta, assai robusta ed elevata (da 100 a più di 300 cm), fusto del diametro di 1-3 cm e portante, oltre la metà, verticilli di 3-6 ombrelle; foglie (molto grandi le basali) 2-3 pennatosette a segmenti terminali ovati e profondamente dentati; i fiori, giallo-verdastri, sono riuniti in ombrelle a 10-30 raggi, prive di involucro (o con 1 brattea); frutto lungo ca 8 mm e largamente alato.
Habitat: presso corsi d’acqua, ma anche scoscesi e chiarie boschive e arbustive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: margine strada da Montepiano verso l’Alpe: in basso, in zona Gasperone, all’Alpe di Cavrazano e alla base della Scoperta (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub Peucedanum verticillare (L.) W.D.J. Koch) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Tommasinia verticillaris Bertol.): Cantagallo.
Il genere Tordylium
è costituito da una ventina di specie quasi esclusivamente erbacee (annuali o perenni) distribuite in area euro-mediterranea e W-asiatica (in Italia 3 entità erbacee annuali). Le sue piante presentano foglie semplici, pennate o pennatosette; fiori pentameri, bianchi o rosei, riuniti in ombrelle a 4-10 raggi dotate di involucro e involucretto (a numerosi segmenti lineari); frutto orbicolare o ovato, compresso e a margine evidentemente ispessito.
-Tordylium apulum L. OMBRELLINI PUGLIESI
T scap – Medit. - IV-VII – Comunissima.
Erbacea a fusto eretto, un po’ ispido e tenace, alta 10-60 cm; ha foglie pennate a segmenti ovali e dentellati; i piccoli fiori bianchi sono riuniti in ombrelle a 5-8 raggi, con involucro a 5-7 brattee e involucretto a bratteole simili, ma più brevi; l'infiorescenza è caratterizzata dai fiori periferici a un solo petalo molto grande e dotato di due lobi ineguali; il frutto, non ispido, è ellittico a bordo espanso e crenulato.
Habitat: incolti, pascoli, zone di transizione, margini di coltivi ecc.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso il Lago Verde, sopra Motecuccoli, da Fabbro verso Migliana e da Carmignanello a Gricigliana (2020) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e GP6: Prato, Cantagallo, Vaiano; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: Monte Buriano, fra i Centopini e i Bifolchi.
- Cascine di Tavola: Spampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggo a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: campi e zone un tempo coltivate.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: è specie alimentare (ricorda il prezzemolo) e officinale (in particolare sembra molto ricca di vitamina E).
-Tordylium maximum L. OMBRELLINI MAGGIORI
T scap – Euro-Medit. - IV-VII – Poco frequente.
Erbacea alta 30-80 cm, di aspetto generale simile alla precedente; se ne distingue soprattutto per avere sul fusto setole assai scabre e rivolte in basso, per il segmento superiore delle foglie lanceolato e ad inserzione cuneiforme e per i frutti ispidi.
Habitat: incolti, zone aride e pietrose, aree marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Migliana (2019) (Cantagallo), da Montepiano al Gasperone (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra il paese e verso Cicignano (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Montemurlo: Parlatore 1889 e Baroni 1897-1908: a Montemurlo.
Il genere Torilis
è rappresentato da una quindicina di specie erbacee annuali, bienni o perenni, diffuse in Eurasia (in Italia 12 entità fra specie e subspecie); i fusti sono rudi e le foglie inferiori bipennatosette; i piccoli fiori sono bianchi o rosei e riuniti in ombrelle a 2-12 raggi; l’involucro è assente o costituito da 1-5 segmenti e l’involucretto è presente e a segmenti multipli; il frutto, da lineare a ovoidale, è lungo 2-3 mm, un po’ compresso e fra le creste si trovano numerose spine o tubercoli.
-Torilis africana Spreng. LAPPOLINA PURPUREA
T scap – Subcosmop. - III-VIII – Non rara.
Erbacea alta 20-60 cm, caratterizzata, rispetto alle altre piante congeneri con infiorescenze terminali, dall' assenza dell'involucro (o ridotto), da ombrelle con un numero di 2-3 (4) raggi e dalle foglie superiori spesso divise in segmenti lineari e allungati; i petali oltre che bianchi possono essere rosei o violacei.
Habitat: incolti aridi, campi coltivati, zone rocciose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: Riserva Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: dal L. Verde a Migliana, da Migliana verso le Cavallaie, Acquiputoli (2020) (Cantagallo), Alpe di Cavarzano e sopra il Goranadaccio verso Montepiano (2021) (Vernio).
- Bargo di P. a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni e Bartolini 1997 (sub T. purpurea (Ten.) Guss.); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub T. arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek): Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub T. purpurea (Ten.) Guss.): Carmignano
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis LAPPOLINA DEI CAMPI
T scap – Subcosmop. - V-VII – Comune.
Erbacea, eretta, alta 20-60 cm, caratterizzata, rispetto alle altre piante congeneri con infiorescenze terminali, da involucro assente o ridotto e ombrelle a più di tre raggi con foglie superiori a segmenti non particolarmente allungati e sottili; i petali sono sempre bianchi.
Habitat: ruderale, incolti aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: Riserva Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: Migliana (2019) (Cantagallo), sopra la Badia di Montepiano (2023) (Vernio).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: a N della Fattoria di Javello (2017) (Montemurlo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano. P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: poderi Baylon e Ciabatti, e in altre zone a coltura (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Torilis japonica (Houtt.) DC. LAPPOLINA PETROSELLO
T scap – Subcosmop. - VI-VIII – Non rara.
Erbacea eretta e alta da 20 a più di 100 cm, è caratterizzata, rispetto alle altre piante congeneri con infiorescenze terminali, dall’involucro delle ombrelle ben sviluppato a 4-8 (12) brattee.
Habitat: ruderale e di incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: Riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Rio Ceppeto sopra Cantagallo, a N de Le Soda, dagli Acquiputoli al Faggione (2019), Pian della Rasa (2021) (Cantagallo), sopra il Gorandaccio di Vernio, sentiero 00 da Montepiano all'Alpe, Gasperone sopra Alpe, Scalette (2022) (Vernio).
- Bargo di P. a Caiano: Maugini 1946 (sub T. anthriscus); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmiganao, P. a Caiano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: Case Serilli (S) (Vaiano).
??-Torilis leptophylla (L.) Rchb.f. LAPPOLINA MINORE
T scap – Medit.-Turan. - V-VI – Rarissima o scomparsa.
Erbacea a fusto eretto e ramificato dicotomicamente, alta 10-50 cm; come T. nodosa ha le ombrelle dell’infiorescenza opposte alle foglie sui lati del fusto; si distingue da questa per: il frutto lungo ca. 5 mm, le ombrelle a raggi (2-3) ben visibili (sovente a maturità uguali o maggiori a 5 mm) e il fusto eretto.
Habitat: ruderale, incolti aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 e Gestri 2009, ma da riferirsi al territorio del comune di Calenzano (FI); non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2016.
-Torilis nodosa (L.) Gaertn. LAPPOLINA NODOSA
T scap – Euro-Medit.-Turan. - III-VIII – poco comune.
Erbacea, alta 20-60 cm, che si caratterizza, rispetto alle specie congeneri, per portare le infiorescenze opposte alle foglie e lateralmente sul fusto (infiorescenze non terminali); da T. leptophylla per: il frutto lungo 2-3 mm, le ombrelle a raggi (3-4) molto brevi quasi invisibili (subnulli) e il fusto è prostrato.
Habitat: ruderale, incolti aridi, margine sentieri e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Vernio (2023) (margine stradale).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009: Prato; Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri 2023a: Seano in via Rizzello in incolto erboso (Carmignano).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: incolto margine stradale presso la rotonda del viale Fr. Cervi presso la scuola d’Infanzia Meoni (2023).
Il genere Trinia
è composto da una decina di specie erbacee a distribuzione euro-asiatica. Le sue piante presentano foglie inferiori 2-3 pennatosette a ultimi segmenti sottili e allungati, fiori dioici o monici, riuniti in ombrelle di 4-8 raggi assai diversi in lunghezza, frutto glabro e privo di ali, nero e lucido a maturità.
-Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca SASSIFRAGIA PANNOCCHIUTA
H scap – S-Europ. - IV-VII – Localizzata al Monteferrato.
Erbacea glauca, cespitosa, a fusto eretto ramificato a zigzag, alta 10-50 cm; foglie 2-3 pennatosette a 3-5 segmenti lineari e sottili fino a 0,5 mm; fiori bianco-giallo-rosati riuniti in numerose ombrelle a 4-6 raggi disuguali, prive di involucro e involucretto; frutto glabro, ovoide, di 2-3 mm, nero a maturità.
Habitat: terreni assolati, aridi e sassosi (nel Pratese almeno serpentinofita preferenziale).
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Caruel 1860-64 (sub T. vulgaris Dec.): M. Ferrato a Prato (Parl!): Parlatore 1889 (sub Apinella glauca (L.) Caruel); Fiori 1914; Messeri 1936 (sub T. g. (L.) Dumort. ssp. euglaucum Wollf. var. jacquinii (DC.) Wollf.); Arrigoni & al. 1983; Ricceri 1998; Biagioli & al. 2002: esclusivamente su serpentino.
Il genere Trochiscanthes
è monospecifico, caratterizzato da un alto fusto con ramificazioni opposte o pseudoverticillate e ± patenti, foglie inferiori grandi e divise 3-4 volte a segmenti terminali incisi o dentati e più larghi di 2 cm; fiori verdastri; frutto più lungo che largo.
-Trochiscanthes nodiflora (All.) W.D.J.Koch ANGELICA MINORE
H scap - Orofila S-Europ. - VI-VIII - Rara.
Erbacea fetida, glabra, a fusto esile, striato, eretto, con ramificazioni patenti opposte o verticillate; foglie inferiori divise 3 o 4 volte a segmenti ovato-lanceolati e dentellati e con picciolo lungo fino a 20 cm, le altre simili ma ridotte didimensioni, le superiori solo ad una stretta guaina; fiori - corolla bianco-verdastra, a petali obovati ad apice a punta ricurva, calice con 5 denti - sono disposti in piccole ombrelle a 4-8 raggi (involucro nullo o a 1 segmento, involucretto a 3-5) riunite numerose, verticillate o opposte, a costituire un panicolo; frutto ovato di 4-5 mm.
Habitat: boschi ombrosi soprattutto di faggio.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: lungo il Torrente le Barbe, prima delle sorgenti del Bisenzio, loc. il Frassino in faggeta (Cantagallo); a N del Valico della Crocetta e a S di Risubbiani, loc. Castagnolo (Vernio).
Il genere Visnaga
si presenta con 1-2 specie distribuite in area mediterranea. Simile al genere Ammi (a cui le sue entità erano attribuite fino a pochi anni fa) è caratterizzato da fiori a petali bianchi o rosei, involucro a numerosi peduncoli (generalmente più di 60) dilatati in alto e che si contraggono e ravvicinano al momento della fruttificazione; foglie (1 pennatosette) cauline maggiori degli internodi corrispondenti e tutte a segmenti terminali larghi 0,2-1,5 mm e a margine intero.
-Visnaga daucoides Gaertn. VISNAGA COMUNE
T scap – Euro-Medit. - IV-IX – Rarissima.
Erbacea, glabra, a fusto robusto, fogliato e ramoso, alta 20-80 cm; foglie 2-3 pennatosette a segmenti interi, sottili e lineari; fiori bianchi-giallastri riuniti in ombrelle ricche di raggi (30-50, ma a volte molte di più), gracili e assai conniventi alla fruttificazione, involucro a segmenti divisi in 3-5 lacinie sottili e spesso revoluti e involucretto a segmenti interi; frutto piccolo (2-2,5 mm), ovato, a stili riflessi, sottili e più lunghi dello stilopodio.
Habitat: incolti fresco-umidi a substrato argilloso.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: al Podere dell’Orto in un campo e presso l’Elsana sotto Ginestre.
Il genere Xanthoselinum
consta di 1-2 specie euroasiatiche, fa parte del “gruppo” di generi simili a Peucedanum (vedi) dal quale si distingue per le numerose ramificazioni del fusto, le ombrelle dei rami terminali all’incirca delle stesse dimensioni di quelle dei rami laterali, l’involucro a 3-8 segmenti patenti e persistenti; presenta fiori a petali bianchi e foglie 2-3 pennatosette.
Xanthoselinum venetum (Spreng.) Soldano & Banfi IMPERATORIA VENETA
H scap – SW-Europ. - VII-IX – Rarissimo.
Erbacea eretta, glabra, a fusto scanalato, cavo, alta 80-120 cm; grandi foglie inferiori 2-3 pennatosette a segmenti terminali larghi 2-3 mm; fiori bianchi a petali di ca. 1 mm, riuniti in ombrelle a 10-30 raggi brevi, con involucro a (4-8) segmenti lanceolati, patenti, e involucretto a segmenti ridotti e sempre non riflessi; le ombrelle in alto sul fusto sono spesso riunite in verticilli; frutto (ca. 4 mm) pubescente, alato ed ellittico con stili più lunghi dello stilopodio e riflessi.
Habitat: boschi radi, arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: versante E del Monte Cicialba (2018) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: da Casa Bastone ai Bifolchi (Prato) e Crocicchio, vers. N M. Cagnani (Vaiano).
- Colline di Montemurlo: sentiero CAI 10 sopra la Fattoria di Javello.