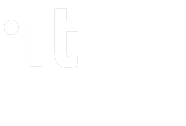Asteraceae
.
Famiglia Asteraceae
Si tratta della Famiglia - distribuita in tutto il globo - con il più alto numeri di specie nel mondo (oltre 23.000), e fra le più evolute; le circa 700 presenti in Italia sono piante erbacee annue, bienni o perenni (altrove anche arboree e succulente), alcune sono laticifere. Hanno foglie prive di stipole, per lo più spiralate, a volte opposte; i fiori sono generalmente ermafroditi, piccoli e riuniti in capolini più o meno numerosi, circondati da brattee, a volte spinose, disposte in 1 o più ranghi; i fiori sono inseriti sul ricettacolo (ingrossamento terminale del peduncolo) e possono presentarsi in due tipologie in base all'aspetto della corolla: tubulosi (con una parte tubulare terminata da 5 dentelli) e ligulati (con la parte tubulare prolungata in alto in una ligula nastriforme). Le specie che presentano fiori tubulosi appartengono alla sottofamiglia delle “Tubuliflore” (prive di latice), a loro volta si distinguono per avere solo fiori tubulosi o per avere fiori tubulosi al centro (disco) e ligulati alla periferia (raggio); le specie che possiedono solo fiori ligulati appartengono alla sottofamiglia delle “Liguliflore” (spesso con presenza di latice). Il frutto è rappresentato da un achenio che può essere dotato di un pappo (appendice di peli o filamenti piumosi) che ne favorisce la dispersione tramite il vento.
Il genere Achillea
(dedicato al mitico eroe greco Achille) ha distribuzione olartica e gli sono attribuite un numero di specie di poco superiore a 110; si tratta di piante erbacee (a volte suffruticose) perenni, appartenenti alla sottofamiglia delle Tubuliflorae: i fiori tubulosi sono gialli e i ligulati bianchi, gialli o rosei con lembo suborbicolare; il ricettacolo, per lo più piano, è munito di scaglie; gli acheni sono per lo più compressi e senza coste. Le piante sfregate liberano, quasi tutte, fragranze aromatiche.
?-Achillea ageratum L. MILLEFOGLIO AGERATO
H scap – Medit. Occ. - V-X – Rarissima, quasi sicuramente scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea, dal profumo di canfora, a radice lignificata e fusti eretti semplici o ramificati, alta 20-50 cm; foglie ruvide, riunite in fascetti, le inferiori oblunghe-ovate a lobi dentati, le superiori sessili, assai ottuse in alto e pur esse dentate; i fiori - al centro tubulosi e in periferia con ligule brevissime e trilobe - sono gialli e riuniti in piccoli capolini di 2-4 mm di diametro ad involucro ovato e ricettacolo con scaglie lanceolate e acute; vanno a formare un corimbo compatto in alto sul fusto.
Habitat: ambienti incolti ed umidi in area mediterranea.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: Pineta di Bagnolo.
NB: il reperimento nella Pineta di Bagnolo è stato probabilmente dovuto ad una presenza occasionale, in quanto ormai da vari anni non è più stata ritrovata.
COMPLESSO di Achillea millefolium:
le quattro specie successive hanno caratteri morfologici assai simili: capolini numerosi riuniti in corimbo in alto sul caule, con 4-5 fiori ligulati lunghi circa la metà dell’involucro, bianchi o rosati, le foglie sono allungate e a contorno lanceolato.
Foto M. Ziletti
-Achillea collina Becker ex Rchb. MILLEFOGLIO COMUNE
H scap – SE-Europ. - IV-VII – Rara.
Erbacea di aspetto grigio-tomentoso, alta 30-70 cm, con fusto del diametro di almeno 2 mm in basso; foglie (glabre di sopra e pelose di sotto) a contorno lanceolato con lati paralleli o quasi, rachide non alato e largo 0,6-1,2 mm, le basali misurano ca. 1-2 x 8-13 cm, i segmenti primari sono a contorno ovato e ravvicinati, i capolini ridotti (ca. 3 mm di diametro) e con ligule bianche.
Habitat: vegeta in ambienti secchi, prati, terreni disturbati, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso il Faggione di Luogomano (2020), presso il Tabernacolo di Gavigno (2024) (Cantagallo); da Sassetta a Montepiano (2018), da Montepiano al Gasperone ed oltre (2024) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Achillea millefolium L. MILLEFOGLIO MONTANO
H scap – Eurosib.- V-IX – Comune.
Erbacea con fusto del diametro di almeno 2 mm in basso, eretto o ascendente e per lo più semplice, alta 10-80 cm; foglie larghe 1,5-3 cm, con faccia superiore pubescente, contorno a margini periferici ricurvi e larghezza massima nella metà superiore, rachide non alato e largo 0,6-1,2 mm, 2-3 volte pennatosette a segmenti spaziati; capolini del diametro di 4-5 mm, con involucri bratteali subglabri, ligule bianche o rosate.
Habitat: vegeta in ambienti secchi, prati, terreni disturbati, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano (herb. Caruel); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001; Arrigoni & al. 2002: sotto Cascina Ciarliano; Arrigoni & al. 2005: presso Le Barbe, Acquiputoli, Loc. Pellacchia, strada per Luogomano; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Pian della Rasa, Le Barbe pressi, Migliana a N della chiesa (Cantagallo), sopra Badia di Montepiano e Fonte del Romito, presso il Gasperone (Vernio), Le Cavallaie (Montemurlo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso Schignano (2021).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Millefoglio): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
-Achillea roseoalba Ehrend. MILLEFOGLIO BIANCO-ROSEO
H scap – C-Europ. - VI-VIII – Molto rara.
Erbacea alta 20-80 cm assai simile a millefolium; se ne distingue soprattutto per il fusto più gracile (in basso 1,5-2 mm di diametro) e ascendente; foglie quasi sempre tripennatifide con le basali larghe 1-2 cm; ligule quasi sempre rosate.
Habitat:
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso il sentiero che dall’Alpe di Cavarzano sale al crinale (2017) (Vernio).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: trovata solamente - ed in un esiguo numero di piante - in un prato presso la Filimortula.
-Achillea setacea Waldst. et Kit MILLEFOGLIO
H scap – SE-Europ. - V-X – Rara.
Erbacea densamente pubescente, a fusto eretto o ascendente, alta 15-40 cm; foglie tripennatosette a segmenti con rachide non alato e largo 0,5 mm, strette (le basali larghe 4-8 mm e lunghe fino a 9 cm), addensate in alto sul fusto; capolini a involucro piccolo (ca. 3 mm di diametro), con ligule sporgenti e sempre bianche.
Habitat: prati steppici.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano e verso la Scoperta (2024) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: crinale a Le Cavallaie (2018).
- Monteferrato: ritrovata da Messeri 1936 nell’erbario Groves, ma da lei non ritrovata; BGMA02: zona pedecollinare del M. Chiesino (terreno marnoso).

Foto di M. Ziletti
ex-Achillea tomentosa L. MILLEFOGLIO GIALLO
H scap – S-Europ.-Subsiber. -VI-VIII – Probabilmente scomparsa.
Erbacea perenne, alta 15-50 cm, simile a A. ageratum (capolini numerosi a fiori gialli e a corimbo apicale, con solo 4-5 ligulati più brevi dell’involucro), dalla quale si differenzia per le foglie 1-2 pennatosette a segmenti lineari ed evidentemente tomentose, ma non vischiose.
Habitat: aree rocciose silicee.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Caruel 1860-64, Fiori 1914 e Messeri 1936, ma non più ritrovata in seguito (Biagioli & al. 2002).
NB: questa specie è rara in tutta la Toscana nella quale è stata recentemente segnalata solo in provincia di Grosseto ed osservata in quella di Massa Carrara, dove un tempo doveva essere più comune. Sembra scomparsa a Prato: evidentemente si tratta di una specie in regresso almeno nella nostra Regione.
Il genere Ambrosia
è costituito da piante erbacee annuali o perenni, spontanee in America (solo una – A. maritima L. - ha areale Euro-Medit.) e costituito da una trentina di specie, di queste 4 si sono naturalizzate in Italia. Quelle presenti in Europa hanno foglie opposte (almeno le inferiori) e ± divise; i capolini sono costituiti da fiori (giallastri o verdastri) unisessuali: quelli femminili sono superiori ed hanno un solo fiore senza corolla e con persistente involucro a campana; i maschili sono emisferici, con brattee saldate a coppa e riuniti in racemi laterali.
-Ambrosia artemisiifolia L. AMBROSIA A FOGLIE DI ARTEMISIA
T scap – esotica di orig. N-Americ. - VI-IX - Rara.
Erbacea annua non aromatica, di 30-100 cm, a fusto assai ramificato in alto; si riconosce in particolare dalle foglie (simili a quelle dall’Artemisia): lunghe 3-10 cm, solitamente 2 volte partite (almeno le mediane): presenta radice a fittone e numerose radici secondarie fino al colletto, involucro a maturazione con 5-7 denti pungenti; fruttifica abbondantemente a fine estate-autunno.
Habitat: campi incolti, terreni rocciosi, scoscesi.
Distribuzione sul territorio:
- Pianura: Gestri in Peruzzi & al. 2024: via del Pantano loc. Case del Rio, in campo a
riposo da colture (Prato).
-Ambrosia psilostachya DC. AMBROSIA A FOGLIE DI CORONOPUS
G rhiz – esotica di orig. N-Americ. - VII-IX – Rara.
Erbacea perenne, tomentosa, alta 30-100 cm, a rizoma strisciante, fusto assai ramificato in alto: quasi tutte le ramificazioni appaiono a racemo terminale di 3-4 cm (alcuni racemi glomerulari ascellari); foglie spesso subsessili e di solito 1-pennatosette con lobi stretti, larghi 3-7 mm, e oblunghi; involucro del frutto si presenta inerme con denti corti e smussati, quello dei fiori maschili coperto di peli radi.
Habitat: terreni poveri, macereti.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub A. coronopifolia Torr. et Gray): presso Montalgeto (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub A. coronopifolia Torr. et Gray): ex-cava di Gello su terra di riporto.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: via del Pantano (2023).
Il genere Anacyclus
ha distribuzione mediterranea ed è costituito da poco più di una decina di specie erbacee, di cui 2 presenti in Italia. Presentano fiori ligulati periferici e tubulosi centrali; di caratteristico hanno gli acheni assai compressi, con quelli laterali circondati tutt’intorno da un’ampia ala ialina (Anakuklosis in greco significa circonvoluzione!) e gli interni con ala ridotta o assente. E’ prossimo al genere Anthemis (vedi) dal quale si distingue soprattutto (oltre all'aspetto degli acheni) per le pagliette del ricettacolo acuminate e di forma romboidale.
?-Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. CAMOMILLA TOMENTOSA
T scap – Medit. - IV-VII – Rarissima (probabilmente scomparsa).
Erbacea alta 20-50 cm, a fusti ascendenti molto ramosi; le foglie sono alterne, 2-3 pennatosette a segmenti patenti, lineari e mucronati, larghi 1-3 mm; capolini del diametro di 15-40 mm con fiori ligulati e bianchi alla periferia e tubulosi al centro (provvisti alla base di 2 ali), pagliette da lanceolate ad ovali, verdastre con margine biancastro o purpureo e peduncolo ingrossato alla fruttificazione; gli acheni sono lunghi appena 2 mm, biancastri a 2 coste salienti.
Habitat: prati, incolti, margini stradali e di campi in area mediterranea.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: campo presso Bonistallo (P. a Caiano).
?-Anacyclus radiatus Loisel. subsp radiatus CAMOMILLA RAGGIATA
T scap -Medit. - V-VIII – Rarissima (probabilmente scomparsa).
Erbacea alta 20-60 cm, molto simile alla precedente dalla quale si distingue per avere i fiori ligulati gialli (a volte arrossati alla base), le lacinie delle foglie inferiori al mm di larghezza.
Habitat: incolti sabbiosi soprattutto presso la costa.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava Guarino su terra di riporto (Montemurlo).
Il genere Andryala
è costituito da una ventina più specie erbacee, distribuite in area mediterranea e in Macaronesia (5 in Italia). Le sue piante hanno capolino con solo fiori ligulati, gli alveoli del ricettacolo con all’intorno setole lunghe come o più dei fiori (caratteristica fondamentale) e squame involucrali in 1 serie; inoltre il pappo degli acheni è composto da peli.
-Andryala integrifolia L. LANUTELLA COMUNE
T scap – Euri-Medit. Occ. - IV-VI – Comune.
Erbacea a fusto eretto e ramoso, alta fino a 70 cm; è ricoperta completamente da un feltro di peli semplici e, soprattutto sul peduncolo e sull’involucro, vi si trovano anche peli ghiandolosi; ha foglie cauline lanceolate, intere e sessili, le inferiori sono spatolate, dentate o sinuate e attenuate alla base; i fiori gialli (solo ligulati) sono riuniti in capolini terminali disposti a corimbo; gli acheni, di circa 2 mm, sono bruni e dotati di pappo di peli.
Habitat: incolti, suoli aridi e assolati, garighe.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso Tabernacolo di Gavigno (2019) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub A.i. var. undulata); Gestri & Lazzeri 2021.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Lanutella comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; oss. Roma-Marzio & Peruzzi 2015 Wikiplantbase#Toscana: nel parcheggio del bar "il Pinone" (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava di Gello (Prato) ed ex-cava Guarino (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S):
NB: le foglie basali sono commestibili: generalmente si consumano dopo cottura in acqua (perché pelose) e miste a quelle di altre erbe.
Il genere Antennaria
è costituito da una quarantina di specie erbacee perenni, o più raramente subarbustive, che vegetano (quasi tutte) nell’emisfero settentrionale (2 in Italia). Le piante si caratterizzano per avere capolini a soli fiori (funzionalmente) maschili di forma da globosa a discoide e a squame involucrali interne ± patenti, e capolini a soli fiori femminili di forma da cilindrica ad ovata e squame involucrali interne erette, hanno aspetto bianco-lanoso e altri caratteri assai simili a Gnaphalium (vedi).
-Antennaria dioica (L.) Gaertn. SEMPITERNI DI MONTAGNA
Ch rept – Circumbor. - VI-VII – Rarissima.
Erbacea dioica a fiori tubulosi, di aspetto bianco-lanoso, con stoloni radicanti e fusto eretto, alta 5-15 cm; foglie tomentose: le basali in rosetta e di forma spatolata, arrotondate in alto e mucronate, le cauline lineari-lanceolate eretto-applicate; capolini a tubo, riuniti a 3-8 in corimbi densi: i maschili hanno brattee involucrali obovate e per lo più biancastre e i femminili oblungo-lanceolate e rosa più o meno carico; acheni dotati di pappo.
Habitat: pascoli, prati, radure di bosco in montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: M. delle Scalette, loc. Le Selve (Cantagallo).
Il genere Anthemis
è distribuito dalla regione mediterranea all’Asia centrale con più di 170 entità specifiche; in Italia ne sono presenti una ventina con in più alcune subspecie. Si tratta di piante erbacee a fiori tubulosi interni (gialli ed ermafroditi) e ligulati (bianchi e femminili) periferici su un solo rango e lunghi 2-4 cm, che vanno a costituire capolini con involucro di 8-12 mm, ricettacolo conico alla fruttificazione e dotato di pagliette o scaglie poste alla base dei fiori; gli acheni non sono o sono molto poco compressi, hanno forma subcilindrica, piriforme, quadrata, ma comunque ad angoli smussati.
-Anthemis arvensis L. CAMOMILLA BASTARDA
T scap (H scap) – Medit. divenuta Cosmop. - IV-VI – Non rara.
Assomiglia morfologicamente alla camomilla (Matricaria chamomilla L.) però si distingue con facilità perché non sprigiona il caratteristico profumo. Ha fusti eretti o ascendenti, ramificati, alti 10-50 cm; le foglie, amplessicauli, sono 2 pennatosette a segmenti lineari; i capolini (fiori ligulati bianchi all’esterno e tubulosi gialli all’interno) sono riuniti in capolini terminali di circa 2 cm di diametro, con involucro a lacinie largamente scariose in alto.
- - Anthemis arvensis L. subsp. arvensis CAMOMILLA BASTARDA COMUNE
Si caratterizza rispetto alla subsp. successiva per la pubescenza scarsa, gli acheni a sezione cilidica (±) e il peduncolo non ingrossato alla fruttificazione sotto il capolino.
Habitat: si comporta spesso da infestante in prati e campi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano verso Monte della Scoperta (Somm. herb.); Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: vers. E della Scoperta; Fonte del Romito (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: in passato segnalata da Maugini 1946 non è stata in seguito in Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- - Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman FALSA CAMOMILLA A PEDEUNCOLI INGROSSATI
Si caratterizza rispetto alla sottospecie precedente per la pubescenza densa, gli acheni a sezione tetragona e il peduncolo ingrossato all’apice al momento della fruttificazione.
Habitat: radure, prati e pascoli aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Badia di Montepiano verso il passo di S. Stefano (2018) (Vernio).
-Anthemis cotula L. CAMOMILLA FETIDA
T scap – Euro-Medit. - VI-IX – Rara.
Erbacea glabra con fusto ascendente o prostrato e ramificato già dal basso, alta 10-50 cm; si caratterizza per l’odore fetido, le foglie 2 pennatosette a lacinie molto sottili (0,3-0,4 mm), il ricettacolo pronunciatamente conico con pagliette lineari nella metà superiore e gli acheni fortemente tubercolati; i fiori ligulati sono bianchi e i tubulosi gialli.
Habitat: campi, ambienti ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2022) (Vernio).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: solo a monte delle ville di Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): rr Le Lastre in incolto.
Il genere Arctium
ha distribuzione eurasiatica e conta poco meno di una trentina di specie (4 in Italia); si tratta di erbacee spesso bienni (almeno da noi) con fiori solo tubulosi ermafroditi, rossastri o biancastri e involucro globoso a brattee numerose e caratteristicamente uncinate; il ricettacolo si presenta con numerose squame aristate; le foglie sono alterne a lamina allagata, in genere intera e ruvida; acheni oblunghi con breve pappo a setole scabre.
NB: un po’ tutte le specie di questo genere erano già nell’antichità considerate erbe medicinali; le foglie essiccate e sminuzzate di queste piante sembrano avere un buon effetto antipruriginoso sulla cute.
-Arctium lappa L. BARDANA MAGGIORE
H bienn – Eurasiat. - VII-IX – Poco comune.
Erbacea bienne, alta da 50 a 200 cm, a fusto eretto, striato e assai ramoso, foglie assai grandi, ovali e con piccioli non fistolosi, biancastre di sotto; si caratterizza per i capolini non ragnatelosi e del diametro (comprese le brattee) di 3-4 cm, assai lungamente peduncolati formanti un corimbo lasso; involucro glabro, fiori tubulosi di color violaceo-rossastro e avvolti da brattee uncinate quasi mai porporine neppure sugli uncini, ma completamente verdi; acheni lunghi 6-7 mm.
Habitat: incolti, radure, siepi, margini boschivi e di strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: : Montepiano (angolo Viale della Repubblica/via Bosco di Sopra), sopra la Badia, verso Tavianella ecc. (2019) (Vernio).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sporadica su terreni abbastanza maturi.
-Arctium minus (Hill) Bernh. BARDANA MINORE
H bienn – Euro-Medit. - VII-IX – Comune.
Erbacea bienne, alta 50-150 cm, pelosa, a foglie inferiori grandi, ovali-cordiformi, picciolate e glabre di sopra; fiori violacei in capolini subsferici, brevemente peduncolati, di 1-2 cm, con ricettacolo irto di scaglie lesiniformi, spesso arrossate in alto; l'involucro è glabro o poco ragnateloso. Si differenzia dalle specie congeneri per i capolini del diametro inferiore ai 3 cm con brattee tutte uncinate e arrossate in alto, le mediane larghe alla base meno di 1,6 mm.
Habitat: bordi stradali, incolti e radure boschive in terreni ricchi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Liimentra orientale; nuovi ritrovamenti: verso Tavianella (Vernio).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: a N della fattoria di Javello (2017).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: anche sulle serpentine (ex- cava di Gello: Prato; Volpaie ecc.: Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): Cerreto e vers. W. P. alle Croci.
-Arctium nemorosum Lej. BARDANA SELVATICA
H bienn – Europ. - VII-IX – Assai rara.
Erbacea bienne alta 80-230 cm, simile ad Arctium lappa (vedi); si differenzia per il picciolo fistuloso, i capolini sferici del diametro di 2-4 cm, a brattee interne più brevi dei fiori (che presentano corolla ghiandolosa e porporina), ± glabre e arrossate in alto e gialle sugli uncini; i capolini sono riuniti in corimbo compatto.
Habitat: incolti e zone marginali di strade e boschi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: dal Lago Verde a S.Ippolito (2018) (Cantagallo, Vernio), sopra Montepiano verso Gasperone (2019) (Vernio).
Il genere Arnoseris
è monospecifico (vedi sotto).
ex-Arnoseris minima (L.) Schweigg.et Körte
T ros – Europ. - V-VI – Molto probabilmente scomparsa.
Erbacea annuale, glabra, senza latice, fusto semplice spesso a 1-2 ramificazioni al vertice, alta 6-30 cm; le foglie, obspatolate-lanceolate e dentellate, sono tutte disposte in rosetta basale; capolino di 7-10 mm, con peduncolo evidentemente ingrossato alla sommità e involucro a brattee fortemente conniventi alla fruttificazione; fiori tutti ligulati e gialli; acheni piccoli.
Habitat: campi coltivati a cereali soprattutto su terreno siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: all’ex-cava di Gello su terra di riporto (Prato). Da allora non più ritrovata.
Il genere Artemisia,
a distribuzione olartica, S-americane e S-africana, è costituito da più di 500 specie legnose alla base o erbacee perenni o annuali, tutte caratterizzate da un più o meno intenso aroma, non sempre piacevole; hanno foglie alterne, 1-2-3-pennatopartite, per lo più con faccia superiore verde e l'inferiore bianco-tomentosa; i fiori sono tutti tubulosi e riuniti in capolini subsferici piccoli che si aggregano in racemi terminali. Questo genere deriva la propria denominazione dalla mitologica Artemide, dea della caccia (la Diana latina).
-Artemisia absinthium L. ASSENZIO VERO
Ch suffr (H scap) – Subcomop. - VIII-IX – Poco frequente.
Erbacea bianco-tomentosa, alta 40-70 cm, profumata al Vermout e di sapore molto amaro; il fusto è legnoso alla base e per il resto robusto, ma erbaceo; le foglie, setolose, hanno lamina 3-pennatosetta a segmenti larghi 3-4 mm, oblunghi-lineari-lanceolati e sono picciolate, le superiori sono di dimensioni minori e subsessili; capolini numerosi, emisferici, di 3-4 cm, a involucro biancastro, con scaglie lineari le esterne e ovali le interne, riuniti in pannocchia terminale fogliosa; acheni lisci.
Habitat: incolti, zone ruderali, presso muretti, scoscesi rocciosi.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: presso Villa Bencini (Bacchereto di Carmignano); nuovi ritrovamenti: zona Toracce a margine di un campo (2024) (Carmignano).
PS: è presente, seppure raramente anche in Calvana, ma un poco al di fuori della nostra provincia (Montecuccoli e versante E del M. Maggiore).
-Artemisia alba Turra ASSENZIO MASCHIO – ERBA REGINA
Ch suffr – S-Europ. - VIII-IX – Non particolarmente rara, ma localizzata.
Suffrutice (legnoso alla base) glabro o poco peloso, a fusto ascendente e glabro almeno in basso, alta 30-60 cm, con odore di canfora (a volte però di trementina o comunque gradevole); foglie lungamente picciolate a contorno ovato e con ghiandole puntiformi, le cauline 1-2-3 pennatosette a divisioni lineari; fiori tutti tubulosi giallastri o rossastri, piccoli, riuniti in capolini numerosi, globosi (2-3 mm di diametro) e penduli sul pedicello a formare una pannocchia rada ed eretta; hanno involucro pubescente e biancastro (da cui l’epiteto specifico “alba”) a squame largamente scariose e il ricettacolo a pelosità breve.
Habitat: prati e incolti sassosi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale: nuovi ritrovamenti: sopra Cantagallo (campione in Erbario PARSEC, PO).
- Calvana: Fiori 1914 (sub A. canphorata); Foggi & Venturi 2009: praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano; oss. Jacopo 2020 Wikiplantbase#Toscana: presso Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub A. canphorata); Messeri 1936 (sub A. saxatilis W. & K.); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 1999 (sub Jenepì del Monteferrato); Biagioli & al. 2002 (su serpentino e gabbro).
- Monte Le Coste e Poggio alla Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Artemisia annua L. ASSENZIO ANNUALE
T scap – Neofita invasiva di origine Eurasiat. - VII-X – Poco frequente, ma in espansione.
Erbacea assai ramificata, annuale e fortemente aromatica; è alta da 50 a 150 cm; le foglie, verdi su ambedue le facce, sono lunghe 3-4 cm e 2-3 pennatosette a segmenti terminali sottili; i fiori tubulosi, gialli, di 1,5 mm di diametro, sono riuniti in numerosi capolini penduli a formare una pannocchia fogliosa.
Habitat: tende a invadere incolti erbosi su terreni sabbiosi o sassosi e zone ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: nuovi ritrovamenti: via della Torretta a E di Filettole (2024) (Prato).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: cassa di espansione dell’Ombrone (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la Fattoria di Javello (2019); assai comune sulla strada bianca dalla Bicchieraia alla Fattoria di Javello (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: presso Carmignano.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: viale Galilei in incolto al margine della ciclabile, nell’alveo del Bisenzio sempre a livello di viale Galilei e a S di Gonfienti (2023), via S. Martino per Galceti tratto a Est di V. Fr. Cervi sul marciapiede (2024) (Prato), argine dell’Ombrone presso Ponte Manetti (2022) (P. a Caiano).
-Artemisia verlotiorum Lamotte Lamotte ARTEMISIA DEI FRATELLI VERLOT
H scap/G rhiz – Neofita fortemente invasiva originaria dell’Asia Orientale – X-XI – Comunissima.
Erbacea fortemente aromatica, con fusto eretto e assai ramificato, alto fino a 2 m; la radice è dotata di stoloni orizzontali striscianti da cui originano numerosi fusti; le foglie, verdi di sopra e puntellate di ghiandole sessili biancastre, di sotto appaiono bianco-tomentose, sono larghe 4-6 mm ed hanno segmenti interi; i piccoli capolini (pendenti all’antesi) sono per lo più arrossati e riuniti in pannocchia compatta e unilaterale.
Habitat: incolti, radure e margini boschivi, argini di specchi e corsi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Fonte del Romito e dintorni (2018) (Vernio) e sicuramente anche altrove.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: anche su serpentine (Prato, Montemurlo); Arrigoni & Viegi 2011.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: praticamente su tutto o quasi l’alveo del Bisenzio a Prato (2023).
NB: i “fratelli Verlot” sono due botanici francesi dell’800, a cui è dedicata questa pianta, che ha quasi soppiantato in Italia la specie indigena A. vulgaris (la successiva), con la quale condivide analoghe esigenze ecologiche.
PS: sicuramente la pianta è più diffusa delle segnalazioni di cui sopra.
-Artemisia vulgaris L. ASSENZIO SELVATICO
H scap – Circumbor.- VII-X – Ormai abbastanza rara.
Erbacea alta 50-200 cm, di aspetto simile a A. verlotorum, da cui si distingue con una certa difficoltà: la nostra è pianta cespitosa, con radice principale breve e ad andamento obliquo da cui originano 1 o più fusti; le foglie non sono aromatiche se sfregate e non hanno ghiandole sessili sulla faccia superiore ed i segmenti di I° ordine di quelle superiori sono inciso-dentati; i capolini generalmente non sono arrossati e la pannocchia da essi formata è più diffusa e non unilaterale; inizia inoltre a fiorire un po’ più precocemente (già a luglio).
Habitat: incolti, aree ruderali, zone presso specchi o corsi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: a N P. Cupola (a S de Le Soda) (2018), sopra Montepiano, Passo della Crocetta (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine: Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: laghetto di Galceti… ex-cave su terreno di riporto (Prato, Montemurlo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: Foggi & Venturi 2009: stagno della Dogaia e sul Bisenzio a SW di Gonfienti.
NB: le artemisie sono costituenti indispensabili del vino liquoroso denominato vermut e creato in Piemonte nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano.
PS: la pianta appare in regresso sul nostro territorio (e non solo).
Il genere Asteriscus,
mediterraneo, consta di poco meno di una decina di specie (1 sola in Italia). Le piante hanno fiori tubulosi e ligulati dello stesso colore giallo, foglie a lamina indivisa.
Foto di M. Ziletti
??-Asteriscus aquaticus (L.) Less. ASTERISCO ACQUATICO
T scap – Medit. - IV-VII – Assai dubbia presenza nel Pratese.
Erbacea che ricorda Pallenis spinosa (L.) Cass. (vedi), dalla quale si distingue per avere i capolini avvolti da evidenti brattee fogliose non pungenti; è alta 10-40 cm, con fusti che si dividono dicotomicamente in alto, foglie oblunghe (fino a 6 cm), le cauline sessili e abbraccianti; capolini solitari a fiori gialli, tubulosi al centro e ligulati (brevi) alla periferia.
Habitat: incolti, zone umide e sabbiose soprattutto presso il mare.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Asterisco Acquatico): AMPIL del Monteferrato: non più ritrovato!
Il genere Bellis
conta poco più di 10 specie a distribuzione paleotemperta (4 in Italia con 2 sottospecie), deriva il nome dal latino a causa della particolare bellezza dei fiori delle sue specie. E' costituito da piante erbacee perenni o annuali, caratterizzate da fusto eretto, foglie per lo più spatolate e quasi sempre solo basali; capolini terminali e solitari, formati da fiori ligulati esterni disposti su un solo rango e fiori tubulosi interni e gialli, involucro a segmenti disuguali, disposti su due ranghi e ricettacolo conico e privo di scaglie.
-Bellis annua L. PRATOLINA o MARGHERITA ANNUALE
T scap – Medit.-Macarones. - XI-VI – Rara e localizzata.
Erbacea a dimensioni inferiori rispetto alle due specie congeneri del nostro territorio (alta 4-8 cm raramente di più), si caratterizza per le foglie che non sono solo basali, ma presenti anche in basso sul fusto e con il lembo all’estremità superiore crenulato-dentato.
Habitat: zone erbose assolate e più “calde” delle altre due specie congeneri.
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: Stampi 1967: zona chiamata "Le Risaie" (Prato); non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano: Prato Rosello; 2 oss. Roma-Marzio 2017 Wikiplantbase#Toscana: lungo il sentiero per Prato Rosello (Carmignano); 3 oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: Prato Rosello.
-Bellis perennis L. PRATOLINA o MARGHERITA COMUNE
H ros – Circumbor. - I-XII – Comunissima e diffusa.
Erbacea a dimensioni intermedie fra le specie congeneri del nostro territorio (alta 5-15 cm), si caratterizza per le foglie solo basali e in rosetta, i capolini con diametro max. fino a poco più di 2 cm, squame dell’involucro lunghe 3-5 mm e le foglie interne con picciolo evidentemente delimitato dal lembo.
Habitat: prati, incolti, margine di coltivi (in genere più sinantropica delle altre due specie congeneri).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano (Somm. herb.) (Vernio); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al 2002: Acandoli (Cantagallo); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra Orientale (Cantagallo); Gestri 2018: Cantagallo e Vernio; nuovi ritrovamenti: da Montepiano (Vernio) a strada per Luciana (curiosamente a capolino piccolo e stelo assai allungato) e sopra Montecuccoli verso Le Soda (2022) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub B. p. var. typica e var. meridionalis); Arrigoni & Bartolini; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; 2 oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: M. Buriano (Prato) e tra i Centopini e i Bifolchi.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava di Gello, Parco di Galceti ed altre aree coltivate ed abitate (Prato e Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: GP13 (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello, lungo il Bisenzio, campi nei dintorni di Prato, Montemurlo e P. a Caiano, aree verdi in città ecc… E’ quasi ubiquitaria!
-Bellis sylvestris Cirillo PRATOLINA o MARGHERITA AUTUNNALE
H ros – Medit. - IX-VI – Abbastanza comune.
Erbacea a fioritura autunnale e normalmente pianta in toto più grande delle precedenti (alta 10-30 cm). Le foglie, solo basali, si restringono insensibilmente in un picciolo prima di inserirsi alla base dei fusti; il diametro del capolino si aggira sui 3-4 cm; le squame dell'involucro sono acute; più frequentemente che in B. perennis presenta arrossamento della faccia inferiore dei fiori ligulati.
Habitat: prati, pascoli, margini boschivi, oliveti.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: Bicchieraia (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Ricceri 1993.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S) (Prato, Vaiano): assai diffusa e comune.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: argine Bardena fra Maliseti e Galcetello (2017) (Prato).
Il genere Bidens
è praticamente presente un po’ in quasi tutte le zone del mondo con le sue circa 280 specie. Si tratta di piante erbacee annuali (più comunemente almeno da noi) o perenni, generalmente caratterizzate da foglie opposte, picciolate o sessili, da fiori ligulati raggianti su un solo rango, bianchi o gialli, e spesso ridotti o assenti, e da fiori tubulosi del disco, ermafroditi e di colore da giallo ad arancio; sono riuniti in capolini con ricettacolo munito di pagliette, isolati e generalmente peduncolati; gli acheni sono troncato-allargati alla sommità e sormontati da 2-5 reste con setole rivolte in basso.
-Bidens aurea (Aiton) Sherff FORBICINA DORATA
H scap – Esotica naturalizzata di origine C-Americ. - X-XI – Rarissima
Erbacea assai appariscente e che vegeta spesso in colonie numerose; ha fusti eretti di 40-170 cm e ramificati in alto; foglie lineari-lanceolate e irregolarmente dentate, a volte divise in segmenti lineari e acuminati; capolini a scaglie involucrali da ovate a lanceolate e con 5-7 fiori ligulati raggianti. bianco-giallastri a volte venati di viola, lunghi 12-30 mm, e brattee involucrali simili fra loro; acheni a 2 reste, lunghi 4-7 mm, cuneiformi a margini non ciliati né spinulosi.
Habitat: ambienti erbosi fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Viegi 2011; non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2016!
-Bidens bipinnata L. FORBICINA BIPENNATA
T scap – Esotica naturalizzata di origine N-Americ. - VII-IX – Rara.
Erbacea alta 30-80 cm con fusto eretto a sezione quadrangolare; foglie con piccioli di 2-5 cm, a contorno ovato, picciolate e 2 pennatosette a lobi da rombici a lanceolati; capolini più lunghi che larghi (5-10 mm) con 3-5 ligule brevi, biancastre e poste all'esterno, i tubulosi centrali, da 10 a 20, ermafroditi, da giallastri a biancastri; gli acheni esterni lunghi ca. 1 cm sono fusiformi, gli interni più lunghi (ca. 14 mm), lineari e dotati di 3-4 reste.
Habitat: zone incolte, ruderali, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Pianura: alveo del Bisenzio presso Ponte al Mercatale (2024) (Prato).
NB: si incontra, anche abbondante, in molte zone limitrofe al territorio pratese: Monsummano, Calvana di Firenze, M. Morello, nel Pistoiese!
-Bidens connata Muhl. ex Willd. FORBICINA SALDATA
T scap – Neofita invasiva cosmop. - VIII-X – Rara e localizzata.
Erbacea alta 30-150 cm, a fusto ascendente o eretto; foglie da ellittiche a lanceolate da intere a 1-pennate; capolini isolati o a 2-3 su peduncoli di 10-40 cm o più; fiori del raggio spesso assenti o pochi; fiori del disco numerosi (20-40 o più) da giallo pallido ad aranciati; acheni nerastri, brunastri o violacei ± a 4 angoli di cui 2 acuti e 2 ottusi, tubercolati e con 2-4 reste spinulate.
Habitat: zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: PG13: alla Nave sulle sponde dell’Arno.
-Bidens cernua L. FORBICINA INTERA
T scap – Circumbor. - VII-IX – Rarissima, forse scomparsa nel Pratese.
Erbacea a fusto eretto, alta 10-100 cm, che si caratterizza per le foglie, lineari-lanceolate, sessili (a volte connate) e tutte indivise (margini da dentellati a interi); capolini solitamente penduli almeno alla fruttificazione, solitari o in corimbo, dotati di un involucro emisferico; brattee fogliacee e riflesse; ligule da 6 a 8 o assenti, giallo-aranciate; fiori tubulosi del disco da 40 a 100, giallastri; acheni cuneati, appiattiti o a 4 angoli (2 acuti e 2 ottusi), di 6-8 mm con 3-4 reste.
Habitat: zone paludose o comunque umide.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: presso i ristagni d’acqua sul fondo dell’ex-cava di Pian di Gello; Arrigoni e Viegi 2011.
-Bidens frondosa L. FORBICINA PEDUNCOLATA
T scap – Neofita inasiva di orig. N-Americ. - VII-IX – Comunissima nelle aree umide.
Erbacea, alta 30-150 cm, con fiori ligulati quasi sempre assenti e tubulosi gialli-aranciati in numero di 20-60 o più e che si caratterizza soprattutto per le foglie superiori divise in tre segmenti lanceolati, di cui il centrale è portato da un peduncolo allungato (anche fino alla metà della lamina), per i capolini con involucro a squame brevi e non raggianti (le esterne in numero inferiore a 10) e il frutto, un achenio appiattito, bruno-nerastro ad apice concavo e con 2 reste.
Habitat: zone umide, fossi, alvei di corsi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale Pratese: nuovi ritrovamenti: presso Fonte del Romito (2020) (Vernio); strada dal lago Verde (Cantagallo) a S. Ippolito (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato. Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Foggi & Venturi 2009: zone umide.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: PG13b (C/S).
- Pianura: Caruel T., 1860-1864: nei fossi presso la strada ferrata di Prato; nuovi ritrovamenti: alveo del Bisenzio a Prato (2023) e dell’Ombrone presso P. a Caiano (2023).
NB: questa specie esotica a rapida diffusione sembra essere arrivata nel territorio toscano “in treno”, avendola Caruel trovata, per la prima nella nostra Regione nel 1849, “nei fossi lungo la strada ferrato di Prato”. In Lombardia sembra si sia diffusa a partire dall’orto botanico in cui era coltivata già nella prima metà dell’’800.
-Bidens tripartita L. subsp. tripartita FORBICINA COMUNE
T scap – Eurasiat. - VII-X – Non comune e in regresso.
Erbacea a fusto ascendente o eretto, spesso arrossato, alta 20-90 cm; le foglie a denti arcuati sono intere o più spesso tripartite con lobo centrale più grande e a breve peduncolo alato; capolini di 10-25 cm di diametro, con involucro a 5-8 segmenti fogliacei; frutto di 5-8 mm, ± appiattito e liscio con presenza di setole ritorse sul margine e sulle 2(-4) reste sommitali.
Habitat: zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009; Gestri & Peruzzi 2016: presso S. Stefano (Cantagallo), a NE della Briglia (Vaiano)
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 e non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Forbicina): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: rarissima, fossetto presso il torrente la Furba (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: corsi d’acqua e loghi umidi (Prato, Montemurlo).
Il genere Bombycilaena
consta di 3 specie di area mediterranea e asiatica centro-occidentale (2 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali, bianco-cotonose e prive di latice, a fiori solo tubulosi; sono simili alle specie del genere Filago (vedi) dal quale si distinguono per i capolini di forma conica con le brattee dell’involucro (in realtà si tratta di pagliette) piegate in due e saldate ai margini a formare una specie di custodia che racchiude il fiore e il frutto e per gli acheni privi di pappo.
-Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. BAMBAGIA SENZA PAPPO
T scap – S-Europ-S-Siber. - V-VII – Poco comune.
Questa erbacea appartiene ad un genere simile a Filago e Logfia (vedi), dai quali si distingue - utilizzando il microscopio! - per il fiore femminile che a 2/3 dell’ovaio ha il tubo inserito obliquamente (in Filago e Logfia il tubo si presenta diritto come una prosecuzione dell’ovaio); inoltre in Bombycilaena il capolino ha la forma conica, negli altri due si presenta piramidato o piriforme e gli acheni non sono provvisti di pappo a setole sottilissime come invece negli altri. E’ pianta di dimensioni contenute (4-8 mm a volte fino a 20) coperta da tomento biancastro, a fusticino eretto; le foglie sono sessili, alterne ed eretto-patenti, di forma oblanceolata più o meno sottili e ad apice ottuso; i capolini – a fiori solo tubulosi e con squame involucrali in 2 serie – sono raccolti in glomeruli (terminali o laterali) sessili, subglobosi e assai lanosi, superati o eguagliati dalle foglie superiori; gli acheni (inferiori a 3 mm) appaiono obovati, compressi, un po’ ricurvi e privi di coste e pappo.
Habitat: terreni poveri e preferenzialmente calcarei.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: presso Poggio Roncomannaio; nuovi ritrovamenti: presso il Santo; sentiero 58 Cai da Gorandaccio a P. Mezzana (2014), sopra Cavarzano e verso l’Alpe omonima (2017) (Vernio).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Micropus erectus); Arrigoni e Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1036 (Micropus erectus L. var. typicus Fiori); Biagioli & al. 2002 (sub Micropus erectus L.): dai Sassi Neri alle Porticciole, ed anche atrove nelle aree serpentinose più aride e assolate.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Il genere Buphthalmum
è costituito da una ventina di specie erbacee perenni o suffruticose a distribuzione europea e W-asiatica (2 in Italia). Si tratta di erbacee perenni, abbastanza alte (fino a 70 cm e più), a foglie intere e lanceolate, fiori a fiori ligulati giallo-oro riuniti in 3-4 serie e ricettacolo con pagliette, piano o poco convesso, riuniti in capolini numerosi; acheni con pappo ridotto.
?-Buphthalmum salicifolium L. s.l. ASTERIODE SALICINA
H scap – Orof. SE-Europ. - V-IX – Rarissima o scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea pubescente a fusto eretto e ramoso, alta 40-60 cm; le foglie sono sessili (semiabbraccianti), alterne, lanceolate, acute e dentellate; i capolini solitari, del diametro di 3-6 cm e con peduncolo lungamente nudo, hanno fiori ligulati del raggio gialli, su una sola serie e larghi 2-3 mm e i tubulosi del disco ermafroditi e di colore giallo-aranciato; l’involucro presenta squame ad apice rivolto in fuori; acheni glabri, di 3-4 mm, con pappo ridotto.
Habitat: pendii assolati soprattutto in collina o montagna e su suolo calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Asteriode salicina): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: anche su terreni derivati da serpentine, in pineta chiara (Sassi Neri, Le Croci).
NB: non più ritrovato!
Il genere Calendula
ha distribuzione euro-mediterranea ed è costituito da ca. 12 specie erbacee annuali o perenni, alcune coltivate (5 in Italia). Si presentano a foglie alterne, indivise, a volte dentellate; i fiori ligulati (gialli o arancioni) periferici e disposti su due ranghi sono femminili e i centrali tubulosi (di vario colore a seconda della specie) e funzionalmente maschili, si riuniscono a formare capolini peduncolati, con involucro a squame lineari ed acuminate, disposte in 1-2 ranghi e ricettacolo nudo; l’achenio è privo di pappo, e di morfologia variabile in generale ± rostrata e arcuata (gli esterni arcuati e a dorso spinuloso, gli interni ± anulari spinulosi o meno).
-Calendula arvensis (Vaill.) L. FIORRANCIO, CALENDULA DEI CAMPI
T scap (H bienn) – Euro-Medit. - I-XI – Comune.
Pianta erbacea alta 10-40 cm e che fiorisce quasi tutto l’anno; ha fusto ascendente o eretto e ramoso, foglie oblungo-lanceolate, dentellate e sessili (o abbraccianti); i fiori - gli esterni raggiati ligulati, di colore giallo e disposti in 1 sola serie, e gli interni tubulosi di colore giallo-aranciato - sono riuniti in capolini terminali di 2-3 cm di diametro; acheni di tre forme: gli esterni rostrati, i medi a forma di barchetta e gli interni anulari.
Habitat: prati, campi ed incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra S. Quirico di Vernio.
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Biagioli & al. 2002: nelle zone marginali (non ritrovata da Messeri 1936!).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: assai diffusa negli incolti e soprattutto a margine di coltivi.
NB: è specie medicinale con azione antiflogistica, astringente, detergente ecc. Ottima in pomata sulla cute come emolliente ed inoltre per il trattamento di punture di insetti e meduse. E’ considerata lo zafferano dei poveri, in quanto i suoi capolini possono essere adoperati nella preparazione di risotti quando non ci si può permettere la più pregiata spezia.
PS: il polimorfismo degli acheni permette modalità diverse di dispersione del seme.
-Calendula officinalis L. FIORRANCIO COLTIVATO
H bienn (T scap) – Archeofita a volte naturalizzata di orig. medit. – VI-XII – Raro.
Erbacea simile alla precedente, dalla quale si distingue, oltre che per essere spesso pianta bienne (fusto lignificato alla base), per le dimensioni generali maggiori (altezza 10-70 cm, diametro capolini 30-50 cm) e per il colore dei fiori ligulati più scuro-aranciato e disposti in 2 o più serie; inoltre gli acheni periferici sono tutti, o quasi, alati.
Habitat: può presentarsi da noi sia come pianta coltivata, sia come occasionale sia, a volte, come naturalizzata in ambienti aperti e assolati in area mediterranea o submediterranea.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: nuovi ritrovamenti: a Collisassi (Vaiano), dove sembra naturalizzata.
PS: sicuramente è più diffusa di c.a. e capita talvolta di osservarla in giardini privati nei centri abitati e non.
Il genere Cardus
conta poco meno di un centinaio di specie a distribuzione soprattutto euroasiatica e mediterranea (22 in Italia con diverse sottospecie); è costituito da piante erbacee perenni (in maggioranza) o annue, per lo più spinose, a foglie sessili, alterne e quasi sempre divise; i fiori ermafroditi sono tutti tubulosi (spesso violacei) e riuniti in capolini di dimensioni variabili, con involucro a diverse serie di squame spinose, ricettacolo con pagliette o setole; il frutto è un achenio con pappo di setole semplici. Si distingue dall'affine genere Cirsium soprattutto per le setole del pappo dentellate, scabre e non piumose.
-Carduus nutans L. subsp. nutans CARDO ROSSO
H bienn – W-Europ. - VI-VIII – Comune.
Erbacea robusta, alta dai 20 cm al metro; presenta capolini solitari, abbastanza grandi (fino a 5 cm di diametro) e quasi sempre reclinati, le squame dell'involucro (emisferico od ovato) largamente lanceolate (2-4 mm) ed acuminate, le foglie pennato-partite lunghe 8-30 cm a 6-8 paia di lobi laterali, assai spinose e non o poco ragnatelose.
Habitat: incolti, prati, pascoli o radure assolate e aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Gorandaccio a Montepiano (2022) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Cantagallo.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: poche piante sulle serpentine presso la cima di M. Chiesino (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Carduus pycnocephalus L. CARDO SAETTONE
H bienn (T scap) – Medit-Turan – IV-VII – Molto comune.
Erbacea annuale o bienne, alta da 20 a più di 100 cm; presenta un fusto alato (ad ali spesso interrotte) e dotato di spine robuste; le foglie da oblunghe ad oblanceolate a 2-5 lobi palmati con spina apicale e bianco-tomentose di sotto; i capolini sono più piccoli della specie precedente (1,5-2 cm di diametro), di forma ovoide-oblunga, solitari o aggregati in 2-3, con involucro a squame ghiandolose e fortemente arcuate in fuori; acheni di ca. 5 mm, compressi, con pappo di 10-14 mm.
Habitat: incolti, aree ruderali e margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra il Gorandaccio (2023) (Vernio); da Fabbro a Migliana, al Tabernacolo di Gavigno (2018) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Cardo Saettone): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano. P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub C. p. L. subsp. pycnocephalus) (C/S).
Il genere Carlina
conta una trentina di specie erbacee e spinose, distribuite in Europa e Asia occidentale. Le sue piante si presentano con foglie divise, alterne e/o basali in rosetta, infiorescenza a capolini isolati o pochi, con involucro a brattee involucrali interne raggianti, spesso colorate (aspetto di fiori ligulati), coriacee e spinose, ricettacolo con setole laciniate in alto e fiori tutti tubulosi e simili fra loro; gli acheni, pubescenti, presentano un pappo a setole poste su un solo rango.
NB: il nome deriverebbe da “Carlo” Magno che sembra utilizzò piante di questo genere per curare i suoi soldati contagiati dalla peste (ovviamente senza successo!!).
-Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. CARLINA BIANCA CAULESCENTE (223)
H ros – Orof. S-Europ. - VI-IX – Poco comune e solo in montagna.
Erbacea alta da 10 a 60 cm, caratterizzata dalle squame involucrali esterne ben evidenti, fogliacee, lunghe fino a 10 cm da sembrare veri e propri fiori ligulati anche per il colore bianco, le interne sono inferiori ai 3 cm di lunghezza; i fiori tubulosi sono di colore purpureo; il fusto è monocefalo; le foglie lunghe fino a 30 cm e a volte di più, bi-pennatosette a lobi dentato-spinosi, ragnatelose o pelose almeno di sotto, sono tutte basali nella subsp. nominale, al contrario nella subsp. caulescens le foglie sono presenti su un caule lungo fino a 40 cm.
Habitat: prati e pascoli sopra i 700 m ca..
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Acandoli, Roncomannaio (2022); M. delle Scalette (2024) (Cantagallo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
NB: la subspecie nominale è presente nelle Regioni d’Italia dalla Toscana verso nord.
PS: i capolini immaturi si possono utilizzare a fini alimentari (escludendo le parti spinose) come i carciofi. La pianta essiccata è considerata decorativa e da alcune parti d’Italia è stata utilizzata come igrometro naturale: le brattee esterne si aprono o chiudono sul ricettacolo a seconda del grado d’umidità ambientale.
-Carlina corymbosa L. CARLINA RAGGIO D’ORO
H scap – Medit. - VII-X – Abbastanza comune.
Erbacea a fusto eretto o ascendente, spesso ramificato, alta 10-60 cm; foglie coriacee con le inferiori picciolate e le altre sessili e abbraccianti, hanno contorno lanceolato e si presentano pennato-partite con ca. 4-5 paia di lobi dotati di spine apicali e con aculeo terminale; i capolini (diametro 1,5-2 cm e, comprendendo le brattee esterne, fino a 4 cm) sono riuniti da 2 a 5 in corimbo: hanno fiori tubulosi gialli al centro circondati dalle brattee involucrali giallo-dorate sulla faccia superiore (un po’ porporine di sotto) patenti e raggianti, larghe 2-3 mm.
Habitat: zone erbose e sassose aperte.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: strada per Gavigno (2019) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1987; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Carlina Raggio d’Oro).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub C. c. L var. typica Fiori); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello.
??-Carlina nebrodensis Guss. ex DC.
Si trova indicata in Baroni 1897-1908: Montepiano (Somm. herb.). E’ stata esclusa la presenza di questa specie in tutta la Toscana ed in tutto il N-Italia: è da riferire a C. vulgaris.
-Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris CARLINA COMUNE
H scap - Eurosiber. - VI-IX – Non molto comune.
Erbacea alta 20-60 cm, a fusto cotonoso, eretto, ramoso, foglioso e terminante in più capolini isolati sui peduncoli; le foglie, sessili o subabbraccianti le cauline e picciolate le basali, appaiono di forma lanceolata, sinuate, dentate e spinose; i capolini (2-4 cm di siam.) sono in genere solitari all’apice dei rami costituiti da soli fiori tubulosi giallo-paglierini a volte arrossati e circondati da un involucro di squame più sottili (larghe ca. 1 mm) e di colore giallo-pallido o biancastro sopra e sotto (questi ultimi due sono i principali caratteri distintivi rispetto a C. corymbosa).
Habitat: radure e margini boschivi, zone erbose da noi più frequentemente sopra i 500 m e più.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Montepiano al Gasperone, dall’Alpe di Cavarzano alla Scoperta (2019) (Vernio); sentiro 00 sopra Acandoli, da Migliana alle Cavallaie (2018) (Cantagallo-Montemurlo); M. delle Scalette (2024) (Cantagallo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: boschi a N della Fattoria di Javello (rara) (2022).
- Monteferrato: Messeri 1936 (trovato da lei e in herb. Levier); Biagioli & al. 2002 (più rara di C. corymbosa): strada per ex-cava Guarino (Montemurlo); falde meridionali del M. Chiesino (Prato).
Il genere Carthamus
conta una quarantina di specie a distribuzione mediterraneo-asiatica (7 in Italia). Si tratta di piante con spine su frutto e foglie, fusto non alato, con capolini multiflori tubulosi gialli (o purpurini), avvolti dalle foglie superiori, ma con squame involucrali non raggianti e floriformi (come in Carlina), le interne intere, il ricettacolo dotato di scaglie e il pappo costituito da squame lineari.
-Carthamus lanatus L. ZAFFERANONE SELVATICO
T scap – Euro-Medit. - VI-VIII – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, ramoso, peloso-ragnatelosa (“lanatus”!), alta 30-60 cm; le foglie basali si presentano in rosetta, picciolate e lirate e le cauline alterne con le superiori sessili, sinuato-pennatifide, dentate e dotate di spine robuste; i capolini, terminali ai rami e solitari, hanno un diametro di 20-30 cm, con soli fiori tubulosi gialli, e circondati dalle foglie superiori; acheni quadrangolari, con pappo (assente nei periferici) costituito da piccole scaglie alternativamente lunghe e brevi.
Habitat: incolti sassosi, aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: dal Gorandaccio a Montepiano (2020) (Vernio); sopra Fabbro verso Migliana (2021) (Cantagallo).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Zafferanone selvatico): AMPIL del Monteferrato; Foggi & Venturi 2009.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: soprattutto su vers. E M.Chiesino e Galceti (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Il genere Centaurea
è piuttosto complesso dal punto di vista sistematico, anche per la facilità all’ibridazione delle sue specie. Per quanto riguarda la distribuzione si tratta di un genere eurasiatico composto da ca. 500 specie diverse (in Italia circa 110 con moltissime sottospecie!). I caratteri distintivi delle varie entità vanno ricercati soprattutto nell’aspetto delle squame involucrali e in secondo luogo in quello delle foglie. Si tratta di erbacee annuali o perenni, a volte spinose; le foglie sono alterne, indivise o pennatosette; i fiori sono tutti tubulosi: gli esterni generalmente sterili, più grandi e raggianti, i centrali ermafroditi e più piccoli; essi sono riuniti in capolini all’apice di peduncoli, spesso sono numerosi, a volte unici; il ricettalo è dotato di setole; l’involucro è coperto di squame in più serie, che sono sormontate da un’appendice di vario aspetto, spinosa o ciliata e con un bordo membranoso, raramente intero, per lo più ciliato; il frutto è liscio, oblungo e compresso, glabro, in più serie e inserito lateralmente.
PS: il nome per alcuni autori è di derivazione mitologica: sembra infatti riferirsi al “centauro” Chirone, esperto cultore e maestro di medicina e di piante officinali.
-Centaurea aplolepa Moretti subsp. carueliana (Micheletti) Dostál FIORDALISO DI CARUEL
H scap – Endemismo ital. (del serentino) – VI-VIII (rifioriture autunnali) – Localizzato al Monteferrato.
Erbacea ispida a fusti di 30-70 cm, eretti o ascendenti, ramificati alto; foglie basali lirato-pennatosette scomparse alla fioritura, le cauline sessili, pennatosette e via via ridotte fino alle superiori lanceolto-lineari; capolini 4-5 x 6-8 mm, terminali o all’ascella delle foglie, con squame involucrali scariose o nerastre a caratteristica appendice a margine denticolato (non vere ciglia); fiori a corolla da bianco-rosata a violacea; achenio pelosetto e privo di pappo.
Habitat: praterie su roccia serpentinosa.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato di Prato e Montemurlo: Caruel 1860-64 [sub C. paniculata Lam. (Sant.)]; Micheletti 1891 e Baroni 1897-1908 [sub C. paniculata L. forma carueliana Micheletti (Car. in Micheletti III)]; Fiori 1914 e Messeri 1936 (sub C. paniculata L. var. carueliana Michel.); Arrigoni & al. 1983; Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & al. 1999; Biagioli & al. 2002; Ricceri 2002; Arrigoni 2003, Ricceri 2006 (sub C. paniculata L. subsp. carueliana (Micheletti) Arrigoni); Foggi e Venturi.
NB: il Monteferrato rappresenta il Locus Classicus di questa entità, ovvero il luogo in cui è stata ritrovata e descritta per la prima volta come C. paniculata L. var. caueliana da Micheletti.
Ai Renai sul M. Le Coste è presente una Centaurea che ricorda fortemente paniculata L. e che nel lavoro Gestri & Peruzzi 2013b abbiamo indicato col nome di c.s., ma si tratta di una entità che sarebbe utile indagare più approfonditamente.
-Centaurea arachnoidea Viv. subsp. montis-ferrati Ricceri, Moraldo & F.Conti FIORDALISO DEL MONTEFERRATO
H scap – Endemismo ital. (del solo Monteferrato) – VI-VIII (rifioriture autunnali) – Localizzata.
Erbacea a fusto eretto, ramoso, alta 10-40 cm; foglie a pelosità simile alla tela del ragno (“aracnoidea”) almeno da giovani, le basali ed inferiori divise il lacinie lanceolate sottili (lunghe fino a 20 cm o più) con la superiore più larga a losanga allungata; capolini del diametro fino a 3 cm su peduncoli allungati e afilli; squame involucrali ciliate (ciglia inferiori al mm) e le inferiori con acuta spina patente alla sommità; i fiori appaiono di colore giallo brillante; gli acheni grigiastri sono lunghi da 2 a 4 mm con pappo poco più breve (nella nostra sottospecie).
Habitat: ambienti rupestri su terreno ofiolitico (più frequente nelle radure di pineta a mezzombra che in pieno sole).
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Caruel 1860-64 (sub C. rupestris L.); Fiori 1914 (sub C. rupestris var. adonidifolia); Messeri 1936 (sub C. rupestris L. var. adonidifolia Rchb.); Arrigoni & al. 1983 (sub C. rupestris L.); Ricceri 1998 (sub C. rupestris L.); Biagioli & al. 1999 e Biagioli & al. 2002 (sub C. rupestris L.); Ricceri 6 al. 2006 (sub C. rupestris L.); Boracchia & al. 2008; Conti & al. 2011.
PS: come si nota anche di sopra, prima della descrizione di questa nuova sottospecie (Conti & al. 2011), la nostra è stata chiamata da tutti gli Autori C. rupestris L.. La differenza fra le due entità (appartenenti per altro allo stesso gruppo!) è assai sottile: si basa sulla lunghezza del pappo (sensibilmente inferiore all’achenio in rupestris e poco più breve o più lungo in aracnoidea), sul tomento fogliare di tipo aracnoideo (o glabrescente) e la lughezza delle ciglia delle squame involucrali di 0,9-1 mm in aracnoidea.
-Centaurea arrigonii Greuter FIORDALISO DI ARRIGONI
H scap/H bienn – Endemismo dell’Italia centrale – V-VII – Poco frequente, localizzata.
Solo di recente è stata accertata la sua individualità sistematica. Erbacea scabra e pubescente (non sempre), a fusti eretti e ramificati, con capolini piccoli (involucro del diametro di 7-10 mm) e ± numerosi, alta 10-70 cm; si caratterizza per le foglie, basali e cauline, 1-2 pennatifide lunghe fino a 10 cm a lacinie lineari acute e mucronate (le superiori a volte intere), e soprattutto per l’aspetto delle appendici delle squame involucrali con parte indivisa e cigliare (mucrone apicale e 4-5 ciglia per lato profonde fino a 2 mm) concolore nera.
Habitat: pendii e zone marginali erbose soprattutto sopra una certa quota.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002 (sub C. intermedia Fiori): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Ricceri 2002 (sub C. dissecta Ten. var. intermedia Fiori): monti a N di Prato; Venturi 2006: unica stazione tra P. Roncomannaio e M. delle Scalette; Ricceri 2006: monti a N. di Prato; Foggi & Venturi 2009: Monti a N di Prato; Gestri 2018: Vernio, Cantagallo; nuovi ritrovamenti: sopra Cantagallo, strada fra Luciana e Cavarzano (2017) (Vernio).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini e Ricceri 2002 (sub C. dissesta Ten. var. intermedia (Micheletti) Fiori); Ricceri 2006: Calvana; Foggi & Venturi 2009: praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
-Centaurea calcitrapa L. CALCATREPPOLA (
H bienn – Subcosmop. - VI-VIII – Poco comune, localizzata.
Erbacea spinosa a fusti prostrato-ascendenti e assai ramificati-divaricati, alti 20-100 cm; le foglie radicali sono pennatopartite, le cauline rudi, pennatosette a lobi sottili e punta subpungente; capolini (diametro 6-10 mm) numerosi, ascellari-subsessili o terminali-peduncolati; involucro ovoide o piriforme con squame terminate da una spina robusta e con alla base spinule più piccole; fiori porporini; achenio di ca. 3 mm privo di pappo e di colore biancastro.
Habitat: incolti e praterie aride e sassose.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Ricceri 2002: Calvana; Ricceri 2006: Calvana e colline a N di Prato; e Foggi & Venturi 2009: praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano; oss. Cataldi 2019 Wikiplantbase#Toscana: presso Case Nuove di Valibona (Vaiano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava di Gello (Prato).
-Centaurea cyanus L. FIORDALISO VERO
T scap – Archeofita di origine Medit. - V-VII – Rara e in regresso.
Erbacea a fusto ascendente e ramificato, pubescente e grigiastro, alta 20-80 cm; le foglie hanno forma da lanceolata a lineare e appaiono intere o dentate, le inferiori a volte sono lobate (a lobi sottili); i fiori sono di un bel colore violaceo o azzurro carico (raramente biancastri o porporini) gli esterni più grandi e patenti. Si riuniscono in capolini solitari (di 1,5-3 cm di diametro) su peduncolo lungamente afillo; le squame involucrali hanno bordatura ciliata (ciglia di ca. 1 mm) brunastra o argentea; acheni di 2-3 mm con pappo rossastro poco più breve.
Habitat: campi di cereali, ma a volte in ambienti ruderali o radure erbose.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Ricceri 2002 e Ricceri 2006: coltivi della Val di Bisenzio; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano sopra il paese.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Fiordaliso): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Riceri 2002 e Ricceri 2006: coltivi del Montalbano, in Gestri & Peruzzi 2013a la specie è stata ritrovata solo al di fuori dei comuni pratesi (Larciano e Serravalle P.).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: poche piante in unica stazione su roccia di serpentino a margine del podere Baylon.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: campi di Solano (S).
NB: si tratta del Fiordaliso per "eccellenza", quello che alcuni decenni fa colorava le messi mature di azzurro con la sua ricca presenza...
-Centaurea deusta Ten. subsp. deusta FIORALISO CICALINO
H bienn – Euro-Medit. - VI-VIII – Poco comune.
Erbacea a fusto eretto e ampiamente ramoso, alta 30-60 cm; foglie pubescenti, le basali picciolate, lunghe fino a 15 cm e 2 pennatosette a lobi lineari, le cauline più piccole, sessili, pennate a lobi ± sottili e mucronati all’apice, quelle sotto il capolino intere e lineari; fiori purpureo-rosati, con gli esterni raggianti e più lunghi; capolini di 1-2 cm di diametro, isolati e terminali sulle ramificazioni, con involucro a caratteristiche squame in più serie sovrapposte, largamente triangolari e convesse verso l’esterno, ialine, membranose e mucronate all’apice, macchiate al centro di bruno-nerastro.
Habitat: prati, incolti, radure ed aree marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: verso Migliana (2020) (Cantagallo), Schignano (2018) (Vaiano).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub C. deusta Ten.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: Ricceri 2002 e Ricceri 2006 (sub C. alba L. subsp. deusta (Ten.) Nyman): colline sopra Bagnolo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Fiordaliso cicalino) AMPIL del Monteferrato.
- Montabano: Baroni 1897-1908: … e Verghereto (Carmignano); Ricceri 2002 e Ricceri 2006 (sub C. alba L. subsp. deusta (Ten.) Nyman): ambienti aridi rocciosi sopra Santa Cristina a Mezzana, al Pinone, Verghereto presso il lago del Chiuso (Carmignano); Foggi & Venturi (sub C. alba L. subsp. deusta (Ten.) Nyman): Montiloni e Verghereto (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub C. splendens L.): in pineta chiara verso Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Ricceri 2002 e Ricceri 2006 (sub C. alba L. subsp. deusta (Ten.) Nyman): Passo del Cerreto (Prato); Gestri & Peruzzi 2013b (sub C. deusta Ten.) (C/S).
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: a N di Schignano (2023).
-Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss. et Reut.) Gremli FIORDALISO STOPPIONE DI GAUDIN
H scap – Orofita S-Europ. - VI-X – Relat. comune.
Erbacea a fusti eretti o ascendenti poco ramificati, alta 30-60 cm; foglie sessili, intere o dentellate da ovate a lanceolate, le superiori più sottili; i fiori, purpureo violacei con gli esterni raggianti, sono riuniti in capolini terminali del diametro di 12-20 mm, ricoperto da squame involucrali in più serie, scariose ad appendice intera o lacero-dentata (mai ciliata), chiare e più scure al centro; acheni grigi e privi di pappo, lunghi 2-4 mm.
Habitat: radure e margini di bosco e di cespuglieti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Ricceri 2002, Ricceri 2006 (sub C. bracteata Scop.): Monti dell’Appennino a N di Prato; Arrigoni & al. 2005 (sub C. bracteata Scop.): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub C. bracteata Scop.): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso Schignano, intorno al lago Galletti (Vernio); a N di Montecuccoli, a Migliana (Cantagallo).
- Calvana: Ricceri 2002, Ricceri 2006 (sub C. bracteata Scop.); Foggi & Venturi (sub C. bracteata Scop.): praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo
- Cascine di Tavola: Stampi 1967: a “le Risaie”, non ritrovata da GL 21.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Fiordaliso ibrido): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Ricceri 2002, Ricceri 2006 (sub C. bracteata Scop.); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub C. j. L. var. vulgaris Coss. et Germ.); Biagioli & al. 2002 (sub C. j. L.): su pietrisco sottile…, soprattutto alle falde meridionali del M. Chiesino (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: questa entità è inserita fra “i gruppi critici”, ovvero fra le entità di cui non è ancora stata chiarita l’esatta collocazione sistematica (in questo caso riguardo le varie sottospecie - se di sottospecie si tratta veramente - che le vengono attribuite). Infatti pur essendo considerata la subsp. angustifolia (DC.) Gremli non presente in Toscana alcune piante da me ritrovate presso il tabernacolo delle Cavallaie (Montemurlo) e a N di Montecuccoli (2019) (Cantagallo) si avvicinano morfologicamente a questa (pianta ben ramificata e con foglie molto sottili).
??-Centaurea nigra L. FIORDALISO NERO
Segnalata per errore al Monteferrato da Arrigoni & al. 1983 e da Biagioli & al. 2002: non sembra neppure essere presente in territorio italiano! Da riferire a C. nigrescens Will. subsp. nigrescens.
-Centaurea nigrescens Willd. FIORDALISO NERASTRO
Si tratta di un'erbacea perenne, a fusto eretto e ramoso, alta 40-100 cm; le foglie, alterne, hanno lamina oblungo-lanceolata e a volte sono dentellate al margine; i fiori tubulosi sono purpurei, più chiari al centro, e riuniti in piccoli capolini di circa 1 cm, con involucro a squame con appendice nerastra in alto e cilata a 6-8 frange per lato (la specie congenere a lei più simile è C. jacea che ha appendice intera o solo un po’ eroso-lacera e chiara, oltre ad avere un fusto poco ramificato!).
- - C. n. Will. subsp. nigrescens
H scap – SE-Europ. - VI-XI – Comunissima.
Si caratterizza per il fusto ramificato, le foglie scabre, a lamina ovato-lanceolata, dentellate o meno e il capolino del diametro di 10-11 mm.
Habitat: aree erbose, marginali, prati.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: Ricceri 2002 (sub C.n. Will.); Ricceri 2006 (sub C.n. Will.): Appennino principale, Acquerino, circondario di Montepiano, Val di Bisenzio; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: da Schignano (2018) (Vaiano) a Migliana (Cantagallo); Fonte del Romito e sopra, Alpe Cavarzano, da Sassetta a Montepiano, da Badia al passo di S. Stefano (2019) (Vernio).
Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1947 (sub C. jacea var. rotundifolia); Gestri & Lazzeri 2021 (sub C.n. Will.).
Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub C.n. Will.); Gestri 2009 (sub C.n. Will.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
Cascine: Gestri & Lazzeri 2021 (sub C.n. Will.).
Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Fiordaliso nerastro): AMPIL del Monteferrato.
Montalbano: Ricceri 2002 (sub C.n. Will.): Carmignano; Ricceri 2006 (sub C.n. Will.); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Fiori 1914 (sub C. vochinensis); Messeri 1936 [C. jacea L. var. vochinensis Bernh. (glabra)]; Arrigoni 2020 (sub C. n. Will. subsp. ramosa Gugler).
Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Pianura: Ricceri 2002 e Ricceri 2006 (sub C.n. Will.): dintorni di Prato; nuovi ritrovamenti: ciclabile di Iolo e di Galcetello e dintorni.
- - C. n. Will. subsp. pinnatifida (Fiori) Dostàl
H scap – Endem. Ital. - VI-X – Rarissima (da ricercare).
Si caratterizza per il fusto poco ramificato e a rami allungati, tomentoso, le foglie del caule pennatifide a lobi sottili ed il capolino del diametro di 6-7 mm.
Habitat: zone erbose.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra il passo di S. Giuseppe (2024) (Vernio).
Monteferrato: Arrigoni 2020 [sub C. n. Will. subsp. vochinensis (W.D.J.Koch) Nyman] (Prato)
Poggio a Caiano: Arrigoni 2020 [sub C. n. Will. subsp. vochinensis (W.D.J.Koch) Nyman].
-Centaurea solstitialis L. FIORDALISO GIALLO
H bienn – Medit. divenuta Subcosmop. - VI-VIII – Non comune.
Erbacea tomentoso-biancastra, a fusto assai ramificato e con branche alate, alta 20-80 cm; foglie scabre e pelose, le inferiori da lirate a pennatifide, le superiori intere-lineari o sinuate, sessili e lungamente decorrenti; fiori gialli su capolini solitari con involucro globoso-cuneato di 7-15 mm di diametro, ed a squame largamente ovate, le mediane terminate da una lunga spina di 10-30 mm e alla base con spinule di ca. 3 mm; acheni di ca. 2,5 mm a pappo più lungo e biancastro.
Habitat: ruderale e di campi e incolti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914; Ricceri 2002; Ricceri 2006; Foggi & Venturi: praterie della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 2006: colline a N di Prato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: non su serpentino, lungo il T. Bardena ed altre zone marginali e coltivi (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: ciclabile Galcetello e sponde del Bardena (Prato).
NB: questa entità spinosa si distingue dalle altre due specie dotate di spine del nostro territorio come segue: da C. calcitrapa semplicemente per il colore giallo dei fiori (porporino-violacea nell’altra) e da C. aracanoidea (a fiori gialli) per il fusto alato e le foglie decorrenti; inoltre nella nostra le spine delle squame involucrali medie sono molto più robuste ed evidenti di quelle delle squame inferiori della centaurea del Monteferrato (che inoltre cadono a maturazione).
-Centaurea triumfettii All. FIORALISO DI TRIONFETTI
H scap – Europ.-Caucas. - VI-VIII – Abbastanza rara e circoscritta.
Erbacea pubescente a caule alto 30-90 cm, eretto o ascendente e poco o non ramificato sopra la metà; foglie fino a 13 cm di lunghezza, almeno da giovani biancastro-tomentose, di forma da lanceolata ad oblunga, le cauline con ali lungamente decorrenti sul fusto; capolini solitari fino a 5 cm di diametro a fiori violaceo-porporini con gli esterni raggianti; involucro di 7-20 mm, da ovato a cilindrico, con squame ad appendice nera o brunastra fimbriata (ciglia da 9 a 15 e lunghe fino a 2,5 mm, maggiori del bordo sottostante); acheni di ca. 4 mm con pappo più breve e a volte assente.
Habitat: radure, scoscesi sassosi, margini boschivi, arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 (sub Cyanus triunfettii (All.) Dostàl ex A.& D. Löve) e Gestri & Peruzzi 2016: rr. sotto M. Maggiore (Vaiano); Arrigoni 2020.
- Colline di Montemurlo: Ricceri 2002 e Ricceri 2006: colline di Montemurlo; nuovi ritrovamenti: Massacorbi (2018).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 [sub Fiordaliso di Trionfetti: C. t. All. subsp. variegata (Lamarck) Dostàl]: AMPIL del Monteferrato.
- ??Monteferrato: Ricceri 2002 e Ricceri 2006; Arrigoni 2020.
Il genere Chondrilla
consta di una trentina di specie di area mediterranea ed eurasiatica (2 in Italia). Si tratta di specie erbacee soprattutto perenni, non spinose, a foglie basali a margini ± dentellati e cauline lineari, alterne e progressivamente ridotte, capolini numerosi a pochi fiori ligulati gialli (da 7 a 15) e con squame involucrali in 1-2 serie; achenio con lungo becco.
-Chondrilla juncea L. LATTUGACCIO COMUNE
H bienn/H scap – Euro-Medit.-S-Siber. - VI-VIII – Comune.
Erbacea bienne o perenne, abbastanza alta (da 40 a 120 cm) con foglie inferiori roncinate o ± incise e le superiori intere, fusti giunchiformi e capolini piccoli e numerosi, ad involucro cilindrico di 3 x 8 mm con 6-12 fiori ligulati gialli; acheni a forma di barchetta con becco sottile e pappo bianco.
Habitat: incolti, prati e margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentrella orientale; nuovi ritrovamenti: strada bianca verso le Cascate del Carigiola (2019), da Fabbro a Migliana, da Usella al Santo (2020) (Cantagallo); da Montepiano verso Gasperone soprattutto in basso (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: ex-Cava di Gello e laghetto Galceti (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: margini stradali a Galcetello e altrove, sponde del Bisenzio qua e là e su molte piste ciclabili (2023) a Prato.
Il genere Cichorium
consta di 6 (7 per altri autori) specie a distribuzione europea (3 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni, a fusto eretto e ramificato, con foglie basali e cauline (alterne), dentate o divise, capolini numerosi a soli fiori ligulati blu-azzurri, con ricettacolo senza pagliette, squame involucrali in 2 serie; acheni con pappo costituito da brevi scagliette.
-Cichorium intybus L. CICORIA SELVATICA
H scap – Cosmop. - VII-X – Comune.
Erbacea perenne a fusto eretto (a volte prostrato) e ramoso, alta 20-120 cm; ha foglie di forma variabile, più o meno profondamente divise, quelle in alto sul caule si fanno intere e abbraccianti; i capolini del diametro d 2-3 cm sono numerosi, peduncolati o sessili; i fiori ligulati sono di un colore azzurro (raramente rosato); gli acheni, di circa 2,5 mm, mostrano un pappo a coroncina di piccoli segmenti ottusi.
Habitat: ruderale, incolti e campi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentrella orientale; Gestri 2018: Vernio, Cantagallo; nuovi ritrovamenti: dall’Alpe a Cavarzano, da Montepiano verso il Gasperonee (2018) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009-Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967: “Le Risaie”; Gestri & Lazzeri 2021.
- Pianura: alveo del Bisenzio qua e là a Prato (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub C.i. L var. maritimum Freyn.); Biagioli & al. 2002: zone marginali (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
PS: si riconosce abbastanza facilmente fra le altre erbe quando sono presenti i fiori a grandi ligule di colore blu. E’ la progenitrice delle numerose varietà orticole di cicoria. Le sue foglie basali giovanili rappresentano uno dei radicchi selvatici più ricercati.
Il genere Cirsium
ha distribuzione olartica e un numero di specie che si aggira sulle 250 (una ventina in Italia). E’ costituito da piante erbacee annue o perenni, quasi sempre spinose e a fiori esclusivamente tubulosi; sono molto simili a quelle appartenenti al genere Carduus (vedi): ne differiscono soprattutto per gli acheni che presentano un pappo costituito da peli piumosi, inoltre spesso i fiori periferici dei capolini sono sterili.
PS: il nome del genere deriva dal greco cirsium = "varice" : si riteneva che queste piante fossero in grado di curare la sindrome varicosa.
-Cirsium acaulon (L.) Scop. CARDO NANO, CIRSIO ACAULE
H ros – Europ.-W-Asiat.-Subatl. - V-VIII – Non comune e localizzato.
Erbacea a fusto brevissimo (max. fino a 15 cm ca.) o nullo, con un solo capolino (raramente 2-3) posto al centro di una rosetta di foglie, lunghe fino a 15 cm, glabre o poco pelose, pennatopartite a lobi con robuste spine (di 2-3 mm) sul bordo; capolino a involucro di ca. 2 cm, ovoide e glabro, con squame lanceolate (le superiori lunghe fino a 20 mm) e acuminato-mucronate; fiori tubulosi porporino-violacei; acheni con pappo di peli piumosi.
Habitat: praterie e radure erbose ed aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano su prato.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub C. acaule Scop.); Gestri 2009 (sub C. acaule Scop.) e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
-Cirsium arvense (L.) Scop. CIRSIO DEI CAMPI, STOPPIONE
G rad – Eurasiat. divenuto Subcosmop. - V-IX – Relat. comune.
Erbacea a radice rizomatosa, fusto eretto, non alato e glabro, alta da 50 a 150 cm; rispetto alle specie congeneri ha capolini (unisessuali) numerosi, piuttosto piccoli (inferiori a 2 cm di diametro) e riuniti in infiorescenze corimbiformi; inoltre le foglie cauline sono sessili e non o poco decorrenti, oblungo-lanceolate, ciliate al margine e spinose; i fiori sono porporini.
Habitat: campi, lungo le strade o a margine dei boschi.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentrella orientale; nuovi ritrovamenti: da Sassetta a Montepiano, da Montepiano al Gasperone e alla Fonte del Romito (2020) (Vernio), strada bianca per le cascate del Carigiola, Alpe di Cavarzano (2019) (Cantagallo).
Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Stoppione): AMPIL del Monteferrato.
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Biagioli & al. 2002: un po' ovunque anche su serpentino (Prato, Montemurlo).
Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Pianura: nuovi ritrovamenti: ciclabile presso Iolo (2022) (Prato).
-Cirsium creticum (Lam.) D'Urv. subsp. triumfettii (Lacaita) Werner CARDO DI TRIONFETTI
H bienn – C-Medit. - VIII-X – Raro.
Erbacea alta 40-200 (o più) cm, a fusto eretto, assai ramoso in alto, spinoso sulle ali fornite dalle foglie lungamente decorrenti; le foglie sono pennatifide o pennatopartite, spinose al margine e biancastro-tomentose sulla pagina inferiore; i capolini hanno involucro ovoide di ca. 1 cm o meno di diametro, con squame involucrali terminate da una punta sottile e pungente, di lunghezza ± uguale al corpo della squama sottostante; i fiori tubulosi sono violaceo-porporini e gli acheni, di ca. 3 mm, giallastri e con lungo pappo. La nostra sottospecie si caratterizza per avere i capolini strettamente agglomerati fra loro (su peduncoli brevissimi o subnulli) in numero di 3-12 terminali alle ramificazioni e le spine delle squame esterne lunghe 1-5 mm, mentre le interne di 4-10.
Habitat: prati umidi, presso corsi o specchi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009-Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Pianura: Caruel 1860-64 (sub C. polyanthemum DC.): a P. a Caiano lungo il canale della Pavoniera. (Amid.); nuovi ritrovamenti: sulla Bardena a Figline (2021) (Prato).
-Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum (= Lophiolepis eriophora (L.) Del Guacchio, Bureš, Iamonico & P.Caputo) CARDO SCARDACCIO
Erbacea cotonosa, robusta, a fusto non alato, ramificato in alto, di 50-150 cm; foglie pennatopartite, bianco-tomentose di sotto, con lobi lanceolati e spinosi, le superiori abbraccianti, con spinule anche sulle facce fogliari; questa specie si caratterizza per i voluminosi capolini (5 cm ed oltre, con involucro di 3-4 cm) globosi, terminali e solitari, con alla base alcune foglie non ricoprenti; per i fiori tubulosi porporino-rossastri e per l’involucro con squame fortemente lanose, le medie e le interne lanceolate-lesiniformi: in alto si presentano con un ampliamento rombico terminato da una spina giallastra di 2-3 mm; il pappo è lungo 2-3 cm.
Habitat: praterie, margini e radure boschive, da noi al di sopra di una certa altitudine (ca. 400 m).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002: Le Barbe presso il ruscello; Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: dal Gorandaccio a Montepiano, da Montepiano al Gasperone (2019), Alpe di Cavarzano, M. della Scoperta (2020) (Vernio), CAI 00 sopra Acandoli e verso la Rasa, Cai 32 sopra Acquiputoli, sotto il Faggione (2019) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
-Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. CARDO ZAMPA D’ORSO
H scap – Orofila S-Europ. - VI-VIII – Rarissima.
Erbacea glabrescente a fusto eretto, non alato, ramificato, alta 50-150 cm; le foglie si presentano pennatopartite o pennatosette (le basali lunghe fino a 50 cm) con una decina di lobi oblunghi, opposti ciliato-spinulosi, le cauline abbraccianti il fusto con due larghe orecchiette; capolini (ca 3 cm) a fiori gialli, reclinati in avanti e riuniti a 2-4 alla sommità di peduncoli lungamente nudi; involucro subgloboso con squame riflesse sulla punta.
Habitat: da noi in radure o faggete chiare di media montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: Vernio (Prato), sentiero dal Passo di S. Giuseppe alla Badia di Montepiano, loc. La Malferra.
?-Cirsium italicum DC. (=Epitrachys italica (DC.) Bureš, Del Guacchio, Iamonico & P.Caputo) CARDO ITALICO
H bienn – SE-Europ. - VII-X – Rarissimo e adesso probabilmente scomparso dal nostro territorio.
Erbacea a fusto eretto alta 20-60 cm, caratterizzata dai fiori roseo-purpurei (raramente bianchi) e dalle foglie brevemente ricorrenti sul fusto (circa la metà dell’internodo), a faccia superiore coperta di spinule setacee di 1-1,5 mm e spine apicali di poco inferiori al mm; inoltre le squame involucrali presentano un callo dorsale carenato brunastro in capolini di 1-1,5 cm di diametro.
Habitat: luoghi umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: su terra di riporto all’ex-cava di Gello (Prato).
-Cirsium tenoreanum Petr. (= Lophiolepis tenoreana (Petr.) Del Guacchio, Bureš, Iamonico & P.Caputo) CARDO DI TENORE
H bienn – Endemismo italiano – VII-IX – Rara.
Erbacea alta 40-90 cm, simile a C. eriophorum (vedi), ma di dimensioni inferiori nei vari organi: capolini col diametro di 3-4 cm e involucro di 2-2,5 (o anche meno), spina apicale delle squame involucrali mediane fino a 3 mm di lunghezza e pappo lungo 14-18 mm; inoltre il tubo della corolla è pari al lembo (in C. eriophorum è più lungo).
Habitat: prati, pascoli, incolti marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2018), sopra il Passo della Crocetta (2020), sopra il Gasperone verso S. Giuseppe (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Mandrioni (Vaiano).
-Cirsium vulgare (Savi) subsp. vulgare Ten. CARDO ASININO
H bienn – Subcosmop. - VI-X – Comune.
Erbacea a fusto alato dotato di aculei di ca. 3 mm, eretto e ramoso, alto 30-100 cm e più; le foglie sono lungamente decorrenti e pennatopartite (le inferiori lunghe fino a 30 cm) con segmenti spinosi; ha capolini del diametro di 4-5 cm, ovoidi, subsessili, con involucro di ca. 3 cm per lo più ricoperto da un feltro di peli biancastri e a squame lineari-lanceolate che si attenuano insensibilmente in una spina di 4-8 mm; fiori roseo-violacei e acheni grigiastri dotati di pappo bianco.
Habitat: luoghi erbosi incolti, zone marginali di strade, sentieri e boschi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Montepiano a Gasperone e a P. di Petto, da Cavarzano all’Alpe (2018) (Vernio), Pian della Rasa, da Migliana a Le Cavallaie (2018) (Cantagallo-Montemurlo); strada dagli Acquiputoli al Faggione di Luogomano (2019) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: si distingue da italicum (con il quale condivide le foglie decorrenti sul fusto con ali spinose ed il colore roseo-purpureo dei fiori tubulosi) per i capolini più grandi e non circondati e superati dalle foglie bratteali, inoltre nel nostro le foglie si presentano molto più lungamente decorrenti.
Il genere Cladanthus
conta 5 specie distribuite in N-Africa e S-Europa (1 in Italia). Si tratta di specie erbacee a fiori ligulati esterni (bianchi e a volte gialli alla base) e tubulosi interni (gialli) che si caratterizzano per il ricettacolo conico dotato di pagliette pungenti e piegate longitudinalmente; si distingue inoltre, soprattutto da Anthemis, genere molto simile e nel quale le sue specie erano incluse fino a pochi anni fa, per i fiori tubulosi, che presentano sulla zona inferiore della corolla un’appendice a sperone che ricopre parte dell’ovario e poi dell’achenio.
-Cladanthus mixtus (L.) Chevall. CAMOMILLA BICOLORE
T scap – Medit. – V-IX – Rarissima.
Si tratta di un’erbacea pubescente e odorosa, a fusto eretto o ascendente, ramoso, alta 10-50 cm; le foglie sessili sono 2 pennatosette (lunghe fino a 8 cm), le superiori pennato-incise; capolini (diametro di 2-2,5 cm) su peduncolo un po’ ingrossato subito sotto, con il ricettacolo conico a pagliette cartilaginee, lanceolato-acute e l’involucro a scaglie applicate e scariose; fiori ligulati periferici raggiati, bianchi e giallastri in basso, i tubulosi gialli prolungati su lato, come si diceva sopra, da un’appendice; acheni molto piccoli (1 mm) e lisci.
Habitat: campi coltivati o incolti erbosi soprattutto su terreno siliceo e sabbioso.
Distribuzione sul territorio:
- Poggio alle Croci: PG13b (S): versante Cerreto.
PS: Baroni 1898-1908 la cita presente “a m. Albano e a San Baronto”; anche Gestri & Peruzzi 2013a la segnalano per il Montalbano, ma solo per la provincia di Pistoia.
Il genere Coleostephus
di area mediterranea conta 3 specie (1 in Italia, più 1 di incerta presenza). Si tratta di specie a fiori ligulati periferici e tubulosi interni, ambedue di colore giallo; è simile sia a Leucanthemum (vedi) - da cui si distingue per le ligule gialle e per gli acheni che in alto presentano una corona prolungata lungamente in linguette - sia a Glebionis (vedi) - da cui differisce oltre che per l’aspetto degli acheni, per le foglie mai profondamente dentellate o crenulate -.
-Coleostephus myconis (L.) Cass. MARGHERITONA GIALLA
T scap – Medit. - III-VII – Abbastanza comune.
Erbacea a fusto eretto, alta da 20 a 50 cm; le foglie, dentato-crenulate, o seghettate (non profondamente), sono semiabbraccianti e di forma obovato-spatulata, le superiori ridotte e oblunghe; i fiori gialli (i periferici lingulati e i centrali tubulosi) sono riuniti in capolini solitari e terminali, del diametro di 2-3 cm; gli acheni sono incurvati, quelli del raggio sormontati da una corona tubulosa grande (e sono sterili), quelli del disco da una corona più piccola con frange all'apice (e sono fertili).
Habitat: incolti erbosi e margine coltivi soprattutto su suolo siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (Limentra orientale).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (Chrysanthemum myconis); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Margherita gialla): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava Guarino (Montemurlo), ex-cava di Gello e podere Baylon (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
PS: il nome scientifico di questa bella e abbastanza comune margheritona gialla, deriva dal greco, coleos = fodero e stephos = corona: corona di foderi (allusione al fatto che gli stami sono ricoperti, come foderati); l’epiteto myconis deriva invece dall’isola greca Mikonos dove si riteneva fosse particolarmente comune.
Il genere Cota
è costituito da una quarantina di specie erbacee annue o perenni a distribuzione euromediterranea (5 in Italia). Le sue specie sono molto simili a quelle del genere Anthemis (vedi), dalle quali si distinguono per il ricettacolo che alla fioritura rimane emisferico (e non si allunga a cono) e per gli acheni che si presentano compressi dorso-ventralmente (tetragoni). Hanno fiori tubulosi interni (gialli) e ligulati alla periferia (gialli, bianchi o a volte mancanti) riuniti in capolini solitari o multipli.
-Cota altissima (L.) J. Gay CAMOMILLA BRUCIA-OCCHI
T scap – S-Europ.-W-Asiat. - V-IX – Non comunissima.
Erbacea alta fino a 1 m (è "altissima" fra le specie del suo genere) con foglie bi- o tri-pennatopartite a segmenti sottili e terminanti in una punta; i capolini hanno i fiori del disco gialli e i fiori ligulati periferici bianchi; il peduncolo fiorale è ispessito sotto il capolino all’antesi e le pagliette del ricettacolo hanno un lungo mucrone (un terzo o più della lunghezza totale).
Habitat: colture di cereali, incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Anthemis cota); Messeri 1936 (sub Anthemis cota L.); Biagioli & al. 2002 (sub Anthemis altissima L.): presso ex-discarica Volpaia (Montemurlo).
- Localizzazioni generiche: Baroni 1898-1908 (sub Anthemis cota L.): Prato (Groves herb.)
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: oss. Gestri 2017 e 2023 Wikiplantbase#Toscana: campi di grano a Bagnolo e Montemurlo; nuovi ritrovamenti: campi di grano a Galcetello (2023), campi di rape a Case Dogali, nel letto del Bardena a Galcetello (2024) (Prato).
-Cota tinctoria (L.) J.Gay CAMOMILLA DEI TINTORI
H bienn/Ch suffr – C-Europ.-Pont. - VI-X – Relat. comune.
Erbacea alta 30-60 cm, a foglie profondamente pennatipartite a segmenti terminali sottili e oblunghi, con capolini a fiori del disco, tubulosi, e del raggio, ligulati, gialli; questi ultimi sono abbastanza brevi e non sorpassano la lunghezza dell'involucro. Il colore giallo dei fiori ligulati e la loro lunghezza contenuta la distinguono dalle altre 2 specie congeneri (a ligule bianche e lunghe più dell’involucro).
Habitat: incolti erbosi, prati, zone ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: passo della Crocetta (2019) (Vernio).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Anthemis tinctoria); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Camomilla dei Tintori): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano. P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Anthemis tinctoria L.): alla Volpaia (Montemurlo), ex-cava di Gello (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b [sub C. t. (L.) J. Gay subsp. tinctoria] (S).
PS: i fiori contengono flavonoidi che tingono i tessuti di giallo; per scopo tintorio è stata utilizzata soprattutto nei paesi anglosassoni, nel resto d’Europa le venivano preferite altre piante che davano una colorazione più vivace e stabile come Reseda luteola e Serratula tinctoria (pur esse presenti nel nostro territorio).
-Cota triumfettii (L.) J.Gay CAMOMILLA DI TRIONFETTI
H scap – S-Europ. - V-VIII – Relat. rara.
Erbacea a fusto eretto, semplice o ramificato, alta 20-70 cm; foglie profondamente 2-pennatipartite; capolini di 2-3 cm con peduncolo non ingrossato al di sotto del capolino stesso, a fiori centrali tubulosi e gialli, i periferici ligulati e bianchi (distinzione più evidente con C. tinctoria in cui sono gialli); ricettacolo convesso con pagliette lanceolate attenuate in una breve punta; acheni piccoli (2 mm) con breve coroncina all’apice.
Habitat: margini e radure boschive aride soprattutto su terreni silicei.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Passo della Crocetta (2020) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano: sopra il Poggetto.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Anthemis triumfettii All.): ex-discarica Volpaia (Montemurlo).
Il genere Crepis
conta circa 200 specie, distribuite soprattutto nell’emisfero boreale (40 in Italia); esso è costituito da piante erbacee annuali o perenni, a fusti per lo più semplici e ramosi, foglie basali e cauline da subintere a più o meno divise, infiorescenza a uno o più capolini con solo fiori ligulati e involucro a segmenti ineguali ed embricati; gli acheni hanno forma cilindrica o fusiforme, spesso ristretti in alto in un becco e con presenza di un pappo (appendice piumosa) bianco o arrossato.
PS: quasi tutte le specie di questo genere sono commestibili a parte tre: C. foetida per il cattivo odore, C. zacintha per le foglie amarissime e C. lacera Ten. (pianta di bassa montagna) perché pianta velenosa. Quest’ultima entità però non è presente nel territorio pratese e rarissima in tutta la Toscana.
Le altre specie sono caratterizzate da un sapore amaro tipico dei radicchi, soprattutto se consumate crude. C. leontodontoides L. è quella che ha sapore più grato.
?-Crepis biennis L. RADICCHIELLA DEI PRATI
H bienn – C-Europ. - V-IX – Rarissima o non più presente.
Erbacea a fusto eretto e scabro (a volte arrossato), alta 30-100 e più cm; le foglie della rosetta sono pennatopartite o pennatifide roncinate e picciolate, quelle cauline si fanno via via più piccole, intere e sessili; capolini numerosi a fiori ligulati gialli lunghi 15-17 mm; involucro piriforme, con squame esterne lanceolato-lineari, patenti ed evidentemente più brevi delle interne; acheni di 4-7 mm, con coste numerose, ma senza becco (talora solo ristretti in alto).
Habitat: praterie e incolti a terreno ricco.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: soltanto alla Gretaia (Montemurlo) e Pian di Gello (Prato).
-Crepis bursifolia L. RADICCHIELLA TIRRENICA
H scap – Medit. - IV-IX – Relat. rara, ma sembra in espansione.
Erbacea perenne, alta 10-30 cm, a fusto eretto o ascendente che si caratterizza per le foglie profondamente pennatopartite in 5-10 coppie di segmenti opposti e bordati da denti cartilaginei di colore bianco puro; inoltre i capolini sono eretti prima dell’antesi, con squame interne dell’involucro in numero di 8, involucro di circa 1 cm di diametro; acheni di 5-7 mm con becco lungo due volte il corpo.
Habitat: prati, incolti aridi e assolati, ma da noi anche sui marciapiedi e margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: presso il Caciaio.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: P. alla Malva alla base di Prato Rosello (Carmignano).
- Montemurlo: Ricceri 2013: Acciai (in verbis).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: fra strada e marciapiede a P. a Caiano (2021); marciapiede a Galcetello (2024) (Prato).
-Crepis capillaris (L.) Wallr. RADICCHIELLA CAPILLARE
T scap – C-Europ. - V-VII – Poco comune.
Erbacea alta 10-90 cm, molto simile a C. neglacta (vedi), dalla quale si differenzia per essere pianta glabrescente, foglie basali più lunghe (fino a 30 cm), capolini eretti prima della fioritura con ricettacolo glabro e squame esterne più lunghe delle interne anche del doppio ed in numero di 7-9; acheni privi di becco.
Habitat: zone ruderali ed erbose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Montepiano sentiero 00 verso il Gorandaccio.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: anche su serpentine.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Crepis foetida L.
Erbacea che si caratterizza fra le congeneri perché maleodorante, con capolini (piccoli o di grandezza intermedia fra le varie Crepis) con squame involucrali non regolarmente embricate e con quelle esterne più brevi delle interne, a maturità sorpassate in lunghezza almeno dagli acheni interni, che si presentano dotati di un becco sottile, lungo più del corpo; gli esterni sono più brevi e senza becco (o con becco molto ridotto).
??-- Crepis foetida L. subsp. foetida RADICCHIELLA SELVATICA
T scap (H bienn.) – Euro-Medit. – VI-X – La sottospecie nominale è molto rara o assente.
Erbacea a fusto eretto o ascendente e ramoso, alta 10-50 cm; ha foglie basali pennato-partite, pubescenti-ispide, di forma oblungo-lanceolata, con le cauline ridotte; i capolini (diametro 10-12 mm) sono numerosi ed hanno l'involucro ghiandoloso; gli acheni sono di due tipologie: gli esterni quasi senza becco e gli interni con becco lungo 1,5-2 volte il corpo.
Habitat: zone ruderali, incolti aridi, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di P. a Caiano: Maugini 1946; non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
PS: Maugini potrebbe aver ritrovato invece che la sottospecie nominale la seguente (vedi).
- - Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (M.Bieb.) Čelak. RADICCHIELLA A FOGLIE DI PAPAVERO
T scap – SE-Europ.-S-Siber. - VI-IX – Rara (ma sembra in espansione).
Questa sottospecie, a fusto eretto e alta da 30 a 70 cm, si caratterizza per le squame involucrali con numerosi peli lanosi e rigidi e assenza, o quasi, di peli ghiandolari; le esterne sono più brevi delle interne. Inoltre la pianta è più robusta, con capolini maggiori della sottospecie nominale e le foglie superiori possono presentarsi da indivise a pennatopartite con auricole intere o quasi.
Habitat: aree incolte e ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub C. rhoeadifolia M. Bieb.): dalla Serra a Montiloni (Carmignano).
-Crepis leontodontoides All. RADICCHIELLA ITALICA
H ros/H scap – Orofita W-Medit. - IV-X – Comunissima.
Erbacea perenne, alta 10-50 cm, glabra o poco pelosa, a fusto gracile e alto fino a 50 cm; ha foglie allungate, pennato-lobate a lobi triangolari e acuti; i capolini sono larghi circa 1 cm, numerosi e ad involucro cilindrico che può presentarsi glabro o un po’ peloso, ma mai ispido; gli acheni, di circa 4-5 mm, hanno per lo più il becco lungo 1/3 del corpo.
Habitat: soprattutto ambienti boschivi chiari e cespuglieti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Usella verso il Santo, CAI 16; da Carmignanello a Gricigliana, Spedaletto (2020) (Cantagallo); verso il passo di S. Giuseppe (2018) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-08: Prato (Somm. herb.).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: nuovi ritrovamenti: M. Chiesino (2020).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Poggio a Caiano: Caruel 1860-64: tra Signa e P. a Caiano.
-Crepis neglecta L. RADICCHIELLA NASCOSTA
T scap – Euro-Medit. - V-VII – Comune.
Insieme a Crepis capillaris, si caratterizza, rispetto alle altre specie congeneri, per i capolini numerosi e di assai piccole dimensioni (6-8 mm di diametro); C. neglecta è alta 20-50 cm, ha fusto ramificato già dal basso; le foglie sono ispide, le basali in rosetta e intere, dentate o divise, le cauline ridotte, a lembo intero e denti basali acuti-triangolari. C. negletta si distingue da capillaris per i capolini penduli prima della fioritura, acheni più lunghi (2-2,5 mm, invece di 1,5-2), per le squame involucrali esterne più brevi delle interne e in numero di 4-6, infine per il ricettacolo ciliato.
Habitat: incolti, aree ruderali, margine strade, radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Migliana al Fabbro, sopra il L. Verde (2020), verso Codilupo (2023) (Cantagallo), sopra il Gorandaccio (2018), sopra Montepiano, Sassetta (2022) (Vernio).
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: non ritrovata (forse confusa con C. capillaris!).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Crepis pulchra L. RADICCHIELLA DOLCE
T scap – Euro-Medit. - V-VII – Relat. comune.
Erbacea annua, a fusto eretto e ramificato, pubescente-vischiosa in basso e alta 30-100 cm; le foglie superiori sono sessili e lanceolate, le altre hanno forma spatolata e si presentano dentate o pennatopartite; ha capolini piccoli (1,5 cm circa), ma non molto numerosi, composti da pochi fiori ligulati giallo-solferino e con ricettacolo glabro; inoltre le squame esterne dell'involucro, ovali, sono assai più piccole delle altre e gli acheni più esterni sono privi di pappo.
Habitat: margini boschivi e di arbusteti, incolti e zone ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890, riportato in Baroni 1897-1908: Mercatale in Val di Bisenzio (Vernio); nuovi ritrovamenti: sotto e sopra Migliana, Gorandaccio (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908 (Somm. herb.): Prato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone marginali.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub C. p. L. subsp. pulchra) (C/S).
- Pianura: nuove segnalazioni: incolto erboso a Tavola (2024) (Prato).
PS: fra le specie congeneri C. pulchra appare effettivamente la specie più elegante e carina, come suggerisce il nome volgare e quello latino (pulcra ovvero bella).
-Crepis sancta (L.) Babc. subsp. nemausensis (P.Fourn.) Babc. RADICCHIELLA DI NIMES
T scap – Neofita invasiva di orig. turanica (divenuta Medit.-Turan.) - III-VI – Comunissima.
Erbacea annuale, a fusto eretto e ramoso già dal basso, alta 5-40 cm; mentre le foglie cauline sono ridotte praticamente a squame, le basali sono spatolate e più o meno profondamente incise al margine; l'infiorescenza è a corimbo e costituita da 2-10 capolini a fiori tutti ligulati gialli (spesso arrossati all’estero) e le squame dell'involucro presentano peli rigidi; gli acheni hanno duplice aspetto: gli interni senza ali e i periferici con 3 ali di ampiezza variabile. La subsp. nemausensis ha capolini più grandi e gli acheni presentano agli angoli esterni larghe ali.
Habitat: prati, incolti, zone ruderali, margini di strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: M. Scalette (2020) (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: sentiero CAI 462b dall'Alpe al Tab. di Gavigno (2024) (Vernio-Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 (sub C. sancta (L.) Babc.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 [sub Lagoseris nemausensis (Gouan) W.D.J. Kock]; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e Poggio a Caiano
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub Lagoseris nemausensis Kock, sempre con individui glabri); Biagioli & al. 2002
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: comune un po' ovunque.
PS: segnalata in Toscana per la prima volta nel 1882 presso Livorno, da allora è divenuta, anche nel Pratese, una delle piante più comuni sia in ambienti di pianura, che di collina, che di montagna.
-Crepis setosa Haller f. RADICCHIELLA COTONOSA
T scap – E-Euro-Medit. - V-IX – Relat. comune.
Tutta la parte area di C. setosa è caratterizzata da una fitta pubescenza setosa; ha fusto eretto e ramoso dal basso ed è alta 20-80 cm; le foglie inferiori si presentano a lamina oblungo-lanceolata, dentata o più profondamente incisa, le superiori lanceolate triangolari, intere, con alcune lacinie bilaterali in basso, abbraccianti con orecchiette acute; l'involucro, di 8-10 mm, presenta peli giallastri; gli acheni hanno pappo bianco che supera appena, a maturità, le lacinie involucrali; il ricettacolo è glabro.
Habitat: luoghi erbosi sia coltivati che incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2022) (Vernio), verso Codilupo (2023) (Cantagallo), Schignano (2023) (Vaiano).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub C.s. Hall. var. typica Fiori); Biagioli & al. 2002: M. Mezzano, falde del M. Chiesino (Prato); ex-cava Guarino (Montemurlo).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: Natreta (S).
-Crepis taraxacifolia Thuill. RADICCHIELLA A FOGLIE SIMILTARASSACO
T scap/H bienn – Euro-Medit. - II-X – Rarissima.
Erbacea alta 20-60 cm, a fusto eretto e ramoso, angoloso; foglie ispide, le basali in rosetta, numerose oblungo-lanceolate, pennatosette con, spesso, il lobo superiore maggiore dei laterali (simili a quelle del tarassaco), le cauline più piccole, lineari, sessili e auricolate; capolini posti su lunghi peduncoli, con involucro cilindrico lungo 8-12 mm e con squame provviste di setole gialle e nerastre e di ghiandole; i fiori sono ligulati e gialli (talora arrossati all’esterno e in basso); gli acheni spesso arrossati e con il becco lungo come il corpo o più.
Habitat: incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b [sub C. vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.]: rr sopra Villa Fiorita (S).
-Crepis vesicaria L. RADICCHIELLA VESCICOSA
H bienn/T scap – Submedit.-Subatl. - I-XII – Comune.
Erbacea abbastanza robusta (alta fino a 80 cm), eretta e per lo più assai pelosa; i capolini sono abbastanza grandi (ca. 2 cm di diametro) con fiori ligulati gialli; caratteristiche sono le brattee esterne dell’involucro rigonfie a vescica (da cui il nome specifico) e membranose sul bordo; le foglie basali da lobate a pennatosette sono lunghe 10-25 cm, la cauline ridotte.
Habitat: ruderale, incolti erbosi, margini sentieri e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-08: Montepiano (Somm. herb.); Venturi 2006: presso Fossato; nuovi ritrovamenti: presso il L. Verde, da Fabbro a Migliana (2022) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub C.v. var. scariosa); Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato); M. Buriano.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub C.v. var. scariosa); Messeri 1936 [sub C.v. L. var. scariosa (Willd.)]; Biagioli & al. 2002: ex-cava Guerino e Pianali (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: presente assai comunemente in incolti e margini di coltivi.
PS: le foglie basali prima della fioritura sono molto ricercate da chi ama i radicchi selvatici; c'è chi utilizza i capolini, prima dell'apertura e circondati dalle brattee, a mo' di capperi sottaceto.
-Crepis zacintha (L.) Loisel. RADICCHIELLA VERRUCARIA
T scap – N-Medit. - V-VI – Rara.
Erbacea a fusto prostrato o eretto e a ramificazioni dicotomiche; foglie radicali (sul fusto piccole alla dicotomia dei rametti), da lirate, a roncinate, a dentate, di forma bislungo-ovata; capolini di ca. 1 cm: i terminali su peduncoli rigonfi in alto e quelli alle biforcazioni sessili; fiori ligulati gialli; involucro piriforme alla fruttificazione, a 5 squame esterne e 8-10 interne più lunghe; acheni fusiformi di 2-2,5 mm, gli esterni ad apici ripiegati verso l’interno.
Habitat: zone erbose, radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: presso il Pod. Dell’Orto (Carmignano).
PS: le foglie di questa specie sono molto amare, immangiabili!
Il genere Crupina
conta 3 specie a distribuzione mediterranea ed SW-asiatica (tutte e tre presenti in Italia e 2 in Toscana). Si tratta di piante erbacee annuali a soli fiori tubulosi, simili per morfologia a quelle del genere Centaurea (vedi), ma con i capolini a squame involucrali diseguali, lanceolato-acute e prive di appendice, ricettacolo con scaglie lineari; inoltre gli acheni si presentano setolosi, sormontati al centro da una coroncina membranosa con pappo formato da una serie di peli esterni brevi e interni più lunghi; le foglie cauline sono pennatosette e in discreto numero.
-Crupina vulgaris Cass. CRUPINA COMUNE
T scap – Euro-Medit.-Subsiber. - V-VI – Abbastanza rara.
Erbacea alta 20-50 cm a fusto eretto con sottili ramificazioni; foglie basali intere e le cauline divise in lobi esili e denticulati; i fiori tubulosi del capolino sono roseo-purpurei ed in numero di 4-6; l’involucro è glabro, fusiforme con base conica; gli acheni di forma oblunga hanno un ombelico basale, subrotondo.
Habitat: aree pietrose, prati e pascoli.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Foggi & Venturi 2009: M. Scalette (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: Scalette (riconferma) (2018) (Cantagallo), Passo La Crocetta verso Mangona (poco oltre il cartello Prato) (2017) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Il genere Dittrichia
conta 2 solo specie mediterraneo-W-asiatiche; si tratta di piante erbacee annuali o perenni, a foglie intere e alterne, fiori gialli, ligulati esterni (femminili) e tubulosi interni (ermafroditi), riuniti in capolini a ricettacolo nudo e involucro emisferico con lacinie embricate; i capolini sono raggruppati in dense pannocchie allungate. E' simile al genere Inula dal quale si distingue soprattutto per il pappo degli acheni le cui setole sono saldate in basso (libere in Inula).
-Dittrichia graveolens (L.) Greuter FULICHI, CUCUTAJA
T scap – Medit.-Turan – VIII-XI – Relat. comune.
Erbacea ghiandoloso-vischiosa, alta 20-60 cm, che emana odore sgradevole (graveolens); dal fusto erbaceo ed eretto si dipartono diversi rami laterali eretto-patenti su cui si inseriscono ad una certa altezza numerosi piccoli capolini (6-10 mm di diametro) ascellari e terminali, dotati di fiori ligulati brevi (lunghi meno di 5 mm e larghi meno di 1 mm), non superanti l'involucro; squame involucrali interne lesiniformi (5-6 mm), le esterne ± patenti; le foglie sono lineari; gli acheni sono lunghi 1-2 mm.
Habitat: incolti aridi, sassosi, zone ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano (a NE stadio de La Briglia).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: a W sotto la cassa di espansione dell'Ombrone (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: poco sopra la Fattoria di Javello (2017).
- Pianura: alveo del Bisenzio qua e là a Prato (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936: segnalata in Levier herb., ma da lei non ritrovata; Biagioli & al. 2002: podere Ciabatti, (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: incolto presso cimitero di Chiesanuova (2022); letto del Bardena a Galcetello (2024) (Prato).
PS: un tempo la pianta era utilizzata contro il morso della vipera.
-Dittrichia viscosa (L.) Greuter ENULA VISCHIOSA, ENULA CEPITTONI
H scap – Euro-Medit. - VIII-XI – Comunissima.
Erbacea aromatica e vischiosa per le numerose ghiandole presenti soprattutto sulle foglie, alta 50-100 cm, a fusti eretti rapidamente lignificati in basso, molto fogliosa (foglie sessili, a lamina lanceolata e acutamente dentellata) e a capolini più grandi della precedente (10-15 mm) riuniti in una ricca pannocchia; essi hanno i fiori (giallo-oro) ligulati raggianti lunghi ca. il doppio dell’involucro (lunghezza maggiore di 5 mm e larghezza maggiore di 1 mm).
Habitat: incolti di ogni genere anche umidi, zone ruderali, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Vernio e zone limitrofe (e oltre!) (2021).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Inula viscosa); Messeri 1936 (Inula viscosa Ait. var. typica Fiori); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002 (sub Inula viscosa (L.) Ait.): un po' ovunque (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: incolto presso cimitero di Chiesanuova, via Brugnani loc. Bocca Vittoria (2023) (Prato).
Il genere Doronicum,
costituito da una venticinquina di specie erbose perenni (8 in Italia), ha distribuzione eurasiatica; è caratterizzato da: foglie intere e alterne, capolini - solitari o pochi terminali ai peduncoli - a fiori gialli (ligulati e tubulosi), squame involucrali in 2-3 serie e ricettacolo privo di setole. Per la determinazione precisa delle specie si devono valutare al microscopio i peli del margine fogliare e delle squame involucrali.
NB: sulla Calvana è stato reperito da chi scrive anche D. columnae Ten. (Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016), ma finora solo nel comune di Calenzano in provincia di Firenze.
?-Doronicum austriacum Jacq. DORONICO D’AUSTRIA
G rhiz – Orof. SE-Europea – V-VIII – Probabilmente scomparsa nel nostro territorio.
Erbacea eretta e alta 80-150 cm, senza stoloni, col fusto eretto che in alto si ramifica con numerosi capolini a corimbo; le foglie radicale sono secche all’antesi e le cauline inferiori abbracciano il fusto con 2 auricole tondeggianti, le medie hanno forma caratteristica a chitarra (si restringono sotto la metà della lamina); i fiori sono di colore giallo-oro.
Habitat: boschi ombrosi montani.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Caruel 1960-64: M.Piano sopra Vernio (Bert.); non più ritrovata.
-Doronicum pardalianches L. DORONICO MEDICINALE
G rhiz – W-Europ. (Subatl.) - VI-VII – Molto raro.
Erbacea stolonifera a fusto eretto e poco foglioso (foglie distanziate fra loro), alta 30-80 cm; foglie basali e inferiori a lembo arrotondato-suborbicolare (diametro di 7-15 cm), lungamente picciolate e profondamente cordate, le medie bruscamente contratte e largamente abbraccianti; capolini in numero di 1-8 (3-5 cm di diametro) a fiori giallo-oro, con squame involucrali ciliato-ghiandolose, lanceolato-lineari a punta sottile; acheni della circonferenza senza pappo.
Habitat: boschi per lo più di montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890 e Baroni 1897-1908: abetina di Montepiano (Vernio); nuovi ritrovamenti: sopra Montepiano verso il Gasperone (raro) e da Badia verso il passo di S. Giuseppe a margine del torrente (relativamente ben rappresentato) (2017) (Vernio); da Fossato al Tabernacolo di Gavigno (2018) (Cantagallo).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sotto le cascate di Massacorbi a margine del torrente affluente del Bagnolo (2015).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: poche piante alla Gretaia (Montemurlo).
PS: il curioso epiteto deriva dal greco (“parda” leopardo e “archo” io strozzo): strozza-leopardi, in quanto considerata velenosissima; in realtà ha proprietà fitoterapiche antispasmodiche, sedative e astringenti (il rizoma contiene inulina, tannini, amari, oli e sali minerali).
Il genere Echinops
conta più di 120 specie distribuite in Europa, Asia e rilievi montani dell’Africa tropicale (7 in Italia). Si tratta di piante erbacee spinose a soli fiori tubulosi, caratterizzate da capolini ad un solo fiore circondato da un involucro angoloso e peloso alla base e riuniti strettamente in pseudocapolini di forma globosa su un ricettacolo comune; squame involucrali acuminate e rigide.
-Echinops sphaerocephalus L. CARDO PALLOTTA MAGGIORE
H scap – Paleotemp. - VII-VIII – Localizzato.
Erbacea alta 50-100 cm, a fusto eretto, peloso-ghiandoloso, ramificato; foglie grandi (fino a 40 cm) pennatifide o lobato-sinuate a segmenti spinosi al margine, lamina di sotto bianco-tomentosa e di sopra verde e spinulosa; infiorescenze ± numerose, di 30-70 cm composte da capolini uniflori di soli fiori tubulosi di colore biancastro o azzurrino, ermafroditi, fittamente stipati su un ricettacolo ovato, e con involucro oblungo circondato alla base da peli lunghi ca. la metà delle squame involucrali interne; le squame si presentano libere, lungamente acuminate e pettinato-ciliate; acheni pelosi di 7-8 mm.
Habitat: incolti sassosi, da noi soprattutto su substrato calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: rarissimo in radura di bosco sentiero CAI 10 sopra la Fattoria di Javello (2019).
NB: il nome del genere è riferito alla morfologia del capolino: deriva dal greco echinos = riccio e ops = aspetto.
Il genere Eclipta
ha distribuzione nelle zone caldo-temperate del Nuovo Mondo e conta 5 specie (in Italia si naturalizzata 1 sola specie). Il nome deriva dal greco ekleipsis = mancanza, allusione alle piccole dimensioni o addirittura all’assenza del pappo degli acheni di queste piante. Si tratta di specie erbacee erette a foglie opposte ed intere, capolini terminali o ascellari composti da fiori ligulati esterni (nella nostra specie di lunghezza inferiore a 6 mm) e tubulosi interni, con ricettacolo a pagliette sottili e acheni assai tubercolati oltre che con pappo ridottissimo o assente.
-Eclipta prostrata (L.) L. FALSA MARGHERITA
T scap – Neofita invasiva di orig. Neotropicale – VIII-X – Relat. rara.
Erbacea ispida, molto ramosa, alta 20-90 cm: foglie opposte, bislungo-lanceolate, sessili (le inferiori a breve picciolo), lievemente dentate, lunghe fino a 13 cm; i capolini, emisferici, ascellari o terminali, su esili peduncoli di 5-12 mm, hanno il diametro di 6-10 mm e sono costituiti da fiori ligulati bianchi di ca. 6 mm, con ricettacolo a pagliette setacee, ciliate in alto.
Habitat: luoghi umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: a N del Poggetto presso un fossetto a NW del torrente la Furba (Carmignano).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: alveo del Bisenzio a S di Gonfienti, fossetti nei campi fra Caserane e Iolo (2023) (Prato); argine dell’Ombrone presso il Ponte Manetti (2023) (P. a Caiano).
NB: questa specie sembra in rapida espansione; in Italia fu individuata per la prima volta nel Napoletano presso Posillipo nella seconda metà dell’ottocento.
Il genere Erigeron
è costituito da piante erbacee annuali o perenni, riunite in circa 480 specie a distribuzione subcosmopolita (in Italia poco più di 15 entità specifiche fra indigene e naturalizzate); le foglie si presentano lanceolate o oblanceolate, basali e cauline (sessili e alterne), i capolini sono solitari o riuniti in corimbo, con involucro a squame embricate in 2 ranghi, ricettacolo alveolato, fiori tubulosi al centro e ligulati stretti - inferiori a 0,2 mm di larghezza - e in più serie (a volte assenti) alla periferia. E' simile al genere Aster che però ha ligule (non sempre presenti) mai gialle e più larghe (0,2 mm), inoltre le squame dell'involucro si presentano generalmente in 2 o più ranghi.
-Erigeron annuus (L.) Desf. CESPICA ANNUALE
T scap – Neofita invasiva di orig. N-Americ. – VII-XI – Comune e diffusa.
Erbacea a peli patenti, alta 30-100 cm e più, con fusto eretto e ramificato in alto; foglie inferiori picciolate e lunghe fino a 3 cm, profondamente e irregolarmente dentate, le superiori minori, sessili e a 3-5 denti per lato; capolini di 1-2 cm di diametro, con fiori tubulosi del disco gialli e ligulati bianchi o lillà e lunghi 6-8 mm; gli acheni dei fiori tubulosi hanno pappo di setole disposte in 2 serie, quelli delle ligule in 1 sola serie. Si tratta di una specie apomittica che in talune popolazioni può apparire con caratteristiche morfologiche un po’ diverse da quelle descritte.
Habitat: luoghi erbosi fresco-umidi, sponde di corsi o specchi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso il lago Verde di Cantagallo (2022).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: in zone marginali, presso l’ex-cava Guarino, torrente Bagnolo (Montemurlo)*; Arrigoni & Viegi 2011.
- Pianura: Caruel 1860-64 (sub Stenactis bellidiflora Braum.): sponde dell’Ombrone dietro il Palazzo di P. a Caiano (Car.); nuovi ritrovamenti: lungo le sponde dell’Ombrone di P. a Caiano.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): margine castagneto sopra Cerreto.
*Gli Autori affermano che oltre alla sottospecie nominale è presente sul Monteferrato anche la subsp. strigosa (Muhl. ex Willd.) Wagenitz, in realtà mai segnalata per la Toscana: si tratta verosimilmente di piante che rientrano nella variabilità morfologica propria della specie.
-Erigeron bonariensis L. SAEPPOLA DI BUENOS AIRES
T scap – Neofita invasiva di orig. Americ. Trop. - V-X - Assai comune.
Erbacea alta 10-60 cm, a fusto eretto molto foglioso (foglie lineari-allungate, a una sola nervatura); i numerosi e piccoli capolini (5-10 mm) sono riuniti in una pannocchia corimbosa all’apice dei rametti; i capolini presentano fiori periferici privi di ligula (al contrario del simile E. canadensis): sono costituiti da soli fiori tubulosi bianco-giallastri col pappo che tende a maturità a divenire giallo-rossastro.
Habitat; aree erbose coltivate ed incolte, in città sui marciapiedi, parchi ecc…
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Conyza bonariensis (L.) Cronq.): Limentra orientale
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Conyza bonariensis (L.) Cronq.): dintorni di V. Fiorelli e Galceti (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello e altrove anche in città a Prato ecc.
-Erigeron canadensis L. SAEPPOLA DEL CANADA
T scap – Neofita invasiva di orig. N-Americ. - VI-X – Assai comune.
Erbacea simile a E. bonariensis, dal quale si distingue per le dimensioni maggiori (è alta 40-150 cm) e per i fiori periferici del capolino che hanno ligule bianche brevi, ma evidenti; i capolini sono piccoli (3-5 mm di diametro) e riuniti in pannocchia piramidata; foglie pubescenti, da lanceolate a lineari, e uninervie.
Habitat: incolti aridi ed erbosi, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Migliana (2021) (Cantagallo).
Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
Motalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Messeri 1936; Biagioli & al. 2002 (sub Conyza canadensis (L.) Cronq.): adattata anche alle più ostiche aree ofiolitiche.
Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2020) e altrove anche in città a Prato ecc.
PS: pur essendo commestibile non è utilizzata a fini alimentari perché di sapore ingrato ed inoltre per la pelosità delle foglie; ha invece un certo utilizzo in campo fitoterapico per le sue proprietà antalgiche ed antiinfiammatorie.
-Erigeron karvinskianus DC. CESPICA KARVINSKIANA
H scap – Neofita invasiva di orig. Subtrop.-N-Americ. - VII-X – Non molto comune.
Erbacea a fusti arcuato-ascendenti e molto ramosi, alta 10-40 cm; foglie inferiori lanceolate e picciolate con 1 grosso dente mucronato per lato, lunghe fino a 3 cm, quelle della rosetta spatolate; capolini terminali di ca. 1,5 cm di diametro su peduncoli nudi in alto; involucro lungo 3-5 mm, fiori tubulosi centrali gialli, i periferici ligulati da bianchi a rosati ± scuri.
Habitat: muri umidi, presso fossi e zone fangose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Fabbro, raro (2021) (Cantagallo); Sasseta al Chiesino (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Savignano (Vaiano).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso Quercia dei Termini (2016).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): raro.
- Pianura: Ricceri 2013: frequente nei muri lungo l’asse fluviale del Bisenzio a N della città di Prato.
PS: l’epiteto specifico è una dedica al naturalista tedesco Wilhelm Friedrich von Karwinski auf Karwin, vissuto cavallo del XVIII e IX° sec.
-Erigeron sumatrensis Retz. CONIZA DI SUMATRA
T scap – Neofita invasiva di orig. America trop. - VI-IX – Non comune.
Erbacea da pubescente a ispida, a fusto eretto e foglioso, è l’Erigeron più alto fra quelli presenti in italia, 50-200 cm; foglie (± dentellate) basali e cauline inferiori lanceolato-lineari, le superiori ridotte, alterne e più sottili e con ± evidenti nervature ramificate; capolini numerosi (più di 50) riuniti riuniti in pannocchie o corimbi allungati e con involucro urceoliforme; i fiori sono tubulosi (bianco-giallastri a volte arrossati), i periferici con un piccolo dente (ligula ridotta?!).
Habitat: terreni di riporto, macerie, greti, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Conyza albida Willd.): presso il T. Bagnolo (Montemurlo).
Il genere Eupatorium
conta una cinquantina di specie a distribuzione olartica (1 sola in Italia). Le sue specie sono erbacee inermi con capolini simili fra di loro e riuniti, numerosi, in denso corimbo; essi si presentano con non più di 10 fiori tutti tubulosi di colore roseo ± intenso; l’involucro ha poche squame embricate lassamente e il ricettacolo è nudo; gli acheni hanno pappo costituito da setole in una sola serie.
-Eupatorium cannabinum L. CANAPA ACQUATICA
H scap – Paleotemp. - VII-IX – Comunissima presso le zone umide.
Erbacea robusta, alta fino ad oltre 1 m, a fusto eretto e ramoso; ha foglie opposte, picciolate a 3-5 segmenti lanceolati, dentellati e acuti (a volte semplici); i fiori, tutti tubulosi e porporini, sono posti su capolini piccoli (2-5 mm di diametro) e numerosi a formare infiorescenze terminali dense a corimbo; acheni di 3 mm a pappo più lungo e grigiastro.
Habitat: ambienti umidi e freschi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 (Le Barbe), Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Foggi & Venturi 2009: a W del tabernacolo di Gavigno; nuovi ritrovamenti: margine strada da Vaiano a Schignano (2021) (Vaiano); da Montepiano al Gasperone, da Sassetta a Montepiano (2018), sopra Montepiano, presso e sopra la Badia, verso F. Romito, Alpe di Cavarzano, sotto Cavarzano verso Luciana (2021) (Vernio); presso Migliana (2023) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Canapa acquatica): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Foggi & Venturi 2009: torrente Acqua Calda (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub E.c. L. var. typicum Fiori f. partitum Neilr.); Biagioli & al. 2002: ovunque in prossimità delle acque, anche su serpentine presso la Fonte della Cava, alla Gretaia e all’ex-cava di Gello (Prato e Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: sponde del Bisenzio presso la pista ciclabile di Prato; Cassa espansione del Bardena a Galcetello (2019) (Prato).
NB: le vengono riconosciute proprietà fitoterapiche lassative, diuretiche, febbrifughe ecc.
Il genere Filago
comprende una quarantina di specie distribuite in area mediterranea e centro-asiatica (10 in Italia). Si tratta di erbacee annuali grigio-tomentose, a fusti sottili e fogliosi; le foglie sono semplici ed alterne; i capolini sono aggregati in serrati glomeruli lanosi e subglobosi (raramente solitari), spesso circondati da brattee, con fiori solo tubulosi; le squame involucrali, per lo più acute o mucronate e in numero di 15-25, sono poste in 3-4 ranghi; ricettacolo con pagliette avvolgenti i fiori; acheni leggermente compressi e per lo più dotati di pappo.
??-Filago eriocephala Guss. BAMBAGIA MERIDIONALE
T scap – Medit. Orient. - III-VII – Rarissima o molto più probabilmente assente.
Erbacea densamente tomentosa, a fusto generalmente eretto e ramificato in alto, alta 2-10(-30) cm; foglie lunghe fino a 24 mm, capolini 4 x 2 mm che sporgono al di sopra dell’indumento lanoso, riuniti in glomeruli molto densi e di forma ovata; squame involucrali lanceolate e lunghe ca. 3 mm; acheni lunghi ca. 7 mm. Si differenzia dalla simile F. germanica per le squame involucrali appuntite, ma non aristate e mai arrossate.
Habitat: aree aride e assolate.
Distribuzione sul territorio:
segnalata solo da Messeri 1936 [sub Filago germanica L. var. eriocephala (Guss.)] sul Monteferrato e non ritrovata né precedentemente, né in seguito da Biagioli & al. 2002 e da nessun altro autore, probabilmente non è mai stata - o almeno non è attualmente - presente nel territorio provinciale di Prato.
-Filago germanica (L.) Huds. BAMBAGIA COMUNE
T scap – Paleotemp. - IV-VII – Non comune.
Erbacea di 2-35 cm, bianco-tomentosa (meno densamente di F. eriocephala) per lo più eretta e ramosa dicotomicamente in alto; foglie lunghe fino a 3 cm e larghe 2-3 mm, lanceolato-lineari, a margine ondulato; i capolini, a fiori gialli, sono riuniti in glomeruli globosi di 10-12 mm di diametro in numero di 15-40 e non ricoperti dalle brattee sottostanti; squame involucrali acute, le esterne prolungate in una resta giallastra e le interne spesso arrossate; acheni ovoidi e brunastri.
Habitat: incolti, luoghi erbosi e marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: nuovi ritrovamenti: da Migliana alle Cavallaie (2018), sentiero CAI 16 vers. S. Ippolito (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 (sub F. vulgaris Lam.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Bambagia): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 [sub F. g. (L.) Huds. var. typica Fiori e var. typica Fiori f. kaltenbackh (S.Bip.)]; Biagioli & al. 2002: soprattutto su pietraie serpentinose.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Filago pyramidata L. BAMBAGIA SPATOLATA
T scap – Euro-Medit. - IV-VII – Comune.
Erbacea annua a fusticino eretto e ramoso spesso di- o tri-cotomicamente, alto 5-30 cm; si caratterizza per le foglie allargate e tondeggianti in alto (spatolate!) e per i capolini riuniti in 12-20 a formare glomeruli più brevi delle foglie superiori; l'apice dei segmenti esterni dell'involucro hanno punta giallastra.
Habitat: incolti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: nuovi ritrovamenti: Terrabianca (2017) (Cantagallo); a W della Badia di Montepiano (2017) (Vernio); sotto Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: cassa di espansione dell’Ombrone (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S); 2 oss. Franzoni 2020 Wikiplantbase#Toscana.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: alveo del Bisenzio lungo Viale Galilei (2024) (Prato).
Il genere Galactites
conta 3 specie distribuite in area mediterranea (1 in Italia). Sono piante erbacee spinose, con foglie tomentose e chiazzate di bianco sulla pagina superiore, capolini a soli fiori tubulosi roseo-purpurei o raramente biancastri (quelli periferici molto più grandi degli interni e raggianti) con filamenti staminali saldati totalmente a tubo; acheni senza coste e con pappo precocemente caduco a setole piumose.
-Galactites tomentosus Moench SCARLINA
H bienn – Medit. - V-VII – Relat. comune.
Erbacea alta fino a 1 m ed assai ramificata in alto, tutta ricoperta di tomento biancastro; contiene un latice bianco, che ha dato il nome al genere (gala = latte); le foglie, macchiettate di chiaro e per lo più profondamente divise, sono ± decorrenti sul fusto e spinose; i capolini, solitari o riuniti in cime, hanno solo fiori tubulosi di colore porporino con i laterali più grandi dei centrali e raggianti (superano le squame involucrali esterne); gli acheni sono di colore bruno brillante. Questo genere è simile a Cirsium, ma se ne distingue per i fiori esterni diversi (più grandi e raggianti) dagli interni, le foglie macchiettate di chiaro ed il pappo di soli peli piumosi.
Habitat: zone ruderali ed incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Lupsia galactites); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub Lupsia galactites); Gestri 2009 (sub Galactites elegans (All.) Soldano) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano; 2 oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: M. Buriano, Bifolchi (Prato).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Scarlina): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; 2 oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: nel comune di Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Lupsia galactites); Messeri 1936 (sub Lupsia galactites O. Kze var. typica Fiori f. alata Fiori; Biagioli & al. 2002: Pian di Gello e Cannatello (Prato), anche su serpentino.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Il genere Galatella,
che fino a poco tempo fa era incluso in Aster, è costituito da una trentina di specie a distribuzione euroasiatica (2 in Italia): erbacee a foglie intere ed alterne, capolini normalmente numerosi costituiti da più fiori tubulosi gialli, ricettacolo senza pagliette, squame involucrali in più serie; si caratterizzano rispetto ad Aster per i fiori ligulati – se presenti! – a stilo abortivo, il pappo in 2-3 serie (Aster in 1-2) e per le squame involucrali più sottili e con le esterne ben più brevi delle interne.
-Galatella linosyris (L.) Rchb. f. ASTRO SPILLO D’ORO
H scap - Euro-medit.- S-Siber. (Sub-Pontico) – VII-IX – Relat. comune.
Erbacea glabra, a fusto eretto, ramificato in alto, alto 20-50 cm, assai foglioso per foglie lineari, numerose, ravvicinate e ± eretto-patenti; i capolini, a peduncolo breve e bratteato e a fiori solo tubulosi e gialli (a 5 divisioni di ca. 3 mm), sono riuniti in corimbo terminali; le squame involucrali appaiono lasse, acute, revolute almeno le inferiori; gli acheni a pappo di setole rossatre.
Habitat: prati, radure.
Distribuzione sul territorio;
Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Astro spillo d’oro): AMPIL del Monteferrato.
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
Monteferrato: Messeri 1936 (sub Aster linosyris Bernh. var. vulgaris Fiori e Aster linosyris Bernh. var. vulgaris Fiori f. patulus Weiss.); Biagioli & al. 2002 (sub Aster linosyris (L.) Bernh.): soprattutto su serpentino in terreno più evoluto (taglia minore della norma, in genere sotto i 30 cm).
Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
NB: in Calvana questa specie è stata osservata solo nel comune di Calenzano (FI) (Gestri & Peruzzi 2016).
Foto di U. Ferrando
??-Galatella sedifolia (L.) Greuter subsp. sedifolia ASTRO SCABRO
H scap – S-Europ.-S-Siber. - VII-XI – Raro o non più presente.
Erbacea a fusto eretto e ramoso in alto, alta 20-50 cm; foglie scabre, lineari, ghiandolose e rigidette (simili a quelle del sedum da cui l’epiteto); capolini (diametro di ca. 2-3 cm) - a fiori periferici ligulati i numero di 2-15, raggianti e violetti e centrali tubulosi e gialli - numerosi in corimbo o pannocchia; squame involucrali (ovate o lanceolate) le esterne inferiori di più della metà delle interne.
Habitat: incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
??Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Aster sedifolius L.): Gretaia ed ex-cava Guarino (Montemurlo).
NB: la segnalazione di questa specie per il Montalbano [Gestri & Peruzzi 2013a: sponde dell’Arno alla Nave (Carmignano)], da un esame più approfondito delle immagini, è da riferire a Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom (vedi).
Il genere Galinsoga
è distribuito “naturalmente” in America centrale e meridionale, con un numero di specie che varia, a seconda degli autori, da 15 a una trentina o poco più (2 soltanto, naturalizzate, in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali (normalmente di piccola taglia), a foglie opposte e intere, capolini – a fiori ligulati femminili e tubulosi ermafroditi – sono piccoli e riuniti in cime dicotome; il ricettacolo è dotato di pagliette e le squame involucrali sono organizzate in 1-2 ranghi; il pappo è bianco a squame pennate.
-Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. GALINSOGA ISPIDA
T scap – Neofita invasiva di orig. S-Americ. - VII-X – Abbastanza comune e in aumento.
Erbacea a fusto eretto, striato e ramificato già dal basso, con fitti peli patenti biancastri lunghi 1 mm e più, misti a peli ghiandolari, alta 10-50 cm; foglie a lamina ruvida, le inferiori e medie ovate e grossolanamente dentate; capolini piccoli (6-7 mm di diametro), su peduncoli ghiandolosi, a 5 (raramente di più) ligule bianche e tridentate e a 15-30 fiori tubulosi centrali gialli; ricettacolo con pagliette intere o comunque non lobate.
Habitat: incolti erbosi, macerie, a margine di coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: a S di Montepiano, nel giardino della piazza principale a Montepiano (2022), strada per Luciana (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Colle (Cantagallo).
- Pianura: argine del Bisenzio presso Viale Galilei (2024) (Prato).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub G. ciliata (Raf.) S.F.Blake): presso il Mulino Nuovo (Montemurlo); Arrigoni & Viegi 2011.
PS: in Toscana in generale la specie sembra in forte espansione.
Il genere Gamochaeta
conta più di una cinquantina di specie, diffuse soprattutto nei Caraibi e in CSN- America (in Italia 4 specie naturalizzate); è affine ad altri generi del complesso Filago (erbacee prive di spine, foglie non opposte e capolini con soli fiori tubulosi, quelli femminili con tubo in diretta continuità con l’apice dell’ovario); si caratterizza per le foglie alterne ed i capolini riuniti all’apice del fusto in infiorescenza spiciforme.
-Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. CANAPICCHIA AMERICANA
T scap – Neofita naturalizzata di orig. SC-Americ. - IV-VI – Rarissima.
Erbacea a più fusti eretti o ascendenti, alta 10-40 cm; foglie basali in rosetta, obovate e leggermente crenate al margine, con faccia superiore verde ed inferiore biancastra; le cauline sessili e via via ridotte verso l’apice del fusto dove si trovano capolini più o meno numerosi in infiorescenza fogliosa spiciforme e ± interrotta; fiori tutti tubulosi ed ermafroditi, involucro piriforme con squame acute in 3-5 serie.
Habitat: incolti presso strade, sentieri e zone antropizzate.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: Cantagallo (Prato), a ovest del paese di Migliana, in via delle Cavallaie, loc. Lavatoio
Il genere Geropogon
è monospecifico e simile a Tragopogon (se ne distingue per gli acheni esterni a pappo non piumoso, come gli interni, ma ridotto a setole rigide e scagliose - in Tragopogon tutti gli acheni sono piumosi – e i fiori ligulati rosati e non rosso-porporino,violacei o gialli) ed a Scorzonera e Podospermum (se ne distingue per le squame involucrali ad 1 solo rango e di uguale grandezza, invece che su più ranghi e con quelle esterne inferiori alle interne).
-Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip BARBA DI BECCO ANNUALE
T scap – Medit. - IV-VI – Rarissima.
Erbacea simile alle specie di Scorzonera e Tragopogon, ma annuale, più gracile e di altezza spesso inferiore (10-50 cm raramente di più); il fusto è eretto e generalmente semplice; le foglie lungamente triangolari e parallelinervie, sono dilatate all’inserzione sul fusto e amplessicauli; il capolino (3-5 cm di diametro) presenta il peduncolo ingrossato, pochi fiori tutti ligulati (meno di 19) lunghi fino a 2,5 cm e di colore lilla-rosato, nettamente superati dalle squame involucrali; acheni cilindrici (15-25mm) e con pappo (vedi sopra) di inferiore lunghezza (12-15 mm).
Habitat: luoghi erbosi e pietrosi, incolti, pascoli in area mediterranea o submediterranea.
Distribuzione sul territorio:
- Colline di Montemurlo: Ricceri 2006 e Foggi & Venturi (sub Tragopogon hybridus L.): Pian di Scalino (Montemurlo).
- Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub G. glaber L.): fra Signa e S. Piero in Verghereto (Somm. IV e Somm. herb.) (Carmignano); Ricceri 2006 e Foggi & Venturi (sub Tragopogon hybridus L.): Montalbano (Carmignano); non ritrovato da Gestri & Peruzzi 2013a.
Il genere Glebionis
è costituito da 3 specie a distribuzione Eurasiatica e N-Africana (tutte presenti in Italia); si tratta di piante annue a foglie alterne da pennatosette a ± profondamente dentate; a capolino unico o pochi in corimbo, con fiori ligulati periferici femminili (gialli o bianchi) e tubulosi centrali (gialli) a 5 lobi ed ermafroditi; acheni centrali a 10 coste e alati. Simile a Leucanthemum dal quale si distingue fra l’altro per gli acheni periferici diversi da quelli centrali; simile pure a Coleostephus che ha acheni periferici ricurvi, non triqueti e foglie tutte dentate (Glebionis ha acheni periferici dritti o poco ricurvi e nettamente a 3 angoli ben visibili in sezione e almeno alcune foglie più profondamente divise).
-Glebionis coronaria (L.) Spach CRISANTEMO GIALLO
T scap – Medit. - IV-VII – Rarissimo.
Erbacea glabra, di odore sgradevole, alta 20-60 cm, a fusto eretto e molto ramoso; si caratterizza per le foglie per lo più pennatopartite a lobi lanceolati e mucronati (le cauline abbraccianti); capolini grossi (diametro 3-5 cm), solitari e terminali con peduncolo ingrossato in alto e a fiori ligulati interamente gialli o bianco-gialli; squame involucrali a bordo spesso nerastro; acheni del disco trigoni con angoli alati.
Habitat: incolti, campi.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Poggio alla Malva (Carmignano).
-Glebionis segetum (L.) Fourr. CRISANTEMO DEI CAMPI
T scap – Euro-Medit. - IV-VII – Comune.
Erbacea glabra, a fusto eretto, alta 20-60 cm; foglie tutte più o meno glaucescenti con le superiori da profondamente dentate a pennatopartite; i capolini sono grandi (2-4 cm di diametro), solitari e terminali, con involucro largo e a squame marginate di bruno; i fiori centrali sono tubulosi e i periferici ligulati di colore giallo; gli acheni sono sprovvisti di corona e quelli del raggio sono alati sulle coste laterali.
Habitat: campi, coltivi, vigne.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Chrysanthemum segetum); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Montalbano: PG13: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Chrysanthemum segetum L.): Podere Pianali e ex-cava Guarino (Montemurlo); Podere Baylon (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: PG13b (C/S).
PS: vegeta nei campi e sembra sia molto apprezzato dal punto di vista alimentare dai bovini: viene chiamato infatti in italiano anche Ingrassabue.
Il genere Gnaphalium
ha distribuzione cosmopolita e conta un quarantina di specie (recentemente molte specie ad esso attribuite sono state inserite in nuovi generi; in Italia 1 sola specie spontanea ed 1 naturalizzata). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni, a foglie intere e alterne, con capolini - a fiori solo tubulosi e gialli o giallastri (i centrali a stilo bifido) - riuniti spesso in glomeruli: hanno ricettacolo privo di pagliette e squame involucrali in 3-4 serie.
-Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum CANAPICCHIA PALUSTRE
T scap – Eurosib. - VI-X – Rara.
Erbacea tomentosa, alta 5-25 cm, a fusto eretto o ascendente e per lo più ramificato dal basso; foglie intere, acute, spatolato-lineari, sessili, ma non abbraccianti; le superiori, sottili, circondano e superano i capolini; questi ultimi, immersi alla base in un tomento biancastro, sono raggruppati in glomeruli compatti e terminali; squame involucrali di colore bruno-chiaro; acheni piccoli, ispidi e a pappo caduco.
Habitat: aree umide, zone boschive fresche.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Gestri in Peruzzi & al. 2024: a ovest de Le Cavallaie, sentiero CAI 70, loc. Spuntoni (Cantagallo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Pianura: Foggi & Venturi 2009: lago Ombrone nella zona delle Caserane (Prato).
- Poggio alle Croci: PG13b (S): sopra C. Renai.
Il genere Hedypnois
conta 4 specie a distribuzione euro-mediterraneo-W-asiatiche (1 in Italia). Si tratta di piante erbacee inermi a soli fiori ligulati, con squame involucrali verde-opache, in due serie: le esterne brevi ed ineguali e le interne più lunghe ed eguali fra loro; foglie basali da intere dentate a pennatolobate, le cauline presenti; acheni lunghi 5-8 mm, i centrali a pappo di segmenti sottili e allungati e gli esterni con all’apice una coroncina dentata.
-Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt RADICCHIO PALLOTTOLINO
T scap – Medit. - III-VI – Raro.
Erbacea poco pelosa, a fusto eretto o ascendente e ramificato, alta 5-30 cm; foglie inferiori e basali a picciolo alato, lamina ellittica e setolosa sul bordo (a volte anche sulle facce), intere, dentate, sinuate o pennato-lobate, le superiori sessili e per lo più intere; capolini ± numerosi di 13-16 mm di diametro, spesso pendenti prima della fioritura, con peduncolo ingrossato in alto, corolla di soli fiori ligulati giallo-oro e involucro inizialmente cilindrico e poi, alla fruttificazione, globoso con squame in 2 serie, arcuate e aperte a circondare i frutti ± ricurvi, lunghi 5-7,5 mm e scabri.
Habitat: incolti, zone prative aride e assolate.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub H. polymorpha); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Leontodon rhagadioloides (L.) Enke & Zidorn): Prato.
- Localizzazioni generiche: Baroni 1987-1908 (sub H. polymorpha DC.): Prato (Somm. herb.).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): a S di Villa Filicaia.
Il genere Helianthus
è costituito da una cinquantina di specie N-americane (in Italia 5-6 naturalizzate o avventizie, più 1-3 ibridi). Si tratta di specie erbacee perenni (raramente annuali), normalmente di discrete dimensioni, a foglie intere, alterne, con capolini grandi a disco piatto o poco convesso, fiori esterni ligulati e raggianti (sterili) e centrali tubulosi (ermafroditi); acheni simili fra loro con pappo a 2-6 scaglie ineguali e presto caduche.
Foto A. Ciociola
Foto M. Ziletti
-Helianthus annuus L. GIRASOLE COMUNE
T scap – Pianta coltivata o neofita occasionale di orig. S-Americana – VII-X – Raramente subspontaneizzata.
Erbacea a grosso fusto eretto e setoloso, alta 60-250 cm; si caratterizza per le grandi foglie ovate (le maggiori subcordate) e picciolate, capolini grandi (10-30 e fino a 50 cm di diametro) con fiori ligulati gialli (lunghi fino a 10 cm) e tubulosi bruni; frutto lungo 1-2 cm in forma di piccola mandorla.
Habitat: coltivato e a volte presente occasionalmente in campi e incolti.
Distribuzione sul territorio:
coltivato nel territorio della Provincia: citato come casuale sul Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
?-Helianthus pauciflorus Nutt. GIRASOLE SELVATICO
H scap/G rhiz – Neofita naturalizzata di orig. N-Americ. - VII-X – Raro.
Erbacea rizomatosa, a fusto ruvido, eretto e a volte ramificato verso la sommità, alta 100-300 cm; foglie opposte a picciolo alato e lamina da lanceolato-lineare, a -ovata, -rombica, con stipole acute; capolino largo 7-10 cm, a fiori ligulati gialli e lunghi fino 5 cm, acuti o bidentati e tubulosi bruno-nerastri; squame involucrali patenti e scure al centro; achenio glabrescente di 5-6 mm. Vedi H. x laetiflorus.
Habitat: zone umide: incolti, sponde fluviali, lacustri ecc.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Arrigoni & Viegi 2011: Prato; dubbio in Gestri & Peruzzi 2016.
-Helianthus tuberosus L. GIRASOLE DEL CANADA, TOPINAMBUR
G bulb – Neofita naturalizzata di orig. N-Americ. - VIII-X – Relat. comune.
Erbacea dotata di un grosso rizoma fusiforme, a fusto eretto, alto fino a 2 m; le foglie sono alterne in alto e opposte in basso, intere, di forma lanceolata acuta e dentellate al margine; il grande capolino (fino a 10 cm di diametro) ha fiori ligulati esterni (12-15, lunghi circa 2-2,5 cm) e tubulosi interni gialli; squame involucrali ciliate. Vedi sotto H. laetiflorus!
Habitat: aree erbose antropizzate e zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (molti da riferire a H. x laetiflorus Pers.).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: cassa espansione Ombrone (Prato).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Topinanbur): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: lungo il T. Bagnolo (Montemurlo); lungo il T. Bardena, presso il laghetto di Galceti (Prato); Arrigoni & Viegi 2011.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: statale di Pistoia presso Ponte ai Confini (2023) (Carmignano); alveo del Bisenzio presso P. Datini (2024) (Prato).
NB: è pregiata specie alimentare, spesso coltivata per i suoi tuberi ricchi di inulina e poveri di amido, così da essere particolarmente adatti a diete ipocaloriche e dimagranti; in più sono di facile digeribilità e di aiuto nella stipsi.
C’è il fondato sospetto che alcune segnalazioni di questa specie debbono in realtà attribuirsi al suo ibrido, H. x laetiflorus Pers.
-Helianthus x laetiflorus Pers. GIRASOLE IBRIDO
H scap – Neofita naturalizzata o occasionale di origine antropica – VIII-XI – Probabilmente più comune di quanto indicato di sotto.
Simile ai precedenti essendo un ibrido fra i due = H. pauciflorus x H. tuberosus:
Differenziazione con H. pauciflorus: le squame involucrali di H. pauciflorus sono ovate ad apice acuto, la faccia abassiale delle foglie è da ispida a glabrescente; le squame involucrali di H. x laetiflorus sono oblunghe-lanceolate ad apice acuminato e la faccia abassiale delle foglie è pelosa.
Differenziazione con H. tuberosus: H. x laetiflorus ha squame involucrali disuguali fra loro, ovate e quasi del tutto appressate, mentre H. tuberosus le ha subuguali, quasi lineari, con almeno l'apice distanziato dall'involucro; inoltre le foglie di H. x laetiflorus sono essenzialmente lanceolate, quelle di H. tuberosus, soprattutto le maggiori, sono ovate con base sub-troncata che poi decorre nel picciuolo.
Habitat: aree erbose antropizzate e zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: alveo del Bisenzio a N di Gonfienti e oltre, a livello di Viale Galilei (2023) (Prato)
Il genere Helichrysum
è ricco di specie (oltre 600) distribuite in Europa e Africa, ma anche in Australia e in Asia (8 in Italia con diverse sottospecie). Si tratta di piante erbacee, a volte suffruticose, a fiori solo tubulosi: i periferici in un solo rango sono femminili e poco numerosi, i centrali sono ermafroditi e più numerosi; le foglie si presentano intere; le squame involucrali, lucenti e colorate di giallo ± vivace sono embricate fra loro e conniventi; i capolini si raggruppano generalmente all’apice delle ramificazioni a formare corimbi irregolari; gli acheni sono dotati di pappo.
-Helichrysum italicum (Roth) G. Don. s.l. TIGNAMICA, PERPETUINI ITALIANI
Ch suffr – S-Europ. - V-IX – Relat. comune.
Suffrutice coperto da tomento biancastro, con fusto lignificato in basso e contorto, aromatico (libera un profumo che ricorda il curry), alto 20-40 cm; le foglie sono intere, sottili e lunghe 1,5-3 cm, con margine revoluto; i capolini - larghi meno di 4 mm, a 10-25 fiori giallo-chiari tutti tubulosi e lunghi 3-3,5 mm, con involucro conico formato da brattee giallo-brune sovrapposte, le interne ghiandolose -sono riuniti in numero di 20-30 in densi corimbi; il frutto è un achenio densamente coperto di ghiandole.
Habitat: ambienti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub H. angustifolium DC.): Montepiano (Caruel herb.); Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Schignano (Vaiano) a Migliana, Codilupo, sopra gli Acquiputoli (CAI 32) (2018), M. delle Scalette (2023) (Cantagallo); Faggeta sopra F. del Romito, sopra il Gorandaccio (2022) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Tignamica): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub H.i. (R.) Don var. typicum Fiori); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: su rocce e pietraie serpentinose, ma anche in zone non ofilitiche (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C).
- Poggio a Caiano: Maugini 1946: Poggio del Cerreto (a W del Bargo).
PS: il nome deriva dal greco, helios, sole, e chryson, oro, per il colore dei fiori; l’epiteto è riferito al fatto che è comune in Italia, dove si incontra soprattutto nelle aree termofile e assolate.
Il genere Helminthotheca
è costituito da 4-5 specie erbacee a distribuzione mediterranea (2 in Italia). Le sue specie, laticifere e a soli fiori ligulati, sono molto simili a quelle del genere Picris (vedi) di cui hanno fatto parte fino a pochi anni fa; si differenziano per le squame involucrali poste in due serie e con la larghezza di quelle esterne maggiore di 4 mm; inoltre per la presenza del becco negli acheni (almeno in quelli centrali).
-Helminthotheca echioides (L.) Holub ASPRAGGINE VOLGARE
T scap – Euro-Medit.- VI-VIII – Comune.
Erbacea annuale (a volte bienne), ispido-irsuta (= Aspraggine), a fusto ascendente con numerose ramificazioni e alto 30-60 cm; le foglie basali sono ellittico-oblunghe con picciolo alato e margine della lamina ondulato, le superiori più piccole, ovali, sessili o abbraccianti, tutte verrucose. La specie si riconosce abbastanza bene per i capolini (di circa 1,5 cm di diametro e con soli fiori ligulati gialli, riuniti in corimbo irregolare) che hanno brattee involucrali esterne molto larghe, ovali e cordate alla base (le interne lineari e mucronate).
Habitat: campi, ruderi, incolti erbosi e a margine di coltivi e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Sasseta a Montepiano (2021) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Picris echioides L.): ofioliti e ambienti antropizzati.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: incolti e campi fra Iolo e Caserane (2023) (Prato).
NB: è specie commestibile: le foglie basali giovanili vengono lessate (da crude sono un po’ troppo ispide), spesso con altre erbe, e condite con olio, sale e pepe.
Gli Hieracium
appartengono ad un genere assai complesso dal punto di vista sistematico e non solo: il numero di specie è assai elevato e queste si differenziano spesso per minuti particolari che richiedono spessissimo la consulenza di uno specialista specifico per questo genere; il motivo di queste difficoltà tassonomiche è legato al fatto che quasi tutte le entità sono apomittiche, ovvero si moltiplicano in maniera asessuata (senza l’unione di gameti maschili e femminili provenienti da piante diverse) e le piante che si formano sono geneticamente uguali alla pianta madre; ciò porta ad avere disparate popolazioni di individui identici. Attualmente (Pignatti 2019) gli studiosi tendono ad identificare e descrivere delle specie principali localizzate ± ampiamente su un dato territorio. Esistono però moltissime forme di passaggio fra queste, ancor più difficilmente classificabili. Molte delle entità descritte qui di seguitorappresentano, più che una singola specie, un gruppo di forme morfologicamente vicine.
Le piante ascrivibili a questo genere sono rappresentate da erbacee perenni - circa 4000 specie a distribuzione subcosmopolita - caratterizzate da: foglie intere o divise ed alterne; capolini ± numerosi a soli fiori ligualti gialli (a volte aranciati), con squame involucrali in 2-4 serie e ricettacolo privo di pagliette; achenio obconico, ristretto in basso e allargato in alto con pappo di peli posti su due serie e di colore bianco-sporco (questi caratteri lo differenzia dal genere Crepis dotato di achenio ristretto in alto e pappo di peli bianco-nivei). Limiteremo la descrizione delle specie che seguono ai caratteri più importanti e di facile individuazione.
-Hieracium bifidum Kit. ex Hornem SPARVIERE INCISO
H ros/H scap – Orofila S-Europ. - VII-VIII – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, poco ramificato, alta 20-50 cm, foglie coriacee soprattutto basali in rosetta (cauline 1-2 ridotte), a lamina da ovato-ellittica a oblungo-lanceolata, da dentellata a lobato-dentata, verde o violacea e spesso maculata di nero, con picciolo di lunghezza analoga alla lamina (4-9 cm); capolini (diametro 2-2,5 cm) poco numerosi (3-1 e a volte di più) riuniti in pannocchia lassa, con squame involucrali biancastre per numerosi peli stellati misti a più radi peli semplici nerastri e prive di peli ghiandolari.
Habitat: radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Cantagallo alla Rasa, Acquiputoli, vetta del Cicialba, (2019), Codilupo (2023) (Cantagallo); da Luciana a P. di Petto, d Montecuccoli alla Dogana, sopra il Gorandaccio (2018), a S di Gricigliana, Alpe Cavarzano verso il M. Scoperta (2017); sopra il Gallo di Vernio; dal Tabernacolo alle Scalette (2022) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo, Vaiano.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
?-Hieracium dentatum Hoppe SPARVIERE DENTATO
H ros/H scap – S-Europ.-S-Siber. - VI-VIII – Rarissimo o assente.
Erbacea alta 10-40 cm, a fusto eretto, caratterizzata da un denso rivestimento di peli semplici che a livello dell’involucro nascondono l’epidermide; foglie molli, le basali picciolate, le cauline (2)3-6(8) un po’ ridotte e sessili, a lamina da ellittica a oblungo-lanceolata, ± dentate; capolini pochi, a ligule gialle in alto con denti brevemente ciliati; squame involucrali lineari-lanceolate e acuminate con peli almeno alla base neri.
Habitat: praterie rocciose e roccaglie.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale, rarissimo.
-Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli SPARVIERE DI GROVES
H scap – Endemismo italiano – V-VIII – Raro.
Erbacea perenne a fusto eretto, alto da 20 a 70 cm; si caratterizza per avere capolini generalmente numerosi con involucro coperto di peli ghiandolari e non, squame ottuse, le medie senza peli stellati in alto; foglie basali e inferiori del fusto lungamente picciolate e con lamina dentellata di forma triangolare o rombica più o meno allungata; foglia caulina più bassa posta a ca. metà del fusto, inguainante (non auricolata, né dilaltata).
Habitat: boschiva.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
NB: sicuramente presente anche altrove.
-Hieracium lachenalii Sutter SPARVIERE DI LACHENAL
H scap – Europ.-Caucas. - V-VIII – Raro.
Erbacea a fusto eretto, alta 30-80 cm; foglie basali poco numerose, a lamina ellittica o lanceolata, intere o inciso-dentate ed attenuate in un picciolo, le cauline da 3 a 8 (a volte di più), lanceolate, le superiori sessili, ma mai amplessicauli, lanceolate, verde-scure e spesso arrossate e con densi lunghi peli; capolini riuniti in infiorescenza relativamente compatta, a fiori ligulati gialli, involucro lungo ca. 1 cm con squame involucrali ghiandolose, lanceolato-lineari e con linea scura centrale, peduncoli tomentosi e biancastri con grosse ghiandole nerastre.
Habitat: nemorale soprattutto su suoli acidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub H. lachenalii C.C. Gmel.): Limentra orientale.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016 (sub H. lachenalii C.C. Gmel.): Cantagallo: rio Alesse, collina a NE di Cambiaticcio.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Sparviere comune): AMPIL del Monteferrato.
-Hieracium murorum L. SPARVIERE DEI BOSCHI o DEI MURI
H scap – Euro-Sib. - V-VIII – Comune.
Erbacea perenne, a fusto ramificato in alto, di 20-40 cm; è dotato di peli ghiandolari e peli a stella; le foglie basali, picciolate, hanno forma ovale o allungata, in basso cordiformi o troncate, dentellate al margine e dotate di peli semplici, a volte sono maculate di nero; i fiori, solo ligulati e gialli, sono riuniti in capolini a formare un'infiorescenza pauciflora a panicolo; l'involucro è molto ghiandoloso; gli acheni sono scuri e lunghi circa 3,5 mm.
Habitat: soprattutto boschi, ma anche arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & Viciani 2001 (sub H. sylvaticum (L.) L.); Arrigoni & al. 2002 (sub H. sylvaticum (L.) L. e H.m. L.): a Monachino, Le Cave, presso C. Lavacchio ecc.; Arrigoni & al. 2005 (sub H. cf sylvaticum (L.) L. e H. murorum L.): riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra Migliana, Cavallaie, Castagneto a S di Chiusoli (2018) (Cantagallo); Cavarzano e crinale sopra il Gallo verso Monte (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Arrigoni & al.1983; Biagioli & al. 2002: pineta chiara anche su substrato serpentinoso maturo.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
?-Hieracium pallidum Biv. SPARVIERE A FOGLIE SETOLOSE
H scap – Endemismo italiano - V-VIII – Rarissima.
Erbacea di 10-40 cm, a fusto eretto, peloso in basso e ghiandoloso in alto, che si caratterizza per le foglie coperte, soprattutto sui lunghi piccioli, di peli setolosi ingrossati alla base di 2-10 mm che le conferiscono un colore chiaro; le foglie sono prive di macchie scure ed hanno lamina lanceolata acutamente dentata o laciniata; le foglie cauline sono mancanti o ridotte a solo 1-3; i capolini, in numero di 2-12, hanno l’involucro, ovato e troncato in basso, privo o quasi di peli stellati e con squame involucrali acuminate; i fiori ligulati e gialli e sono ciliati in alto.
Habitat; rupi e luoghi sassosi o rocciosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
?-Hieracium picenorum Gottschl. SPARVIERE DEL PICENO
H scap – Endemismo italiano – V-VIII – Rarissimo.
Erbacea alta da 20 a 40 cm, descritta recentemente (2012) dall’esperto del settore G. Gottsclich, che ha anche determinato la specie presente nel Pratese, ma solo su foto (quindi con qualche dubbio!). Appare come una forma di passaggio fra H. bifidum e grovesianum: si caratterizza per le foglie basali tronche sul picciolo o ristrette brevemente, le cauline ridotte, in numero di 1-2 e dalle squame involucrali al margine con abbondanti peli stellati.
Habitat: nemorale.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Acquiputoli (03-07-2019) (Cantagallo). Prima segnalazione per il Pratese e seconda per la Toscana.
-Hieracium pseudogrovesianum Gottschl. SPARVIERE MASCHERATO
H scap – Endemismo italiano – VI-VII – Raro.
Erbacea a fusto verde ed eretto, alta 20-60 cm; caratterizzato da: prima foglia caulina inserita subito sopra le basali (in numero da 3 a 7) anche a meno di 5 mm, con picciolo ± alato e un po’ allargato all’inserzione; capolini a fiori ligulati gialli e riuniti in infiorescenza a racemo o panicolo; squame involucrali posizionate indistintamente a tegole del tetto e larghe 1-1,3 mm.
Habitat: nemorale.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Acquiputoli (03-07-2019) (Cantagallo). Prima segnalazione per il Pratese (determ. da G. Gottsclich).
-Hieracium racemosum Waldst. & Kit. SPARVIERE RACEMOSO
Erbacea perenne, alta da 30 a 90 cm, a fusto eretto, ispido in basso e terminante in alto in un ampio racemo di numerosi capolini; si caratterizza per la perdita, all'antesi, delle foglie basali e per la presenza in basso sul fusto di un aggregato di 6-9 foglie ellittiche con dentellatura poco appariscente e ristrette in basso all'inserzione, ma senza picciolo; le numerose foglie cauline al di sopra di questo aggregato si mostrano di taglia progressivamente ridotta; gli acheni sono scuri.
--H. racemosum subsp. italicum Fr. ex Zahn SPARVIERE RACEMOSO ITALIANO
H scap – Orofila Europea – VII-IX – Relat. comune.
Erbacea simile alla subsp. virgaurea ma di dimensioni inferiori. Foglie a lamina poco dentellata e con breve picciolo e capolini con involucro inferiore al cm.
Habitat: boschivo.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub H. crinitum Sibth): Montepiano (Car. In Belli II); Venturi 2006 (sub H. italicum Fries): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Montepiano a Badia (2022) (Vernio).
--H. racemosum subsp. Waldst.& Kit. ex Willd. subsp. racemosum (Cosson) Zahn
H scap – Europ. - VI-IX – Comune (da recenti indicazioni sembra addirittura di dubbia presenza in Toscana, per cui probabilmente le segnalazioni seguenti vanno attribuite ad altra sottospecie!).
Vedi descrizione della specie.
Habitat: nemorale.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021
- Calvana: Gestri 2009 (sub H. heterospermum Arv.-Touv.) e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Montalbano: Arrigoni & Viciani 2001 e Viciani 2001 (sub H. racemorum Waldst.& Kit.): Fornia (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
--H. racemosum Waldst.& Kit. ex Willd. subsp. virgaurea SPARVIERE VERGA D’ORO
H scap – CO-Medit. - VI-IX – Relat. comune.
Erbacea a fusto robusto ed eretto, alta 20-40 cm che si distingue dalla subsp. nominale soprattutto per le foglie distintamente picciolate, a lamina ovata, quelle al di sopra dell'aggregato inferiore del fusto si fanno da subito assai ridotte e più brevi (invece che progressivamente), ed infine per i capolini del racemo superiore a peduncolo breve.
Habitat: zone rupestri e zone fresco-umide, anche di bosco.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005 (sub H. virgaurea Coss.): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub H. virgaurea Coss.): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Montepiano verso Poggio di Petto e presso la Badia (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 (sub H. virgaurea Coss.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 2006: forre, ambienti rocciosi preferibilmente calcarei.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, Poggio a Caiano.
- Monteferrato: nuovi ritrovamenti: rarissimo sul Monteferrato (2017).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Hieracium sabaudum L. SPARVIERE DI SAVOIA
H scap. - Europ.-Caucas. - VIII-X – Relat. comune.
Erbacea perenne a fusto eretto abbondantemente ramificato in alto, sparsamente peloso e alto da 30 a più di 100 cm; le foglie cauline distribuite in maniera omogenea sul fusto, sessili e dentellate, sono abbastanza numerose e grandi, soprattutto quelle più basse, poi progressivamente ridotte; le basali, sempre sessili, si seccano precocemente e sono scomparse all'antesi; i capolini (di circa 1,5 cm di diametro) sono disposti in panicolo lasso in numero di 20-40; acheni scuri di 3-3,5 mm.
Habitat: nemorale, anche in boschi cedui e arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub H. boreale (Fries) Zahn): rr Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: strada per l’Alpe di Cavarzano (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: a NE della Briglia (Vaiano).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Baroni 1897-1908 (sub H. boreale Fr. var. sabaudum L.: alla base del M. Ferrato presso Prato (herb. Levier- det. Belli); Fiori 1914 (sub H. boreale Fr. var. sabaudum L.): non ritrovato; Messeri 1936 lo riporta sotto due denominazioni (H. sabaudum L. var. boreale (Fr) e H. boreale Gries var. subsabaudum Rchb. (Herb. Levier! Det. Belli), ma non ritrovato né da lei né da Fiori 1914; Biagioli & al. 2002: ville di Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
?-Hieracium schmidtii Tausch SPARVIERE DI SCHMIDT
H scap/H ros – W-Europ.-Subatlant. - IV-VII – Rarissimo.
Molto simile a H. pallidum (con cui alcuni Autori lo identificano), caratterizzato dalle foglie per lo più lanceolate, ± attenuate alla base, con dense setole bianche o giallastre, lunghe fino a 10 mm, soprattutto sui piccioli, sulla nervatura centrale sulla faccia inferiore.
Habitat: ambienti rocciosi.
Distribuzione sul territorio:
Calvana: Gestri 2009: ostrieti al M. Bologna (Vaiano); non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2016.
??-Hieracium pallescens Waldst. & Kit. subsp. subpatulum (Zahn ex Benz) Greuter
Segnalato per errore da Venturi 2006 (sub H. incisum Hoppe s.l.) alla Limentra Orientale: non sembra presente neppure in Italia!
Il genere Hyoseris
conta 5 specie di area mediterranea (3 in Italia). Si tratta di piante erbacee a soli fiori ligulati gialli, portati da capolini unici terminali al caule indiviso; foglie pennatosette e solo basali in rosetta; acheni privi di becco e di 2 forme assai diseguali: gli interni, compressi, oblunghi e dotati di pappo di setole giallastre, gli esterni corti e filiformi con pappo di ciglia brevi.
PS: la derivazione del nome dal greco è curiosa: us = porco e seris = cicoria: cicoria dei porci; almeno alcune sue specie sono radicchi di discreto sapore, ma probabilmente solo per i porci per il botanico (Linneo) che ha dato il nome a questo genere!
-Hyoseris radiata L. TRINCIATELLA, LUCERTOLINA
H ros – Medit.- I-XII – Comune.
Erbacea perenne, a foglie solo basali e scapi eretti senza ramificazioni, con al culmine un solo capolino (4-4,5 cm di diametro) a fiori tutti ligulati e di colore giallo (gli esterni spesso sono verdastri e/o arrossati); è facilmente riconoscibile per le foglie caratteristicamente “roncinate”, con segmenti laterali triangolari-acuti e il superiore trifido.
Habitat: muretti a secco, margini di sentieri e strade, prati e scarpate rocciose, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Usella al Santo (2022); Alpe di Cavarzano (2018) (Vernio); margine strada per Migliana da Vaiano (2018) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi, Monte Buriano (Prato).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub H. radiata L. var. typica Fiori); Biagioli & al. 2002: Podere Ciabatti, parco di Galceti, Porticciole (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C).
- Pianura: si incontra in varie zone incolte e a margine di coltivi.
PS: le giovani foglie sono commestibili e possono essere consumate sia crude che lessate.
Il genere Hypochoeris
conta una sessantina di specie a distribuzione eurasiatica, N-africana e S-americana (8 in Italia). Le sue piante sono caratterizzate da un fusto e un capolino (a soli fiori ligulati gialli, con ricettacolo a scaglie lineari caduche e involucro a squame molto diverse e embricate) solitari (o pochi), le foglie basali grandi e numerose e le cauline di dimensioni ridotte; gli acheni normalmente hanno un lungo becco (esclusi i periferici) con pappo setoloso. Si distingue dal genere Leontodon, molto simile, soprattutto per il ricettacolo dotato di pagliette.
-Hypochoeris achyrophorus L. COSTOLINA ANNUALE
T scap – Medit. - II-VII – Comune.
Si distingue dalle specie congeneri per essere una pianta erbacea annuale (il ciclo vitale si conclude in meno di 12 mesi e normalmente le radici sono più “gracili” di quelle delle piante perenni), avere le brattee dell’involucro coperto di peli rigidi e squame involucrali uguali e in un singolo rango (con qualche eventuale piccola squama basale). Ha fusto spesso ramificato e alto 5-30 cm; foglie della rosetta basale con lamina da spatolata a ovale, dentellata o meno e foglie cauline (ridotte: 20-30 mm) poche o assenti; i capolini (lunghi 12-15 mm) sono solitari e con fiori ligulati giallo-dorati o aranciati; acheni lunghi circa 6 mm.
Habitat: incolti, prati, zone ruderali e margini di coltivi assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Montecuccoli alla Dogana sopra il Gallo; sentiero CAI 20 (2023) (Vernio); Migliana (2022) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub H. aetnensis); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub H. aetnensis); Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub H. aetnensis); Messeri 1936 (sub H. aetnensis C.P. & G. var. foliosa Arc.); Biagioli & al. 2002: non ritrovata; oss. Gestri 2014 Wikiplantbase#Toscana: poggio Cassapanca del Monteferrato (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Hypochoeris glabra L. COSTOLINA LISCIA
T scap – Euro-Medit. - IV-V – Relat. comune.
Erbacea per lo più glabra (a volte con setole sparse), di 5-40 cm, a fusto eretto o ascendente, semplice o ramificato in alto; le foglie tutte basali (qualche squama sul caule in alto), oblunghe (max larghezza sotto la metà), attenuate alla base, da dentato-sinuate a pennatolobate a lobi acuti; capolini di 2-4 cm, a soli fiori ligulati gialli; si caratterizza fra le congeneri per essere specie annuale con foglie glabre o quasi e squame involucrali diverse fra loro ed embricate in più serie; acheni centrali attenuati in un becco, gli esterni per lo più senza becco.
Habitat: specie acidofila di incolti, radure, roccaglie, margini di coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Baroni 1897-1908: M. Javello (Somm. herb.) (2021) (Vaiano); nuovi ritrovamenti: Terrabianca (2018) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub H. g. var. minutissima), citata (H. g. L. var. minutissima Dntr.) ma non ritrovata da Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: Sassi Neri, Gretaia (Montemurlo) e nella parte pratese.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Hypochoeris maculata L. COSTOLINA MACCHIATA
H ros – Eurosib. - V-VII – Rara.
Erbacea a grossa radice verticale, fusto peloso-ispido, eretto, semplice o 2-3 volte diviso, un po’ ingrossato- tubuloso sotto il capolino, alta 20-60 o più cm; foglie tutte radicali in rosetta (1-2 squamette sul caule), da oblunghe ad ovali, intere o sinuato-dentate, con macchie nerastre sulla faccia superiore; capolini solitari terminali di 40-60 mm di diametro, a fiori ligulati gialli terminanti in 5 dentelli, e squame involucrali in molte serie, scure in alto; achenio con pappo a setole tutte piumose.
Habitat: acidofila di prati e radure boschive aride.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub H.m. L. f. monocephala Fiori); Biagioli & al. 2002: solo nelle pinete dei vers. E e N del M. Chiesino (Prato e Montemurlo).
PS: in Calvana questa specie è presente in territorio fiorentino (P. Farnetto e Sarto, Calenzano) su substrato acido (Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016); anche sul Montalbano è presente, ma solo in provincia di Pistoia su analogo substrato (Gestri & Peruzzi 2013a).
-Hypochoeris radicata L. COSTOLINA GIUNCOLINA
H ros – Europ.-Caucas. - IV-VII – Comune.
Erbacea a fusto solitario o plurimo,nsemplice o poco ramoso, alta 30-80 cm; radice carnosa e dotata di grosse ramificazioni (radicata!); foglie solo basali in rosetta, aderenti al terreno, consistenti, vellutate, a lamina spatolata sinuata o pennatifida a lobi ottusi; capolini solitari di 20-40 mm e terminali, a fiori gialli e involucro con brattee lanceolate e scariose al margine; pappo di circa 1 cm.
Habitat: prati, pascoli, incolti, margini di sentieri e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Arrigoni & al 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limetra orientale; nuovi ritrovamenti: Montepiano (2019) (Vernio); strada bianca da Migliana a Le Cavallaie (2018), verso Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946, Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub H.r. L. var. typica Fiori); Biagioli & al. 2002: anche su serpentine, ma soprattutto in zone marginali (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2022).
NB: le foglie, da giovani, possono essere utilizzate come radicchio, sia da crude che lessate.
Il genere Jacobaea
conta circa 35 specie erbacee distribuite in Eurasia (poco meno di una ventina in Italia). E’ molto simile a Senecio, nel quale era incluso fino a poco tempo fa (vedi per confronto); se ne differenzia essenzialmente per la presenza di 1-2 squame involucrali esterne, lunghe 2/5 delle interne o più (più brevi in Senecio); in molte specie inoltre le piante sono rivestite da un fitto feltro di peli sottili e sinuosi, ed alcune foglie cauline superiori hanno lunghi denti presso l’inserzione sul fusto; ma le differenze principali fra i due generi sono genetiche (nella sequenza del DNA) più che morfologiche.
-Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. SENECIONE DEI FOSSI
H bienn – C-Europ.-Submedit. - VI-X – Relat. comune.
Robusta specie erbacea bienne, alta a volte anche oltre 1 m; ha capolini a fiori gialli solo ligulati, del diametro di 12-22 mm, che formano un corimbo a rami divaricati (con un angolo, col ramo principale, che si aggira sui 50°); caratteristiche le foglie mediane del fusto che presentano i lobi laterali che divergono dal rachide quasi ad angolo retto, inoltre le foglie si presentano pennatosette o lirate (le cauline a 2-3 paia di segmenti) con il lobo superiore molto più grande dei laterali. Si distingue da J. erucifolia per le squame involucrali esterne in numero di 3, e da J. vulgaris per le foglie cauline con 2-4 paia di segmenti con il superiore maggiore dei laterali, inoltre per i capolini riuniti in infiorescenza allungata.
Habitat: ambienti umidi e fra le macerie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Senecio erraticus Bertol.): presso Fossato; nuovi ritrovamenti: da Spedaletto verso Acquerino (2023) (Cantagallo); vers. E del M. Scoperta (2018), S.Giuseppe (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Senecio jacobea var. barbaaefolius); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 (sub Senecio aquaticus Hill) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Senecio erraticus Bert.): Gretaia (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: giardini a Galcetello (2024) (Prato).
-Jacobaea erucifolia (L.) P. Gaertn., B. Mey & Scherb. subsp. erucifolia SENECIONE SERPEGGIANTE
H scap – Eurasiat. – V-X – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto e peloso, ramificato fin dal basso, alta 40-120 cm; si caratterizza per le foglie simili a quelle della rucola (come ricorda il nome erucifolia), ovvero profondamente divise con area centrale larga 2-3 mm, lacinie laterali aperte ad angolo retto e dentellate solo sul lato esterno; i capolini (diametro 1,5 cm circa), a fiori ligulati gialli, formano un ampio corimbo con ramificazioni divaricato-patenti. Si distingue dalle altre due specie congeneri per le squame involucrali piccole e lunghe fino alla metà dell’involucro (le altre al max fino a ¼ dell’involucro), che divengono eretto-patenti alla fioritura, quelle esterne in numero di 4-6 e per i segmenti laterali delle foglie stretti e con il lobo superiore un po’ più grande dei laterali, le foglie a lembo pubescente arenoso di sotto, gli acheni tutti pubescenti.
Habitat: ambienti fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Senecio erucifolius L.): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra il Gorandaccio, Gasperone (2018) (Vernio); da Migliana alle Cavallaie (2022) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 (sub Senecio erucifolius L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Seano loc. il Castro (2023) (Carmignano).
?-Jacobaea vulgaris Gaertn. SENECIONE DI S. GIACOMO
H bienn/H scap – Paleotemp. - VI-X – Rara, scomparsa o determinazioni inesatte.
Erbacea alta 30-100 cm, a fusto con rami generalmente presenti in alto ed eretti o quasi; foglie, le inferiori (spesso scomparse all’antesi) con picciolo e pennato-lirate, le altre sessili (o auricolate) e pennatopartite a 5-7 coppie di segmenti subuguali; capolini (15-20 mm di diametro) terminali, a fiori tubulosi, gialli, con 12-15 ligulati in una unica serie, piccoli di ca. 1 cm, riuniti in corimbo (raggiungono tutti ± la stessa altezza); acheni centrali pelosi e esterni glabri con pappo caduco. Si distingue da J. erucifolia per le squame involucrali esterne in numero di 3, più brevi (non superiori a ¼ dell’involucro) e da J. erratica per le foglie cauline a 5-7 paia di segmenti uguali fra loro, a volte il superiore un poco più grande, foglie basali essicate all’antesi e i capolini riuniti in infiorescenza corimbosa (tutti posti quasi alla stessa altezza).
Habitat: prati assolati e aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub Senecio jacobaea L.); non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Senecio jacobaea L.): anche su ofioliti, in posizione di mezz'ombra e su terreno abbastanza maturo.
Forse le segnalazioni di cui sopra sono da riferire a J. erratica, anche perché mancano segnalazioni recenti in tutta la Toscana.
Il genere Lactuca
ha distribuzione subcosmopolita con oltre 70 specie (11 in Italia); si tratta di erbacee a succo lattiginoso (da cui il nome), con capolini a fiori tutti ligulati, poco numerosi, gialli o violetti; involucro cilindrico con squame alla base; ricettacolo senza pagliette; acheni fortemente compressi e bruscamente terminanti in un lungo becco sottile; pappo bianco. Si differenzia dal simile genere Crepis soprattutto per i pochi fiori ligulati del capolino (meno di 20) e in molte specie per il loro colore viola-porporino.
PS: il succo di alcune specie sembra avere effetti sedativi sul sistema nervoso centrale.
-Lactuca saligna L. LATTUGA SALCIGNA
T scap/H bienn – Euro-Medit.-Turan. - V-IX – Comune.
Erbacea a fusto esile, eretto, semplice o ramificato dal basso, alta 50-100 cm; foglie senza spinule (o molto raramente), le inferiori per lo più pennatopartite/roncinate a segmenti acuti, le superiori intere-lineari, acuminate con nervatura centrale bianca, abbraccianti il fusto con due auricole acute; capolini a fiori gialli (a volte macchiettati di rosso), sessili o quasi in spighe allungate; acheni nerastri, fusiformi con lungo becco.
Habitat: incolti, margini strade, sentieri e macereti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: nuovi ritrovamenti: da Schignano a Migliana (2023) (Vaiano, Cantagallo), Montepiano, P. Crocetta (2021), da Sassetta a Montepiano, S. Poto (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967: zona chiamata "Le Risaie" (Prato); non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: Pian di Gello, parco di Galceti (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Lactuca sativa L. subsp. serriola (L.) Galasso, Banfi, Bartolucci & Ardenghi SCAROLA, LATTONA
H bienn/T scap – Euro-Medit-S-Siber. - VII-IX – Comune.
Erbacea a latice bianco (senza odore o quasi), fusto eretto o ascendente, alta da 30 a 120 cm; è riconoscibile rispetto alle congeneri per il lungo fusto di colore bianco osseo, per le foglie cauline glauche setolose-spinulose sul bordo e sulla nervatura centrale, e spesso disposte verticalmente; l’infiorescenza, costituita da piccoli capolini a fiori gialli, ha forma di pannocchia aperta piramidata; gli acheni (3-3,8 mm) sono grigiastri a maturità e ciliati in alto.
Habitat: soprattutto in ambienti ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 (sub L. scariola L.) e Arrigoni & al. 2005 (sub cfr. L. serriola L.): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale (sub L. serriola L.).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1943 (sub L. scariola); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub L. serriola L.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1946 (sub L. scariola L.); Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub L. serriola L.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub L. scariola); Biagioli & al. 2002 (sub L. serriola L.): margine sentieri anche su substrato serpentinoso.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub L. serriola L.) (C/S).
-Lactuca viminea (L.) J.et C.Presl. LATTUGA ALATA
H bienn – Euro-Medit.-W-Asiat. - VI-VIII – Relat. rara.
Erbacea glabra, alta 30-80 cm, a fusto eretto, di colore bianco, da cui partono rami sottili e divaricati (simili a quelli dei vimini da cui il nome); foglie basali roncinato-pennatopartite completamente divise in stretti segmenti dentati, le cauline via via lineari, intere e decorrenti sul fusto da10 a a 35 mm; capolini solitari o in fascicoli, numerosi e subsessili, a 4-5 fiori ligulati giallo-pallidi (a volte arrossati di sotto); acheni di ca. 1,5 cm, nerastri con becco breve e pappo di ca. 5 mm.
Habitat: incolti pietrosi, roccaglie.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: non su substrato ofiolitico (ex-cava di Gello) (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Lactuca virosa L. LATTUGA VELENOSA
T scap/H bienn – Medit.-Atl. - VI-IX – Rara.
Erbacea con aroma fetido, che ricorda il papavero, fusto eretto, ispido in basso e spesso di colore violaceo, alta 40-120 cm e più; foglie patenti (disposte orizzontalmente) e rigidette, intere o sinuato-incise (raramente roncinate) con margine dentellato-spinuloso e nervatura centrale pure spinulosa sul dorso, amplessicauli con orecchiette evidenti; capolini a fiori ligulati gialli, subsessili, riuniti in panicolo; acheni lunghi 4-5 mm, neri o violacei a maturità, glabri o quasi sul corpo.
Habitat: incolti, margini strade e sentieri.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Migliana verso Cavallaie (2022) (Cantagallo); strada per Vernio e S. Poto (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): rr. presso Figline.
PS: nel latice bianco della pianta sono contenuti principi ad azione ipnotico-sedativa ed un tempo veniva essiccato (lactucario) e utilizzato come succedaneo dell'oppio negli stti di eccessiva eccitabilità nervosa (soprattutto nei bambini), nell'insonnia e come sedativo della tosse. Attenzione all'utilizzo in quanto a dosaggio di poco superiori a quelli terapeutici ha azione tossica.
Il genere Lapsana
è monospecifico.
-Lapsana communis L. LASSANA
T scap - Paleotemp. - V-X – Comune.
Erbacea annuale, a fusto assai ramificato e foglioso, alta da 20 a 120 cm; le foglie sono picciolate e alterne (le inferiori lirate e a grosso lobo terminale, le altre lanceolate e dentate), i capolini piccoli e numerosi a pochi fiori ligulati gialli, riuniti in infiorescenze lasse; l'involucro presenta 2 serie di squame, quelle interne lineari e carenate, le esterne ovate; il frutto è un achenio a numerose strie longitudinali e lungo circa 3 mm.
Habitat: coltivi ed incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: presso Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Montepiano, Badia (2023) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Caruel 1860-64 (sub Lampsana communis L.): Prato (A. Targ!).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub L. c. L. subsp. communis) (S).
Il genere Leontodon
è rappresentato da una trentina di specie a distribuzione Mediterraneo-eurasiatica (12 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni dotate di foglie dentate o incise e riunite in rosetta alla base del caule; il capolino è unico o pochi a fiori tutti ligulati gialli, involucro a squame embricate disuguali e ricettacolo privo di pagliette;caratteristica la presenza, soprattutto sulle foglie, di peli particolari (da semplici a più volte forcati) che aiutano il non facile riconoscimento specifico.
-Leontodon crispus Vill. DENTE DI LEONE CRESPO
H ros – S-Europ. - IV-VI – Rarissimo e localizzato.
Erbacea a radice allungata verticalmente, fusto esile e afillo (con qualche squama), alta 5-30 cm; foglie tutte basali, ma non appressate al suolo, da lanceolate a pennatifide, picciolate, larghe al max. 1 cm e molto più brevi del caule, dotate di fitti peli 3-4-forcati; squame involucrali ispide alcune lunghe fino a 2 cm; capolini sottili, penduli prima della fioritura e a fiori gialli spesso arrossati inferiormente; acheni ruvidi e assottigliati in alto con pappo di setole bianche (il simile L. saxatilis ha gli acheni periferici con pappo ridotto ad una coroncina dentata, senza setole); si distingue poi dalle altre specie congeneri soprattutto per gli acheni pelosi all’apice e la radice fittonante.
Habitat: calcicola di praterie e prati aridi, radure ed incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Retaia (Prato), Mandrioni e Fonte al Favo (Vaiano).
-Leontodon hispidus L. DENTE DI LEONE ISPIDO
H ros – Europ.-Caucas. - VI-X – Non raro.
Erbacea alta 10-60 cm che si caratterizza per gli acheni glabri, le foglie per lo più glabre, ma a volte pelose e allora i peli si presentano semplici o bifidi su più di ¼ della lunghezza (a raggi lunghi); inoltre sul caule possono esserci da 0 a 2 squame; le foglie possono presentarsi da sinuato-dentate a profondamente divise; i capolini a fiori gialli, spesso arrossati sulla pagina inferiore, sono reclinati prima della fioritura.
Habitat: prati e incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub L. hastalis L. var. glabratus Koch): Montepiano (Somm. herb.); Porciatti 1959: presso Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Migliana alle Cavallaie (2021) (Cantagallo-Montermulo); sopra la Cascina di Spedaletto (2022) (Cantagallo); presso il passo di S. Giuseppe, sopra l’Alpe di Cavarzano (2018), sopra il Gallo (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946, ma non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009-Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone erbose marginali non su serpentino.
-Leontodon rosanoi (Ten.) DC. DENTE DI LEONE DI VILLARS
H ros -MW-Medit. - V-IX – Non raro.
Erbacea alta 7-30 cm, che si caratterizza per gli acheni glabri e le foglie (da sinuato-dentate a pennatosette a segmento terminale ca. uguale ai laterali) sempre pelose con alcuni peli semplici e molti bifidi su meno del 10% della lunghezza (ovvero a raggi brevi), inoltre per le radici sottili, lo scapo non ramificato e con un solo capolino terminale; il pappo si presenta con setole in due serie (le interne più lunghe delle esterne).
Habitat: incolti, margini strade e sentieri.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub L. villarsii); Gestri 2009 (sub L. rosani (Ten.) DC.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub L. villarsii Lois.): fra Montelupo e Verghereto (Somm. herb.); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub L. villarsii); non ritrovata da Messeri 1936; Biagioli & al. 2002 (sub L. villarsii (Willd.) Lois.): rara, in aree marginali, ma anche su terreni ofiolitici evoluti (Gretaia) (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Leontodon saxatilis Lam. DENTE DI LEONE IRTO
T scap/H scap – Medit. Mont. - VI-IX – Abbastanza raro.
Erbacea alta 10-35 cm che si caratterizza per gli acheni del rango periferico con pappo ridotto ad una coroncina dentellata (senza setole), ciò lo distingue da tutte le altre specie congeneri presenti nel Pratese escluso L. tuberosus che però ha radici evidentemente "tuberose." Le radici e i cauli sono sottili, questi ultimi spesso incurvato-ascendenti.
Habitat: prati e pascoli.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 [sub Thrincia hirta Roth., Montepiano (Car.herb.)]; nuovi ritrovamenti: Migliana verso le Cavallaie 2018 (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagrilli (Prato); Mandrioni (Vaiano).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: rarissimo presso la Serra e al Pinone (Carmignano).
-Leontodon tuberosus L. DENTE DI LEONE TUBEROSO
H ros – Medit. - X-IV – Comune.
Erbacea alta 10-50 cm, che si caratterizza per la presenza di tuberi radicali evidenti, inoltre il caule è privo di squame, le foglie hanno lamina da dentato-sinuata a roncinata, la faccia inferiore delle ligule esterne si presenta spesso di colore grigio-azzurro, le squame involucrali sono lunghe all’incirca quanto il pappo.
Habitat: prati, pascoli, incolti, margini di coltivi, giardini e ruderi.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: nuovi ritrovamenti: Monteferrato (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2023) (Prato).
NB: sembra che i tuberi di questa specie siano commestibili, ma probabilmente poco gustosi in quanto non risultano molto ricercati. Appare in espansione sul nostro territorio rispetto al passato.
Le specie del genere Leucanthemum
hanno distribuzione euro-asiatica e sono in totale poco più di 40 (16 in Italia con qualche sottospecie ed almeno un ibrido); si tratta di piante erbacee perenni, a foglie dentate, basali e cauline (alterne), capolino unico o pochi, costituito da fiori centrali tubulosi gialli e periferici ligulati bianchi, gli acheni sono privi di becco; il riconoscimento della specie si avvale soprattutto di alcuni caratteri che riguardano la forma delle foglie e quella delle brattee dell’involucro.
-Leucanthemum ircutianum DC. subsp. ircutianum MARGHERITA DI IRKUTSK
H scap – Eurosiber. - V-X – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, non lignificato alla base, alta 20-80 cm, con capolino (unico o a volte con 2-3 laterali) di 4-5 cm di diametro; ha la base delle foglie cauline mediane dentata a denti più lunghi che larghi ed almeno alcuni acuti; le brattee dell’involucro appaiono da bianche a marroncino chiaro; è pianta glabra o pelosa solo in basso; le foglie sono sottili e flaccide dopo la raccolta; acheni lunghi 1,7-2,3 mm.
Habitat: incolti, margini sentieri e strade, zone ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Migliana (2018), da Usella verso il Santo, sopra Luicciana, sopra il laghetto di Gricigliana (2021) (Cantagallo); sentiero CAI 16 vers. S.Ippolito, sopra Montepiano (2018); sentiero 58 CAI da Gorandaccio a P. Mezzana, da Montepiano alla strada per Luciana (2020), strada da Vernio verso Luicciana, strada per Gavigno, Luciana (2021), strada per l’Alpe di Cavarzano (2022) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Chrysanthemum leucanthemum); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano. (alcune segnalazioni di Gestri 2009 di L. vulgare Lam. andrebbero qui riferite!).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: dato di erbario (FI) di Bargagli (sub Chrysanthemum leucanthemum Auct. Fl. Ital. p.p., jun 1863) da Wikiplantbase#Toscana: Monteferrato di Prato.
- Rilievi a W di Vaiano: nuovi ritrovamenti: dalla Collina a Schignano (2024).
NB: questa entità è stata definita in maniera soddisfacente solo da alcuni anni; prima, in uno dei più diffusi e consultati manuali botanici italiani (Pignatti 1982), veniva indicata come L. vulgare Lam. var. vulgare: da qui la confusione nelle flore meno recenti fra le due entità. Almeno alcune, se non tutte, le indicazioni di L. vulgare Lam. di Gestri 2009 (Calvana), Gestri & Peruzzi 2013a (Montalbano) e Gestri & Peruzzi 2013b (M. Le Coste e P. alle Croci) andrebbero qui riferite!
-Leucanthemum pachyphyllum Marchi et Illuminati MARGHERITA DEL SERPENTINO
H scap – Orofita S-Europ. - IV-VII – Relat. comune sul Monteferrato.
Erbacea a fusto eretto o ascendente, per lo più semplice, alta 50-90 cm, foglie carnosette e consistenti (da cui l’epiteto specifico: pachys = spessa e phyllon = foglia) di colore verde-scuro, margine da inciso ad intero e a lamina, le basali e le cauline inferiori, obovata e lungamente attenuata, le medie e le superiori, allungata-oblunga fino a lanceolata e abbracciante; capolino (4-6 cm di diametro) per lo più unico (fiori centrali tubulosi gialli e periferici ligulati e bianchi); squame involucrali ad ampio margine (arrotondato) scarioso da bruno scuro a chiaro; acheni lunghi ca. 3 mm.
Habitat: boschi chiari, cespuglieti soprattutto su serpentino, ma anche in substrati calcarei e silicei.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Foggi & Venturi 2009: praterie della Calvana (in Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 osservata solo nel comune di Calenzano!).
- Monteferrato: Fiori 1911 e Fiori 1914 (sub Chrysanthemum leucanthemum L. var. crassifolium Fiori); Messeri 1936 (sub Chrysanthemum leucanthemum L. var. crassifolium Fiori); Arrigoni 1974 (sub Chrysanthemum leucanthemum L. var. crassifolium Fiori); Marchi & Illuminati 1975; Arrigoni & al. 1979 (sub Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. crassifolium (Fiori) Zangheri); Arrigoni & al. 1983; Gestri & Biagioli 1992; Ricceri 1993 e 1998; Biagioli & al. 1999; Biagioli & al. 2001; Biagioli & al. 2002: più comune sul vers. occ. M.Mezzano e tra la Gretaia ed ex-cava Paci (Montemurlo, Prato); Ricceri 2006; Foggi & Venturi 2009: tra Monteferrato e Monte Piccioli; Ricceri 2010.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): da Case Serilli (Vaiano) verso la Collina e sopra Cerreto verso il crinale.
NB: di questa entità il Monteferrato di Prato rappresenta il locus classicus, ovvero il luogo dove è stata descritta per la prima volta.
-Leucanthemum pallens (Perreym.) DC. MARGHERITA PALLIDA
H scap – Euro-Medit. - V-VII – Relat. rara.
Erbacea alta 30-80 cm, a fusti eretti e generalmente ramificati, che si caratterizza per le foglie numerose, le basali assenti all’antesi, le cauline inferiori oblanceolate, le medie oblunghe e le superiori lineari a margine da intero a crenulato-dentato e abbraccianti; capolini spesso numerosi (fino a 5 cm di diametro), con squame involucrali a largo margine bruno-chiaro o trasparente.
Habitat: incolti, prati soprattutto su substrato calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub Crysanthemum leucanthemum v. pallidum); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Crysanthemum leucanthemum v. pallidum); Messeri 1936 (sub Crysanthemum leucanthemum L. var. pallidum Fiori), Biagioli & al. 2002: zone marginali, ex-cava di Guarino (Montemurlo) e ex-cava di Gello (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: presso Schignano (2023) (Vaiano).
-Leucanthemum vulgare Lam. MARGHERITA DIPLOIDE
H scap – Euro-Medit. - III-VII – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto spesso semplice, alta 20-80 cm; si caratterizza per le foglie basali e cauline inferiori spatolate a lamina rotondeggiante irregolarmente lobata (lobi ottusi e interi), le medie da pennato-lobate a pennatosette con in basso, presso l’inserzione, la presenza di alcuni denti allungati; per il margine delle squame involucrali si presenta bruno-rugginoso; i capolini sono generalmente più di 1 con il terminale più grande (diametro ca. 4 cm o più); acheni di 1,5-2 mm.
Habitat: incolti, zone marginali di strade e sentieri.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005: aree prative fra gli Acquiputoli e Cave; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Fonte del Romito (2017), sopra il Gorandaccio di Vernio (2020), poco più a N de Le Soda, a N del P. della Crocetta (2023) (Vernio); a W del M. Scalette (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo (almeno alcune segnalazioni da riferire a L. ircitianum!)
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano (almeno alcune segnalazioni da riferire a L. ircitianum!).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub L.v. Lam. subsp. vulgare) (C/S) (almeno alcune segnalazioni da riferire a L. ircitianum!).
Il genere Logfia
ha distribuzione mediterranea e conta 5 specie (4 in Italia). E’ assai simile ai generi Filago e Bombycilaena, caratterizzati da: capolini circondati da evidenti pagliette simulanti squame involucrali, fiori periferici femminili posti all’ascella di una brattea, foglie lineari o comunque sottili; in Bombycilena i fiori femminili hanno lo stilo posto lateralmente e non terminale; in Logfia i capolini sono solitari o pochi (non riuniti in glomeruli), le brattee includenti profondamente i fiori, sono convesse all’esterno e presentano in basso una evidente gibbosità (assente in Filago); infine gli acheni hanno forma oblunga (e non reniforme come in Filago).
-Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. BAMBAGIA FRANCESE
T scap – Euro-Medit. - IV-VIII – Abbastanza comune.
Erbacea eretta e ramificata in alto, alta 5-20 cm: si caratterizza per le foglie sottili-subulate e più lunghe (15-25 mm) di L. minima, le superiori maggiori dei capolini; squame involucrali cotonose, in basso con gibbosità e a punta ottusa e giallastra; i capolini hanno 5 angoli acuti. Si differenzia inoltre da L. minima per le squame involucrali medie che al momento della fruttificazione si irrigidiscono avvolgendo gli acheni fino all’apice.
Habitat: praterie, garighe, vigneti e oliveti, radure assolate.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 (sub Filago gallica L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Filago gallica L.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub Filago gallica L. var. typica Fiori); Biagioli & al. 2002 (sub Filago gallica L.).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
?-Logfia minima (Sm.) Dumort. BAMBAGIA MINIMA
T scap – C-Europ.-S-Siber. - V-VIII – Probabilmente scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea eretta, ramificata dalla metà in su, alta 2,5-20 cm, a foglie sottili, subacute o subottuse (non subulate) e lunghe 4-10 mm; capolini di 2,5-3,5 mm di diametro, terminali o ascellari, con acheni non completamente avvolti dalle squame involucrali (pallide e glabre in alto) medie che rimango molli.
Habitat: campi, incolti, margini sentieri soprattutto in substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub Filago minima (Sm.) Pers.): S.Piero a Verghereto (Somm. herb.) (Carmignano); non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2013a.
Il genere Matricaria
comprende 5 o 6 specie erbacee annuali a distribuzione olartica (3 presenti in Italia); si tratta di piante aromatiche a fusti eretti e ramificati; foglie alterne, sessili e divise con segmenti terminali sottili e subcilindrici; capolini solitari e terminali alle ramificazioni, con ricettacolo privo di pagliette; quest’ultimo carattere lo distingue dall’affine genere Anthemis; si differenzia invece dal genere Tripleurospermum (vedi) per avere il ricettacolo cavo (visibile sezionando il capolino) e per l’intenso aroma che si libera strofinando la pianta (le piante di Tripleurospermum presentano un odore molto più lieve ed il ricettacolo è pieno).
-Matricaria chamomilla L. CAMOMILLA
T scap – Subcosmop. - V-VIII – Relat. comune.
Erbacea alta da 10 a 30 (-50) cm, a fusto eretto o ascendente e ramificato, dal caratteristico profumo; le foglie sono divise (2-3 pennatosette) in lacinie sottili ed il capolino (diametro di circa 1,5-2,5 cm) ha fiori centrali tubulosi gialli (a 5 denti) e periferici ligulati bianchi (lunghi ca. 6 mm), ricettacolo conico e vuoto al centro; acheni senza pappo. Facilmente riconoscibile rispetto a M. discoidea sprovvista di fiori ligulati.
Habitat: soprattutto a margine di coltivi o in aree da poco abbandonate dall’agricoltura.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Castello di Luicciana (2018) (Cantagallo); Fonte del Romito (2019) Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava di Gello (Prato), rara sulle serpentine; Arrigoni & Viegi 2011.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: nel letto del Bardena a Galcetello, incolto erboso a Tavola (2024) (Prato).
NB: è importante e conosciutissima pianta medicinale, ma forse non tutti sanno che il suo principale effetto fitoterapico è quello antiinfiammatorio, mentre è scarso o nullo quello sedativo.
PS: la specie è più diffusa nel nostro territorio di quanto detto di sopra.
-Matricaria discoidea DC. subsp. discoidea FALSA CAMOMILLA
T scap – Neofita di orig. NE-Asiat. - VI-IX – Rarissima.
Erbacea a fusto ascendente e assai ramificato, alta 5-30 cm, caratterizzata dall’assenza di fiori ligulati nel capolino (di ca. 1 cm di diametro e con soli fiori tubulosi gialli a 4 denti); le foglie hanno contorno lanceolato e si presentano 3 pennatosette a divisioni finali sottili, larghe ca. 1 mm; i peduncoli sono fogliosi e robusti.
Habitat: zone ruderali e incolti calpestati e sassosi, sopra i 500 m di altitudine.
Segnalazioni nel Pratese:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: Montepiano alla Fonte del Romito, loc. Pecorile (Vernio).
Il genere Mycelis
ha distribuzione europea (introdotto negli Stati Uniti). Simile a Hieracium se ne differenzia soprattutto per i capolini (numerosi in ampia pannocchia) poveri a soli 5 fiori ligulati gialli, gli acheni a lungo becco e il pappo con in basso circondato da brevi ciglia.
-Mycelis muralis (L.) Dumort. LATTUGA DEI BOSCHI
H scap – Europ.-Caucas. - VII-VIII – Comune.
Erbacea glabra e glauca, a fusto alto fino a oltre 1 m, eretto e ramificato; i capolini sono piccoli, solitari, lungamente peduncolati, con pochi fiori ligulati gialli; caratteristiche le foglie divise in larghi lobi e poco consistenti, con picciolo alato e dotato, all’attaccatura sul fusto, di orecchiette dentate; le squame involucrali sono in numero di 5 ed uguali fra loro.
Habitat: radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al 2005 e Bettini & al. 2009: da Cascina Vespaio a Le Barbe, riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti e conferma: presso Le Barbe (2022), Migliana (2023) (Cantagallo); da Montepiano a P. di Petto, Alpe di Cavarzano (2018) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Lactuca muralis (L.) Gaertn.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso Le Cavallaie (2020)
- Localizzazioni generiche: Foggi & Venturi 2009.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Lactuca muralis (L.) Gaertn.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone umide non sulle ofioliti.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Lactuca muralis (L.) Gaertn.) (S).
NB: le foglie basali giovanili possono essere consumate in insalata.
Il genere Omalotheca
è distribuito in Europa, N-America e nell'Asia settentrionale con una decina di specie (5 in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni prive di latice e senza stoloni; il fusto è generalmente eretto, le foglie possono essere basali e cauline (alterne e sessili o quasi), i fiori (pentameri e tetraciclici) sono tubulosi e riuniti in infiorescenze racemose o a corimbo, hanno brattee brunastre in 2-3 serie, gli acheni sono dotati di pappo.
NB: il nome del genere è di derivazione greca: omalos = liscio e theca = custodia, riferito agli acheni a superficie liscia. Precedentemente queste piante erano attribuite al genere Gnaphalium, dal quale sono state separate in quanto specie perenni con i capolini singoli riuniti in infiorescenza racemose o a corimbo.
-Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz CANAPICCHIA COMUNE
H scap – Circumbor. - VI-IX – Non comune.
Erbacea bianco-tomentosa, a fusto eretto o ascendente, generalmente semplice, alta 20-60 cm; foglie basali (a rosetta) ed inferiori lanceolate e attenuate lungamente in basso, le cauline lineari-oblunghe, acute, sessili, uninervie e decrescenti verso l’alto (2-5 x 40-60 mm); capolini di forma conica, raggruppati in alto sul fusto in racemo denso o ± allungato e foglioso; squame involucrali scariose con macchia brunastra più o meno ampia.
Habitat: nemorale per lo più su substrato siliceo e sopra i 200 m di altezza.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub Gnaphalium sylvaticum L.): Montepiano (Caruel herb.); nuovi ritrovamenti: presso Tavianella, sopra Montecuccoli e sopra le Soda (2021) (Vernio); da Migliana a Le Cavallaie (2023) (Cantagallo, Montemurlo).
Il genere Onopordum
ha distribuzione eurasiatica con una sessantina di specie, di cui 5 presenti in Italia (con alcune subsp.); si caratterizza per le ali del fusto e le foglie dotate di spine, le squame involucrali embricate e lungamente attenute in punte pungenti, antere senza appendice basale, ricettacolo senza pagliette e alveolato con bordo dentellato; acheni subtetragoni con pappo a setole saldate in basso ad anello.
-Onopordum acanthium L. ONOPORDO TOMENTOSO
H bien – E-Medit.-Turan. (Archeofita?) - VII-IX – Relat. rara.
Erbacea a fusti eretti, alati (a 2-4 ali dentate o erose) spinosi (spine di 3-5 mm e patenti), ramosi, alta 50-150 cm; foglie a contorno oblungo e margini dentati e dotati di spine, bianco-tomentose soprattutto di sotto: le basali sessili e pennatopartite, le cauline lanceolate e lungamente decorrenti nelle ali del fusto; grossi capolini (2,5-5 cm di diametro) a fiori solo tubulosi roseo-violacei, involucro ragnateloso, globoso o piriforme a squame in più serie, larghe alla base 2-3 mm, lungamente attenuate in punte pungenti; acheni nerastri con pappo di setole saldate ad anello e biancastre.
Habitat: incolti, macchie, su terreni con escrementi animali, macereti.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: Pian di Gello (Prato); nuovi ritrovamenti: Monte Piccioli vers. S su serpentino, in terreno di una certa maturità e consistenza.
NB: la specie è presente anche sulla Calvana, ma osservata solo presso la discarica di Torri (dove è ben rappresentato) nella provincia di Firenze (Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016).
-Onopordum illyricum L. subsp. illyricum ONOPORDO MAGGIORE
H bienn/H scap – Medit. - VI-VIII – Rarissimo.
Erbacea pubescente-biancastra a fusto eretto alto fino a 2 m, con 4-6 ali interrotte e dotate di spine robuste; foglie pennatopartite o pennatolobate a lobi triangolari o a cono, le cauline via via ridotte e dotate al margine di spine lunghe fino a 20 mm; capolini di 5-7 cm di diametro, a fiori tubulosi rosati, con squame involucrali in 4-5 serie e larghe alla base 5-8 mm, che si restringono in una punta pungente spesso violacea e riflessa a maturità. Si distingue dalla specie precedente per le foglie più strette, l'infiorescenza racemosa (invece che corimbosa) e le brattee involucrali più larghe (le mediane più di 3 mm a metà lunghezza).
Habitat: radure, incolti sassosi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: sotto Migliana nella via omonima in loc. Pratalecchio (Cantagallo).
Il genere Pallenis
è costituito da 6 specie a distribuzione mediterranea e W-asiatica (2 in Italia). Si caratterizza per i capolini eretti con fiori centrali tubulosi e i periferici ligulati e raggianti (ambedue di colore giallo), l’involucro a squame esterne spinose e molto più lunghe delle interne, il ricettacolo con pagliette acuminate; foglie alterne a lamina intera; acheni esterni alati con pappo a setole brevi.
-Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa ASTERISCO SPINOSO
T scap/H bienn – Euro-Medit. - V-VIII – Relat. comune.
Erbacea a pelosità patente e a fusti ascendenti e ramosi (ramificazioni laterali spesso più alte dell’assiale principale), alta 20-50 cm; foglie intere da ovate a lanceolate, le basali picciolate e le superiori abbraccianti; capolini terminali alle ramificazioni, del diametro di ca. 2 cm - a fiori tubulosi centrali giallo-scuri e ligulati periferici, raggianti giallo più chiaro – circondati da squame esterne patenti, ad apice spinoso e assai più lunghe delle ligule, le interne membranose più brevi e non pungenti; acheni periferici senza pappo e alati ai 2 lati.
Habitat: incolti erbosi o sassosi, zone marginali e ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Asteriscus spinosus); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: M. Buriano (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: Cicignano (2024).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: alveo del Bisenzio qua e là a Prato (2024).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: prati e margine sentieri.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: presso la ciclabile a Galciana (2021), alveo del f. Bisenzio in città (2024) (Prato).
Il genere Pentanema
è costituito da una ventina di specie distribuite in Europa, Africa ed Asia (11 le specie presenti in Italia, di cui una esotica). Queste entità erano considerate fino a poco tempo fa appartenti al genere Inula. Si tratta di piante arbustive o erbacee, annuali o perenni, a foglie alterne da oblunghe a lanceolate, da intere a dentellate; il ricettacolo è privo di pagliette ed i capolini sono piccoli a fiori gialli; spesso i fiori marginali sono solo femminili e di forma da raggiante, a miniradiata, a quasi tubolare, i fiori del disco invece sono ermafroditi e l’achenio che da essi deriva ha un pappo a setole molto sottili.
PS: il nome deriva dal greco: penta = cinque e nema = filamento, infatti alcune specie presentano un pappo a cinque segmenti sottili.
Foto di E. Romani di Acta Plantarum
?-Pentanema britannicum (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. ENULA LAURENZIANA
H scap – C-Europ.-W-Asiat. - VII-IX – Probabilmente non più presente nel nostro territorio.
Erbacea subglabra o poco pelosa a fusto semplice ed eretto, alta 20-70 cm; foglie poco consistenti ed ineguali, lanceolato-allungate e acute, le cauline superiori abbraccianti il fusto e le inferiori picciolate; i capolini - a fiori gialli con ligule ghiandolose e non pelose, involucro a squame lineari vellutato-setolose e simili fra loro – sono riuniti in corimbo; acheni pelosi, lunghi 1,3 mm, con pappo bianco 3 volte più lungo del corpo dell’achenio stesso.
Habitat: prati e zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Pianura: Caruel 1860-64 (sub Inula britannica L.): Pian di Lecore tra Signa e P. a Caiano; verso la strada ferrato di Prato.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub Inula britannica L.); Gestri & Lazzeri 2021 non ritrovata!
-Pentanema hirtum (L.) D. Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart.Ort. ENULA SCABRA
H scap – S-Europ.-S-Siber – V-X – Non comunissima e localizzata.
Erbacea alta fino a 40 cm, quasi sempre con un unico fusto monocefalo dotato di lunghi peli; foglie coriacee, ruvide, erette, oblunghe-lanceolate, a margine intero o finemente dentellato e ciliato, ottuse, le superiori abbraccianti il fusto; capolini terminali, grandi (4-5 cm di diametro) a fiori con lunghe ligule strette e gialle, non pelose, né ghiandolose; involucro a squame pelose, uguali fra loro, erette, lineari-lanceolate; acheni glabri.
Habitat: zone erbose e cespugliate, margini boschivi.
Distribuzione sul territorio:
Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Inula hirta); Gestri & Lazzeri 2021.
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Messeri 1936 (sub Inula hirta L. var. oblungifolia Becfk f. uniflora Spenner); Arrigoni & al. 1983 (sub Inula hirta L.); Biagioli & al. 2002 (sub Inula hirta L.): radure steppiche.
-Pentanema salicinum (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. ENULA ASPRA
H scap – Europ.-Caucas. -VI-IX – Relat. comune.
Erbacea di 30-60 cm, a fusto glabro o poco peloso, lignificato in basso, eretto o ascendente, a volte ramificato alla sommità; foglie coriacee, lucide di sopra, patenti o riflesse, a lamina da oblunga a lanceolata-ovale, sessili o abbraccianti, a margine intero o dentellato, ciliato-setoloso; capolini (diametro 25-35 mm) unici (o pochi) e terminali, riuniti in corimbo lasso; involucro con squame inferiori riflesse all’apice; fiori gialli con ligule molto più lunghe dell’involucro (fino a 14 mm); acheni glabri.
Habitat: arbusteti, boschi, praterie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Caruel 1860-64 (sub Inula salicina L.): Vernio; nuovi ritrovamenti: verso Montecuccoli (2023) (Vernio).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Inula salicina L.); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Inula salicina L.): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: da Fornacette a Fatt. Javello (comune) (2020) (Montemurlo).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Enula aspra): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Inula salicina L.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Inula salicina L.): tra il bosco ed il Podere Ciabatti (Prato).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Inula salicina L.) (C/S).
-Pentanema spiraeifolium (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. ENULA UNCINATA
H scap – S-Europ. - VI-IX – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, semplice o poco ramoso, lignificato alla base, alta 30-70 cm; foglie coriacee, sessili, eretto-patenti, a base arrotondata e assai numerose sul fusto, la lamina si presenta ovato-lanceolata e glabra, il margine dentellato-cilato; capolini - a fiori gialli, i ligulati raggianti e lunghi fino a 1 cm – numerosi e riuniti in corimbi brevi e compatti; squame involucrali ineguali, le esterne con apice mucronato, ottuso e ripiegato in fuori e le interne lineari ad apice acuto; acheni privi di peli e pappo bianco.
Habitat: zone marginali anche pietrose soprattutto su substrato calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2020) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Inula spiraefolia L.): Prato, Vaiano.
- Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub Inula squarrosa L.): m. Albano; Gestri & Peruzzi 2013a (sub Inula spiraefolia L.): Carmignano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Inula spiraefolia L.) (C).
-Pentanema squarrosum (L.) D. Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart.Ort. ENULA BACCHERINA
H bienn (H scap) – Medio-Europ.-W-Asiat. - VII-IX – Comune.
Erbacea pubescente e non ghiandolosa, alta da 50 cm a 1 m, ramosa in alto; foglie lanceolate, tomentose sulla faccia inferiore, ruvide su quella superiore, le medie e le inferiori appaiono picciolate; capolini abbastanza numerosi in corimbo, a fiori gialli solo tubulosi o con gli esterni a breve ligula (1 mm!), involucro a squame ad apice riflesso, le esterne uninervie; acheni subglabri o pelosi con pappo di 7 mm.
Habitat: incolti, arbusteti, siepi, radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005 (sub Inula conyza (Griess.) Meikle): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub Inula conyza (Griess.) Meikle); nuovi ritrovamenti: da Montepiano al Gasperone (2018), a Poggio di Petto, a Montepiano, Alpe di Cavarzano (2023); Le Soda (2020) (Vernio); da Migliana alle Cavallaie (2022) (Cantagallo-Montemurlo)
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Inula conyza); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Inula conyza (Griess.) Meikle); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Inula conyzae (Griess.) Meikle): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Inulae conyza (Griess.) Meikle): Carmignano. P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Inula conyza (Griess.) Meikle).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Inula conyza (Griess.) Meikle) (C/S).
PS: nella medicina popolare era utilizzata in infuso per regolare il ciclo mestruale.
Il genere Petasites
è costituito da una ventina di specie distribuite in Asia, Europa e N-America (4 in Italia); si tratta di piante erbacee perenni subdioiche (si presentano sotto due aspetti: piante con fiori funzionalmente maschili e piante con fiori femminili fertili); foglie basali - picciolate, a larga lamina cordata o reniforme - completamente diverse dalle cauline - squamiformi, sessili fino ad amplessicauli -; capolini numerosi su fusti robusti che generalmente compaiono prima delle foglie; involucro campanulato a squame in 1 o più serie con ricettacolo privo di pagliette; acheni glabri, cilindrici e con coste evidenti, pappo di peli bianchi.
-Petasites albus (L.) Gaert. FARFARACCIO BIANCO
G rhiz – Orofita C-Europ.-W-Asiat. - IV-V – Relat. raro e per lo più sopra una certa quota.
Erbacea perenne a rizoma biancastro e sottile, fusto semplice ed eretto, alto 20-40 cm (si allunga alla fruttificazione fino a 80 cm), che compare prima delle foglie basali; queste sono tutte radicali, picciolate, a lamina angolata, reniforme o quasi orbicolare, fortemente sinuato-dentata e bianco-tomentosa sulla faccia inferiore; le foglie cauline sono costituite da scaglie fogliacee verde-giallastre, semiabbraccianti; i capolini hanno fiori tutti tubulosi e bianchi (o leggermente giallastri) e sono riuniti quelli maschili in infiorescenza racemosa e ovata e quelli femminili in infiorescenza più allungata a pannocchia; acheni di 2-3 mm.
Habitat: corsi d’acqua, zone umide nel bosco in particolare di faggio.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: presso Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe Cavarzano, sopra Badia lungo il torrente (2018); sentiero 00 a N del P. Crocetta, sopra Montecuccoli (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: ruscello sopra Collisassi (Vaiano); rio Alesse (Cantagallo).
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1993 e 1998: AMPIL del Monteferrato; Foggi & Venturi 2009: corsi d’acqua ecc.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: a Le Barche nel torrente e alla fonte del rio A. Calda (Carmignano).
-Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. et Scherb. FARINACCIO MAGGIORE
G rhiz – Eurasiat. -III-V – Relat. comune.
Erbacea a rizoma ingrossato, scapi fiorali eretti, con squame fogliacee semiabbraccianti, lunghi 10-50 cm; le foglie radicali compaiono dopo i fiori e sono pubescenti, lungamente picciolate e molto ampie, fino a 50 cm di larghezza, di forma da reniforme a obovata a margini sinuati o grossolanamente dentati; squame involucrali ottuse; capolini maschili di 7-8 mm in denso racemo ovato, i femminili di 3-4 mm in infiorescenza che si allunga alla fruttificazione; fiori tutti tubulosi e di colore rossastro.
Habitat: margini o letto di corsi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; Foggi & Venturi 2009: a W del Tabernacolo di Gavigno (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: zona Tavianella (2017) (Vernio); presso Gricigliana, Usella verso il Santo (2022) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Farinaccio Maggiore): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Foggi & Venturi 2009: torrente Acqua Calda (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Fonte del torrente Acqua Calda (presso Madonna del Papa) (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: argine del Bagnolo (Montemurlo) e zone umide nel comune di Prato.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub P. h. (L.) P. Gaertn. subsp. hybridus): Fornaci di Figline (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: sponde del fosso che passa sotto a via D. Campana a Prato (2024).
-Petasites pyrenaicus (L.) G.López FARFARACCIO ODOROSO
G rhiz – C-Medit. - XII-IV – Relat. rara.
Erbacea a robusto rizoma, a fusti semplici ed eretti, alti 10-30 cm; foglie cauline squamiformi e verso l’alto in forma di guaine rigonfie; le basali reniformi o orbicolari (5-20 cm di larghezza) a margini finemente e regolarmente dentellati, cordate alla base; capolini a fiori odorosi di vaniglia, violetti, riuniti in breve grappolo; questa specie si caratterizza per i fiori periferici femminili dotati di brevi ligule e le foglie che compaiono contemporaneamente ai fiori.
Habitat: incolti e forre umide.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 (sub P. fragrans (Vill.) Presl.) e Gestri & Peruzzi 2016: sotto V. Rucellai, e a NW dei Bifolchi (Prato); nuovi ritrovamenti: il Quercetino (2021) (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub P. fragrans (Vill.) Presl.): Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (P. fragrans L. var. typica Fiori); Biagioli & al. 2002 (sub P. fragrans (Vill.) Presl.): zone umide e fresche.
Il genere Picris
è costituito da una quarantina di specie (4 in Italia) a distribuzione paleoartica; hanno foglie alterne, capolini - a soli fiori ligulati gialli - numerosi e raccolti in corimbo; squame involucrali in più serie disposte a spirale, acheni a becco breve o mancante con pappo caduco a due serie di peli; la caratteristica che contraddistingue queste piante sono le setole a forma di ancora visibili (con una forte lente) sul fusto, foglie e brattee.
-Picris hieracidoides L. ASPRAGGINE COMUNE
H scap/H bienn – Eurosib. - VI-X – Abbastanza comune.
Erbacea ispida (setole ancoriformi a 2 punte), alta da 30 a 100 cm, a fusto eretto e ramoso; ha le foglie inferiori oblunghe, intere o divise, e le superiori lanceolato-lineari, intere; i capolini sono brevemente peduncolati, con fiori gialli ligulati e involucro con squame verdi, le esterne caratteristicamente lanceolate, patenti e/o riflesse; acheni di 3-5 mm con strozzatura in alto.
Habitat: incolti, ambienti ruderali e margini di sentieri e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra il P. della Crocetta (2017), da Sassetta a Montepiano (2020) (Vernio), da Migliana a le Cavallaie (2022) (Cantagallo, Montemurlo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (P. h. var. spinulosa); Messeri [sub P. h. L. var. spinulosa (Bert.)]: individui sempre stenofillici, più o meno glabrescenti); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: margine di viottoli e in pineta rada, anche su serpentino.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: via Brugnani loc. Bocca Vittoria (2023) (Prato).
NB: sul Monteferrato sembra essere presente la subsp. spinulosa (Bert.ex Guss) Arcang., caratterizzata da stenofillia, fusti di altezza contenuta e aspetto fortemente ispido, entità non accettata da tutti gli AA, molti la fanno rientrare nella sottospecie nominale.
Il genere Pilosella
ha distribuzione europea, asiatica e N-africana; il numero di specie che gli sono attribuite variano molto a seconda degli Autori, da una ventina a una settantina (con in più molti ibridi). E’ simile, e “complicato”, quasi quanto il genere Hieracium (vedi) dal quale è stato recentemente scorporato. Si differenzia da quest’ultimo soprattutto per l’aspetto degli acheni ad apice crenulato (in Hieracium è intero e borato da un cordoncino anulare), il pappo con setole disposte su un solo rango, sottili e simili fra loro (in Hieracium le setole sono poste su due ranghi: le interne più lunghe e più rigide delle esterne), per la possibile presenza di stoloni e di sottilissima dentellature del margine fogliare (ambedue sempre assenti in Hieracium). Per una sicura determinazione delle varie entità è indispensabile la supervisione di uno specialista del campo.
-Pilosella acutifolia (Vill.) Arv.-Touv. PELOSELLA A FOGLIE ACUTE
H ros – Alpico-Appennina – IV-VII – Rarissima, ma forse più rappresentata di quanto appare per la difficoltà di individuazione.
Erbacea rosulata a fusti con lunghi peli semplici e stellati (questi ultimi assenti in basso), alti 10-30 cm, quasi sempre privi di foglie e poco ramificati, con 1 o più capolini (fino 7); foglie basali lineari-spatolate, intere, prive di peli ghiandolari, con setole scure allungate e numerosi peli stellati (soprattutto al margine e faccia inferiore); presenza di stoloni epigei sottili; squame involucrali con peli chiari e setole scure.
Habitat: incolti e scarpate sassose.
Distribuzione sul Territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub Hieracium x brachiatum).
NB: probabilmente questa entità è presente anche sull’Appennino pratese principale in quanto è stato ritrovato da chi scrive sulla Panoramica sopra C. Spedaletto, in territorio provinciale pistoiese, ma abbastanza prossimo al confine con la nostra provincia.
-Pilosella cana (Peter) Gottschl. PELOSELLA DI KALKSBURG
H scap – Alpico-Appennina – IV-VII – Rarissima.
Erbacea a fusti alti da 10 a 30 cm, simile a P. acutifolia (per la mancanza di peli ghiandolari sulle foglie basali e di peli stellati sulla pagina superiore e densi invece sull’inferiore) e a P. officinarum, da quest’ultima si differenzia per avere più di 1 capolino (sebbene sempre in numero limitato) e per il peduncolo allungato.
Habitat: radure di boschi in montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso l’Alpe di Cavarzano (Vernio) la pianta fotografata sui monti di Prato appare alla voce P. cana sul forum di Acta Plantarum.
-Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West PELOSELLA LATTUGHELLA
H ros – Eurosiber. - VI-VII – Rarissima.
Erbacea di 10-25 cm, a fusto con setole, peli stellati e ghiandole, eretto con una sola foglia nella metà inferiore e alcune squamette in quella superiore, brevemente ramificato in alto; foglie basali (lunghe fino a 4,5 cm, con setole e peli stelati) a lamina da lineare a spatolata, margine intero o appena dentellato con lunghi peli bianchi; presenza di stoloni dotati di foglie lunghe la metà delle basali; capolini piccoli con fiori ligulati gialli e involucro con peli stellati e ghiandole.
Habitat: pascoli e radure soprattutto su terreni acidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (Hieracium lactucella Wallr.): Limentra orientale.
-Pilosella officinarum Vaill. PELOSELLA PELOSETTA
H ros – Europ.-Caucas. - V-X – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, privo di foglie e generalmente monocefalo; presenza di stoloni epigei spesso ascendenti, fogliosi (foglie lunghe meno della metà delle basali) e lunghi fino a 20 cm e più; foglie basali intere, a lamina ovato-spatolata, con lunghi peli stellati sulla pagina inferiore che appare bianca, mentre la superiore verde-scura; capolini unici (15-25 mm di diametro) a fiori gialli (a volte arrossati) e squame involucrali lineari, pelose e con ghiandole nerastre.
Habitat: pendii, prati, radure sassose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002 (sub Hieracium pilosella L.): da M. Bucciana a Lavacchio (Cantagallo); Arrigoni & al. 2005 (sub Hieracium pilosella L.): riserva naturale di Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub Hieracium pilosella L.): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2014), da Fabbro a Migliana (2018), Terrabianca (2015), Malpasso (Gricigliana) (2022) (Cantagallo); CAI 16 vers. S. Ippolito (2019) (Vernio); dall'Alpe verso il Tab. Gavigno (2024) (Vernio-Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Hieracium pilosella); Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Hieracium pilosella L.); Gestri 2009 (sub Hieracium pilosella L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Hieracium pilosella); Messeri 1936 (sub Hieracium pilosella L. var. vulgare Tausch. e H.P. L. var. pacilodes (N.et P.); Biagioli & al. 2002 (sub Hieracium pilosella L.): soprattutto su rocce serpentinose.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Pilosella piloselloides (Vill.) Soják PELOSELLA FIORENTINA
Erbacea a fusto abbastanza sottile, più o meno glabro, lungo 20-80 cm e ramificato in alto; infiorescenza lassa a 8-20 capolini (squame involucrali con radi peli stellati e ghiandole) su peduncoli gracili, piccoli (5-10 mm di diametro) e a fiori ligulati di colore giallo-pallido; foglie basali numerose, lineari-lanceolate e glauche, le cauline in numero ridotto e a lamina strettamente lineare.
- - P. p. (Vill.) Soják subsp. piloselloides
H scap. - Europ. - V-VIII – Relat. comune.
Si caratterizza per le foglie basali interne sottili e a margini paralleli e l’infiorescenza a panicolo lasso con rametti e peduncoli privi di peli stellati ed inoltre assenza di stoloni.
Habitat:
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Codilupo (2022), il Santo, Terrabianca (2015) (Cantagallo); da Cavarzano all’Alpe, Passo di S. Giuseppe (2014) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Hieracium piloselloides); Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub Hieracium florentinum); Gestri 2009 (sub Hieracium piloselloides Vill.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: da MontemuColline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: Cicignano (2024).rlo verso Cicignano (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Sparviere fiorentino): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Hieracium florentinum); Messeri 1936 (sub Hieracium florentinum All. grex florentinum (All.) Zhan. subsp cylindriceps NP. f. normale Zhan.; Hieracium florentinum All. var. vulgare Tausch.); Arrigoni & al. 1983 (sub Hieracium piloselloides Vill.); Biagioli & al. 2002 (sub Hieracium piloselloides Vill.): soprattutto su rocce e ghiaie serpentinose.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- - P. p. (Vill.) Soják subsp. subsp. praealta (Gochnat) S. Bräut. & Greuter
H scap. - Europ.-Caucas. - IV-VIII – Rara (forse almeno alcune delle segnalazioni di sopra sono da attribuire a questa sottospecie).
Si caratterizza per la maggior robustezza, le foglie basali interne ed oblaceolate (margini leggermente convessi), la pelosità giallastra, i peduncoli con fitti peli stellati e con peli ghiandolari, involucro verde-chiaro con peli ghiandolari nerastri, l’infiorescenza a corimbo e stoloni assenti.
Habitat: pendii, scarpate, radure sassose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: CAI 16 vers. S. Ippolito (2019), Gasperone (2020) (Vernio).
NB: questa subspecie è probabilmente stata sottostimata in passato ed alcune delle segnalazioni per la nostra provincia della subsp. nominale sono da attribuire a questa entità.
??-Pilosella longisquama (Peter) Holub PELOSELLA A SQUAME LUNGHE
Segnalata da Messeri 1936 [sub Hieracium pilosella L. var. pachilodes (N. et P.)] al Monteferrato e non più segnalata.
??-Pilosella officinarum X piloselloides
Questo ibrido è stato segnalato da Fiori 1914 (sub Hieracium x brachyatum) per la Calvana e non è più stato ritrovato.
Il genere Prenanthes
è costituito da poco meno di 10 specie (per lo più montane) distribuite in Europa, Asia e Africa (1 sola autoctona in Italia); si caratterizza per i capolini con pochi fiori ligulati (4-7) e pendenti prima dell’antesi, per l’involucro con poche squame diverse fra loro, il ricettacolo privo di pagliette e gi acheni senza rostro e a pappo bianco.
-Prenanthes purpurea L. LATTUGA MONTANA
H scap – Europ.-Caucas. - VI-VIII – Comune oltre una certa altitudine su substrato siliceo, assente altrove.
Erbacea glabra, a fusto eretto, foglioso e ramificato, alta 70-120 cm; foglie cedevoli, abbraccianti il caule con 2 auricole ottuse, le inferiori spatolate con 2-3 coppie di lobi laterali e uno superiore maggiore e acuto, le altre lanceolate ± intere; capolini a 3-5 fiori ligulati violacei-porporini, involucro cilindrico, pendenti prima della fioritura e lungamente peduncolati, riuniti numerosi in pannocchia a piramide; acheni compressi, biancastri un poco inferiori al pappo.
Habitat: boschi di montagna su substrato siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002: in faggeta presso Lavacchio e Poggio la Scavata verso Fregionaia (Cantagallo); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale di Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano, presso Montepiano e il Passo di S. Giuseppe (2021) (Vernio).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: boschi presso la fattoria di Javello (2023).
- Localizzazioni generiche: Arrigoni & Viciani 2001: castagneti.
Il genere Pulicaria
comprende circa 85 specie (4 presenti in Italia) a distribuzione europea, asiatica e africana; le sue piante sono morfologicamente molto vicine ai generi Inula e Pentanema; si caratterizzano per gli acheni con il pappo a setole in 2 serie (le esterne più corte) e con alla base del pappo stesso una frangia dentata o una lacinia. Le foglie cauline medie sono troncate o auricolate, il ricettacolo è privo di pagliette.
NB: il nome deriva dal latino pulex, col significato di “erba delle pulci”, in quanto in antico, una o più specie, erano ritenute in grado di tenere lontano questi insetti fastidiosi.
-Pulicaria dyssenterica (L.) Bernh. INCENSARIA DISSENTERICA
H scap – Euro-Medit. - VII-X – Abbastanza comune.
Erbacea leggermente aromatica, alta da 20 a 70 cm, ramificata in alto, con foglie pubescenti, ondulate, leggermente dentate al margine, le cauline lanceolate e abbraccianti il fusto con orecchiette evidenti (le superiori astate), le basali poco più grandi e secche all’antesi; i grossi capolini (ca 1,5-2,5 cm di diametro), con involucro a sottili squame lanose, sono riuniti in corimbo, hanno fiori tutti gialli, tubulosi al centro e ligulati (piuttosto sottili e numerosi, lunghi 6-4 mm) in periferia; acheni vellutati di 1,5 mm.
Habitat: incolti erbosi e fresco-umidi, zone marginali a corsi o specchi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Sassetta, Montepiano (2018), a N di Montecuccoli (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone marginali (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Brugnani loc Bocca Vittoria (2023) (Prato).
NB: ha un’antica tradizione popolare di erba della medicinale: il nome generico (pulicaria da pulex=pulce) si riferisce alle sue supposte proprietà insetticide e quello generico (disynterica) a quelle antidiarroiche.
-Pulicaria odora (L.) Rchb. INCENSARIA ODOROSA
H scap – Euro-Medit. - VI-VII – Poco comune.
Erbacea alta 30-80 cm, simile alla precedente; si differenzia soprattutto per l’assenza di stoloni, per il fusto non o poco ramificato, le foglie semiabbraccianti con orecchiette poco evidenti, le basali ancora presenti all’antesi e molto più grandi delle cauline, i capolini meno numerosi 1-5(10), i fiori ligulati lunghi oltre 6 mm e per un profumo sui generis.
Habitat: sottobosco chiaro, radure boschive e arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: verso Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: prato ingresso da via T. il Crocifisso (Prato)
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub P.o. Rchb. var typica Fiori); Biagioli & al. 2002: strada bianca alla Gretaia (Montemurlo).
-Pulicaria vulgaris Gaertn. INCENSARIA FETIDA
T scap – Paleotemp. - VIII-IX – Rarissima.
Erbacea di odore fetido, dotata di peli crespi, con fusto eretto o ascendente a ramificazioni da erette a patenti, alta 10-50 cm; foglie poco consistenti, a lamina lanceolata o obovata e margine ondulato, le cauline da sessili a semiabbraccianti; capolini subglobosi e piccoli (7-9 mm di diametro) a fiori gialli con le ligule più brevi dell’involucro, che è coperto da squame lineari densamente tomentose per peli semplici e ghiandolari; i capolini sono riuniti in lassi grappoli corimbiformi.
Habitat: aree incolte e umide.
Distribuzione sul Territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Pianura: Caruel 1860-64: fra Signa e P. a Caiano...(Amid!)
Il genere Reichardia
è costituito da una decina di specie (3 in Italia) distribuite in area mediterranea e tropicale (alcune anche in Australia). Le sue entità hanno aspetto simile a quelle di Hieracium, ma si caratterizzano per l’aspetto degli acheni (gli esterni scuri e gli interni chiari) molto rugosi in senso trasversale e con pappo costituito da peli saldati fortemente in basso fra loro (spesso si distaccano insieme). Le squame involucrali esterne hanno la base nettamente cordiforme.
-Reichardia picroides (L.) Roth. LATTUGHINO, GRATTALINGUA COMUNE
H scap – Medit. - I-XII – Molto comune.
Erbacea a latice bianco e dolciastro, con radice legnosa, tutta glabra, liscia e glauca, alta 25-50 cm, a fusti semplici o biforcuti; foglie del fusto amplessicauli-auricolate, a lamina lanceolata e margine dentato-lobato, le inferiori pennatifide o pennatopartite; capolino con involucro piriforme a squame embricate; capolini a fiori ligulati gialli con peduncoli allungati, monocefali e con diverse foglioline squamiformi acute e scariose al margine.
Habitat: incolti sassosi, zone marginali.
Distribuzione sul Territorio:
- Appennino pratese principale: Gestri 2018: nel comune di Cantagallo e di Vernio; nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2020) (Cantagallo), ma anche altrove.
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub R. p. Roth. var. vulgaris Fiori f. pennatifida Fiori (individui sempre più o meno glaucescenti a foglie succulente) e R. p. Roth. var. maritima Fiori); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: su tutti i suoli serpentinosi… spesso esemplari arrossati (eritrismo) (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: PG13b (C/S).
Il genere Rhagadiolus
è costituito da due sole specie mediterranee, ambedue presenti in Italia. Le due entità sono caratterizzate da squame in 2 serie, ricettacolo nudo, fiori (8-12) solo ligulati gialli con il peduncolo, in particolare nel capolino terminale, molto inferiore all’involucro, il quale si apre a stella al momento della fruttificazione; inoltre gli acheni, privi di pappo, si accrescono e poi si incurvano
(soprattutto gli esterni) a maturità.
NB: le due specie fino a pochi anni fa sono state spesso confuse fra loro, ovvero venivano ambedue indicate sotto l’unica denominazione di R. stellatus almeno in Toscana. Da recenti osservazioni (in realtà ancora abbastanza incomplete e frammentarie) sembra che sia molto più comune, almeno da noi, R. edulis; quindi molte delle segnalazioni riportate sotto R. stellatus andrebbero ricondotte a R. edulis: per chiarire esattamente il problema andrebbe condotta un’accurata ricerca ad hoc.
-Rhagadiolus edulis Gaertn. RADICCHIO EDULE
T scap – Euro-Medit. - III-VI – Da valutare perché spesso confuso con il successivo.
Erbacea alta fino a 40 cm, a rametti divergenti e poco fogliosi, pelosa in basso e glabra in alto, con soli fiori ligulati gialli; i capolini a maturità si presentano con 5-7 squame involucrali aperte a stella e glabre nella parte superiore, con al centro gli acheni, quelli interni rugosi, dritti o poco ricurvi. Le foglie basali appaiono profondamente divise, quelle più interne mostrano 5-11 segmenti con l’apicale di forma poligonale.
Habitat: radure, campi, margini di sentieri e strade in area mediterranea.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri 2023: Vernio, a N di Montecuccoli in loc. Porciglia, Gricigliana (Cantagallo), assai diffusa e comune, ca. 370 m s.l.m..
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021 (sub R. stellatus (L.) Gaertn.); Gestri 2023b: sito del Comune di P. a Caiano: Conosci la città: Piante vascolari.
- Calvana: nuovi ritrovamenti: sopra R. Alesse verso Montecuccoli (2024) (Cantagallo).
-Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. RADICCHIO STELLATO
T scap – Euro-Medit. - III-VI – Da valutare perché spesso confuso con il precedente.
Erbacea molto simile all’entità di cui sopra, da cui si differenzia per gli acheni setolosi e lisci, con i centrali assai incurvati ed in numero di 7-8, circondati da squame involucrali ciliate all'apice; le foglie basali interne per lo più sono divise in 9-17 segmenti con quello apicale tondeggiante.
Habitat: incolti, campi, radure e margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: oss. Gestri 2017 Wikiplantbase#Toscana: Celle (Vernio); nuovi ritrovamenti: sopra Cantagallo, sopra Montecuccoli (2016), Castello di Luicciana (2017), da Fabbro a Migliana, sopra il paese di Migliana (2020) (Cantagallo); strada per la Rocca di Vernio (2021), sopra Luciana (2017) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano
NB: da alcune immagini della mia fototeca sembra che siano presenti ambedue le specie sul Montalbano: sull’Elsana (Carmignano) per esempio si incontra R. stellatus con brattee pelose all’apice (come da foto annessa).
Il genere Scolymus
è rappresentato da 3 specie (e 2 subspecie) a distribuzione mediterranea, tutte presenti in Italia. Caratterizzano queste entità laticifera, a soli fiori ligulati gialli e ricettacolo con pagliette, la presenza di spine sia sulle foglie che lungo le ali del fusto.
-Scolymus hispanicus L. CARDOGNA COMUNE
H bienn – Euro-Medit. - VI-VIII – Relat. comune.
Erbacea alta 20-80 cm a fusto eretto e ramoso, con ali spinose senza margine cartilagineo, discontinue soprattutto nella metà superiore (caratteri importanti per le distinzione con le altre due specie); foglie (lunghe fino a 12 cm) pennatopartite o pennatosette, sprovviste di margine cartilagineo e a contorno sinuato, assai spinose ed a nervature bianche, le superiori amplessicauli; capolini a fiori giallo dorati (2-3 cm diametro), terminali e ascellari alle foglie, riuniti in grappoli ramosi e circondati da 3 brattee spinose; squame involucrali sottili e assai acuminate; acheni terminati da una coroncina e con 2 setole presto caduche.
Habitat: praterie, incolti aridi e sassosi, margini di camminamenti.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: solo su terra di riporto all’ex-cava di Gello (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: sponde del Bisenzio, Pista ciclabile a Prato e in viale Galilei (2023) (Prato).
Il genere Scorzonera
comprende poco meno di 200 specie (5 in Italia) a distribuzione paleotemperata. Si presentano come piante erbacee perenni a foglie alterne, intere e lineari; capolini unici o pochi a fiori ligulati, ricettacolo senza pagliette, squame involucrali in molte serie (il simile genere Tragopogon in 1-2 sole serie!); acheni costati, rugosi, ristretti in alto e con pappo di setole saldate ad anello.
?-Scorzonera humilis L. SCORZONERA MINORE, CASTRACANE
H scap – Europ.-Caucas. - VI-VII – Rarissima o assente.
Erbacea a radice robusta sprovvista di fibre brunastre sul colletto, fusto eretto, semplice, per lo più monocefalo e fistoloso, alta 10-40 cm; foglie intere e glabre, a lamina lineare con le radicali attenuate alla base in un picciolo scanalato e le (poche) cauline sessili; grosso capolino (4-5 cm di diametro) a fiori ligulati gialli superanti l’involucro che presenta squame esterne molto inferiori alle interne; acheni lunghi poco meno di 1 cm, lisci o quasi, con pappo di 10-12 mm bianco sporco.
Habitat: prati e boschi umidi, paludi.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 1999 (sub Castracane); Biagioli & al. 2002: su gabbro alla Gretaia (Montemurlo).
NB: ne andrebbe riverificata la presenza, in quanto non è più stata segnalata in zona ormai da anni!
-Scorzonera laciniata L. SCORZONERA SBRINDELLATA
H bienn – Plaeotemp. - V-VII – Rara.
Erbacea a radice a fittone, a fusto glabro, striato in alto, eretto, per lo più ramificato, alta 10-50 cm; foglie profondamente divise in lacinie ± sottili (pennatopartite o pennatosette); capolini solitari a ligule giallo-pallide (a volte purpuree di sotto) lunghe come o poco di più delle squame involucrali, l’involucro cilindrico si allunga fino a 4 cm nel frutto; acheni fino a 17 mm e senza becco, con pappo di lunghezza analoga e pappo sporco.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Podospermum laciniatum (L.) DC. subsp. laciniatum): Foce ai Cerri e Cave di Savignano (Vaiano).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Podospermum laciniatum (L.) DC. subsp. laciniatum) (C): prati nei pressi di Cerreto (Prato).
Il genere Scorzoneroides
è costituito da una quindicina di specie (5 ed alcune subsp. in Italia) a distribuzione paleotemperata; le sue piante sono molto simili a quelle del genere Leontodon (vedi) del quale per alcuni Autori fanno o facevano parte. Vengono distinte per l’assenza di peli o per la presenza sulle piante di soli peli semplici.
-Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench DENTE DI LEONE RAMOSO
H ros – Paleotemp. - VI-XI – Abbastanza raro.
Erbacea a radice breve e a più fusti eretti, alti 20-50 cm, ramosi, con, generalmente, più di 3 scaglie fogliacee e terminanti in 2 o pochi capolini (raramente 1); foglie radicali glabre, appressate al suolo, pennatifide e/o pennatopartite, le superiori intere; capolini eretti prima della fioritura, a fiori ligulati giallo-chiari, i periferici di sotto più scuri o arrossati, con stigmi giallo-verdastri (nerastri nelle piante essiccate), peduncolo e involucro glabri o a peli semplici inferiori a 2 mm; acheni rugosi con pappo bianco-rosato a setole piumose.
Habitat: prati, pascoli, luoghi erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe Cavarzano (2017: erbario PARSEC- Prato) (Cavarzano); a le Soda (2017: erbario PARSEC- Prato), da Montepiano a P. di Petto (2020) (Vernio).
-Scorzoneroides cichoriacea (Ten.) Greuter DENTE DI LEONE MERIDIONALE
H ros – Medit.-Mont. - V-VIII – Raro.
Erbacea alta 15-40 cm con radici dotate di tuberosità fusiformi; fusti da 1 a molti, ± ingrossati in alto e con squame ± sottili nella metà superiore; foglie picciolate, larghe 5-20 mm e lunghe fino a 70, da dentate a roncinate-pennatifide, glabrescenti o pelose per peli semplici; capolini solitari a fiori ligulati e stimmi gialli, con involucro di 12-15 mm a brattee sottili, ottuse in alto e molto pelose; acheni di 7-10 mm, rugosi trasversalmente, con becco che uguaglia o supera in lunghezza il corpo e pappo di peli piumosi in un solo rango.
Habitat: prati e zone erbose di montagna.
Distribuzione sul territorio:
Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: vers. NE del M. Maggiore (Vaiano).
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: sopra il lago Montalbano (Carmignano).
Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguinetti): presso la cava Paci sulle serpentine (Montemurlo), a margine dei coltivi nei poderi Ciabatti e Baylon (Prato).
Il genere Senecio
conta circa un migliaio di specie (erbacee, arbustive o rampicanti) a diffusione cosmopolita. Il nome deriva dal latino senex = vecchio riferito al pappo bianco degli acheni che ricorda i capelli di un vecchio. Le sue piante si caratterizzano all’interno della Famiglia per essere prive di latice, le foglie con nervatura pennata e lamina da pennatifida a 3 pennatosetta (le cauline alterne), capolini con fiori gialli, tubulosi al centro e ligulati in periferia (a volte molto ridotti), ricettacolo privo di pagliette, brattee involucrali in 2 ranghi (o raramente un solo rango di brattee uguali e poste allo stesso livello), con le esterne più brevi (meno del 40%, più del 40% in Jacobaea) e sottili.
-Senecio inaequidens DC. SENECIO SUDAFRICANO
T scap (Ch suffr) – Neofita invasiva di orig. S-Afric. - VIII-XI – Relat. rara, ma in espansione.
Erbacea a fusto eretto ramificato dal basso, alta 30-70 cm; foglie lineari (2-4 x 70-80 mm), sessili e alterne, a margine intero o finemente dentellato; fiori gialli, riuniti in numerosi capolini - del diametro di 1,5-2,5 cm, con 21 squame involucrali interne con apice bruno e 10-12 esterne più brevi e rossastre – a formare corimbi irregolari; acheni cilindrici di 3 mm dotati di pappo.
Habitat: zone marginali di strade, ferrovie ecc.
Distribuzione sul territorio:
- Appenino pratese principale: nuovi ritrovamenti: da Montecuccoli alla Dogana (2018) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zona argillosa presso il sentiero dei Patriarchi (Montemurlo); Arrigoni & Viegi 2011; adesso non più presente in loco, ma nuovi ritrovamenti: cima del M. Mezzano (2020).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): rarissimo.
- Pianura: oss. Gestri 2017 Wikiplantbase#Toscana: presso La Querce a margine stradale; nuovi ritrovamenti: presso la ferrovia a S del Ponte Datini (2019), alveo del Bisenzio presso il ponte della Passerella (2024) (Prato).
-Senecio lividus L. SENECIONE LIVIDO (361)
T scap – Medit. - IV-VI – Poco comune.
Erbacea aromatica, a fusto normalmente unico e semplice, ghiandoloso in basso, alta 30-80 cm; foglie di 4-8 cm, un poco lobate o pennatifide, a lobi simili e a denti un poco aristati, le superiori abbraccianti o sessili, le inferiori picciolate; i capolini - larghi da 6 a 10 mm, a involucro cilindrico con 21 squame esterne sottili, lunghe 1 cm ca., e 3-5 interne molto più brevi, a fiori ligulati lunghi ca. 5 mm e ripiegati all’esterno - sono riuniti abbastanza numerosi in un lasso corimbo; acheni puberuli, lunghi 3 mm ca. e con pappo bianchissimo.
Habitat: radure, margini di coltivi e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Montecuccoli alla Dogana (2018) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Poggio Secco (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: nuovi ritrovamenti: cima di M. Mezzano (2016) (Prato).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): raro.
?-Senecio nemorensis L. s. l. SENECIONE SILVANO
H scap – C-Europ.-Cauacas. - VII-VIII – Rarissimo o assente.
Pianta a fusto erbaceo ed eretto, alto 60-120 cm; foglie ovate, ca. 3 volte più lunghe che larghe (larghezza max. al terzo inferiore) e con denti di 1-2 mm e distanziati fra loro; capolini (diametro ca. 3 cm) a 4-8 fiori ligulati e gialli e con squame involucrali esterne ed interne quasi della stessa lunghezza.
Habitat: zone erbose fresco-umide ad una certa quota (almeno collinare).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002: riserva naturale Acquerino-Cantagallo, ma non riportato nei lavori successivi di questi Autori, né ritrovato da altri!
NB: molto probabilmente trattarsi dell’entità successiva molto simile macroscopicamente.
-Senecio ovatus (P.Gaertn.,B.Mey. et Scherb.) Willd. subsp. alpestris (Gaudin) Herborg SENECIONE ALPESTRE
H scap – Orofita Europea – VI-VIII – Relat. raro.
Erbacea a fusto eretto, alta 50-150 cm; si caratterizza per le foglie alterne, sessili, ovate con margine completamente e regolarmente dentato, le superiori poco diverse dalle medie e inferiori; squame involucrali interne molto maggiori delle esterne (queste in numero di 5-6), con fiori gialli riuniti in capolini (2-4 cm di diametro) numerosi formanti infiorescenze a corimbo. La subsp. alpestris si distingue per essere pianta stolonifera con le foglie 5-7 volte più lunghe che larghe, i fiori ligulati da 1 a 3 e i tubulosi da11 a 17 riuniti in capolini a peduncolo sottile; il fusto è pubescente almeno all’inserzione delle foglie.
Habitat: soprattutto nelle schiarite dei boschi di faggio o altre caducifoglie ad una certa altitudine.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub S. fuchsii Gmelin): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: bosco sopra il Lago Galletti (2020), sopra il Gorandaccio (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub S. ovatus (P.Gaertn.,B.Mey. et Scherb.) Willd. s.l.) e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: Gestri 2002 (sub S. fuchsii Gmelin): sentiero sopra la Fattoria di Javello e altrove.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub S. ovatus (P.Gaertn.,B.Mey. et Scherb.) Willd. s.l.): osservato al sentiero dei Patriarchi, a quota notevolmente inferiore rispetto a quella usuale.
-Senecio rupestris Waldst. & Kit. SENECIONE MONTANINO
H bienn/H scap – Orof. SE-Europ. - V-VIII – Raro.
Erbacea a fusto eretto, non o poco peloso, alta 20-60 cm; foglie pennatopartite con 3-4 paia di segmenti, allungati e dentati, a contorno ovato o oblungo, non allargate in alto (max larghezza sotto la metà), a lungo arenose almeno sulla venatura centrale; capolini (1,5-2 cm di diametro) a fiori gialli, i ligulati lunghi 1-1,4 cm, con squame involucrali generalmente ad apice scuro (21 interne di 6 mm ca. e una decina esterne lunghe un terzo ca. delle prime), sono riuniti in corimbo irregolare; acheni lungo ca. 2 mm.
Habitat: radure, margini sentieri e strade, massicciate di montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1879-1908 (sub S. laciniatus Bert.): Montepiano; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: verso Tavianella (2020) (Vernio).
-Senecio sylvaticus L. SENECIONE DELLE SELVE
T scap – Europ. - VII-IX – Raro.
Erbacea a fusto ispido ed eretto, alta da 20 a 80 cm; è simile a S. lividus (vedi) dal quale si distingue per avere per lo più 13 squame involucrali interne lunghe ca. 7 mm (e non costantemente 21) (le esterne 2-3 e lunghe 1-2 mm), capolini eretti anche da giovani (non pendenti) e riuniti in una ricca e densa infiorescenza a corimbo (lassa e meno ricca in lividus); può essere confuso anche con S. vulgaris quando - a volte - presenta brevi fiori ligulati: se ne distingue per le squame involucrali dotate di ghiandole e verdi (o a volte scure solo all’apice) nel nostro; in più S. sylvaticus si incontra solo in ambiente nemorale, da noi soprattutto in faggeta.
Habitat: boschi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al. 2024: Monte della Scoperta versante W, radura di faggeta lungo il crinale (Cantagallo); osservata anche sul sentiero che sale
al crinale della Scoperta dall’Alpe e sotto Le Soda (Vernio).
-Senecio vulgaris L. VERZELLINA, SENECIO COMUNE (366)
T scap – Cosmop – I-XII – Molto comune: una delle specie più diffuse e frequenti nel nostro territorio.
Erbacea alta 10-50 cm, a fusto eretto o ascendente e ramificato; foglie basali spatolate e ± divise e le cauline pennatopartite e semiabbraccianti; lo caratterizzano i piccoli capolini - ca. 6 mm di diametro e pendenti prima dell’antesi, a fiori gialli tutti tubulosi (con rare eccezioni) appena sporgenti, con 10-12 squame involucrali ad apice macchiato di nero, le esterne triangolari e molto brevi, le interne strette e 4-5 volte più lunghe – si riuniscono a formare infiorescenze a corimbo irregolare; acheni lunghi 1-2 mm, con pappo bianco.
Habitat: coltivi, incolti, ambienti ruderali ecc.
Distribuzione sul territorio:
Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; ma presente su tutto l'Apennino!
Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano,Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Calderina): AMPIL del Monteferrato.
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Biagioli & al. 2002: in tutti gli ambienti escluso le nude rocce e pietraie.
Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2021) (Prato), circondario di Montemurlo, Vaiano, Vernio ecc.
E’ presente un po’ ovunque, anche in città sui marciapiedi e incolti…
Il genere Serratula
conta 2-4 specie erbacee (per alcuni Autori molte di più) distribuite in Europa e Asia (1 con 2-3 sottospecie in Italia). E’ simile al genere Centaurea (vedi), ma se ne distingue soprattutto per le squame involucrali delle sue piante che non presentano appendici; le foglie sono 1 pennatosette a segmenti lanceolati, i capolini sono posti all’apice delle ramificazioni in numero di 1-5, gli acheni hanno un pappo di setole.
-Serratula tinctoria L. SERRATOLA DEI TINTORI, CERRETTA COMUNE
H scap – Eurosiber. - VIII-XI – Relat. comune.
Erbacea alta da 30 a 90 cm, a fusto e ramificazioni erette, con foglie (assai variabili) glabre, a contorno lanceolato, profondamente divise in segmenti finemente dentati: quelle inferiori lungamente picciolate e le superiori sessili; i capolini (con involucro cilindrico-oblungo e spesso porporino) sono riuniti all’apice dei rami a 2-5 ed hanno fiori rosato-violacei solo tubulosi.
Habitat: in pianura è specie quasi esclusivamente di bosco (radure e schiarite).
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. t. L. subsp. tinctoria): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la Fattoria di Javello (2015).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Cerretta comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub S. t. L. subsp. tinctoria) : Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub S. t. L. var. lancifolia S.F. Gray); Biagioli & al. 2002: soprattutto in ambienti freschi e ombrosi di pineta, anche su substrato maturo serpentinoso.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
NB: si tratta, come si comprende anche dal nome, di una pianta tintoria: viene (o meglio veniva) utilizzata tutta la pianta per ottenere una colorazione gialla dei tessuti trattati (chimicamente la molecola colorante è un flavonoide).
Il genere Silybum
è costituito da 2 specie erbacee euro-mediterranee (1 in Italia). Si tratta di piante spinose, generalmente robuste a foglie intere e amplessicauli (ma non decorrenti sul fusto), a soli fiori tubulosi uguali fra loro, stami con filamenti saldati completamente in un tubo, ricettacolo con pagliette lesiniformi e squame involucrali patenti, acheni senza coste e a setole denticolate.
-Silybum marianum (L.) Gaertn. CARDO DELLA MADONNA
H bienn – Medit.-Turan. - VI-VIII – Relat. comune, a volte molto abbondante nei luoghi di crescita.
Erbacea robusta e alta 30-150 cm, caratterizzata da grandi foglie (lunghe fino a 40 cm), glabre, lucide, venate di bianco e spinose sul bordo, le cauline, minori, abbraccianti il fusto con 2 orecchiette ottuse; da capolini grandi (più di 3 cm), lungamente peduncolati, emisferici, con brattee esterne patenti-prominenti, triangolari e munite di spina apicale e spinule laterali; i fiori sono tubulosi e di colore porporino; gli acheni sono nero-lucidi con pappo bianco, lunghi 6-7 mm circa.
Habitat: ambienti ruderali, margini sentieri e strade, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra il Fabbro verso Migliana poche piante (2017), presso Gricigliana (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021 (ricchi popolamenti).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: sopra il lago Castagnati (Carmignano); oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: Cave della Gonfolina (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: su terreno non ofiolitico presso l’ex-cava di Gello (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): Malcantone (Prato).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: argine del Bardena a Galcetello (ricco popolamento) (2017).
PS: gli acheni contengono silymarina, complesso flavonoide di comprovata azione epatoprotettice. La pianta, sia la radice che le foglie ed i capolini, è utilizzata anche in cucina. L’epiteto marianum (della Madonna) è collegato alle venature bianche sulle foglie, che hanno fatto pensare ai dotti galattofori di Maria, madre di Gesù!
Il genere Solidago
è distribuito soprattutto in N-America, ma è presente anche in Europa ed Asia con un numero di specie che si aggira sul centinaio (in Italia 1 nativa con 3 sottospecie, 1 ibrido e 2 esotiche). Le sue piante sono erbacee con capolini - dotati di fiori gialli, i ligulati periferici in un solo rango e i tubulosi centrali più numerosi, squame involucrali su più di 1 rango - che si riuniscono in infiorescenze a racemo o panicolo; acheni cilindrici a pappo setoloso.
-Solidago gigantea Aiton VERGA D’ORO MAGGIORE
H scap – Neofita invasiva di orig. N-Americ. - VII-IX – Rara.
Erbacea robusta, a fusto eretto, glabro e foglioso, alta da 50 a più di 200 cm; foglie alterne con breve picciolo, glabre, lanceolato-acuminate (le superiori più sottili) e dentellate al margine; i capolini - piccoli (ca. 5 mm di diametro) a fiori giallo-vivo (i ligulati lineari e brevi, solo ¼ maggiori dei tubulosi), squame involucrali sottili ed in più ranghi - sono riuniti in panicolo terminale contratto.
Habitat: incolti umidi e argini di corsi d’acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentrella orientale.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub S. serotina); non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2013a e Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: presso il cimitero di Montecuccoli e a N di Colle (Cantagallo).
-Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea VERGA D’ORO
H scap – Circumbor. - VII-X – Relat. comune.
Erbacea glabra o quasi, a fioritura estivo-autunnale, alta da 15 a 90 cm, con fusto eretto, foglie ovali-oblunghe, basali e cauline (queste alterne), dentellate al margine e le inferiori picciolate (picciolo alato); capolino - a fiori gialli tubulosi interni e ligulati periferici, squame involucrali ottuse e in più serie - in alto disposti in infiorescenze a grappolo o in panicolo allungato.
Habitat: varie tipologie di bosco, boscaglie, arbusteti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005: riserva Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: dal Tabernacolo di Gavigno verso le Scalette e verso Fossato (2017); strada bianca da Migliana verso Le Cavallaie (2024) (Cantagallo); Fonte del Romito (2018), Sasetta, Montepiano, Alpe di Cavarzano (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998; Biagioli & al. 1999 (sub Verga d’oro): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Arrigoni & Viciani 2001 e Viciani 2001: castagneto a Fornia (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: rara nei boschi, anche in pineta su serpentino.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub S. v. L. subsp. virgaurea) (S).
Il genere Sonchus
è costituito da un’ottantina di specie distribuite in Europa, Asia, Africa e Australia (in Italia vi sono 7 specie e alcune sottospecie). Si tratta di piante erbacee annuali, bienni o perenni a latice bianco, non sono stolonifere, e sono spesso glabre o poco pelose; le foglie sono intere o pennatosette, basali e cauline, i capolini hanno numerosi fiori ligulati (gialli o blu), ricettacolo nudo e squame involucrali ineguali e su più ranghi; l’achenio, privo becco, è provvisto di pappo sessile.
NB: molte delle specie spontanee italiane sono ottime commestibili (fra i migliori “radicchi”) sia da crude (in stadio giovanile) che da cotte.
Foto B. Pierini
-Sonchus arvensis L. subsp. arvensis GRESPINO DEI CAMPI
H scap – Subcosmop. - VI-IX – Assai raro.
Erbacea di 50-150 cm, glabra a fusto eretto, peloso-ghiandoloso (ghiandole gialle!) solo in alto, dove rimane anche indiviso; le foglie sono pennatopartite o pennatifide a 2-3 paia di lobi laterali e 1 terminale per lo più grossolanamente dentellati (a volte anche a margine intero), le cauline, minori, sono abbraccianti il fusto con due brevi orecchiette ottuse; i capolini (2-4 cm di diametro) - a fiori ligulati di 12-13 mm, con lungo peduncolo ispido-ghiandoloso e stimmi gialli - sono riuniti in corimbo paucifloro; acheni scuri, di 3-3,5 mm, fortemente striati trasversalmente e con pappo bianco.
Habitat: campi, incolti erbosi, aree marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Fiori 1914; non ritrovato da Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: qualche pianta sporadica alla Gretaia (Montemurlo) e a Pian di Gello (Prato).
-Sonchus asper (L.) Hill. subsp. asper GRESPINO SPINOSO
T scap/H bienn – I-XII – Relat. comune.
Erbacea di 20-100 cm, a fusto fistoloso, eretto e spesso ramificato anche in alto, con foglie oblunghe, pennatifide o intere, caratteristicamente lucide e spinulose sui denti, le cauline abbraccianti con orecchiette larghe e arrotondate; i capolini - a soli fiori ligulati gialli e con stimmi e stili verdastri, a involucro glabro o con qualche ghiandola stipitata – sono riuniti in cime; acheni lisci (o quasi).
Habitat: coltivi, margini stradali, incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: fonte del Romito (2019), Sant’Ippolito (2023) (Vernio), Gricigliana (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Monteferrato: Fiori 1914; non ritrovata da Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: anche su ofioliti.
Qua e là è presente in pianura, anche in zone urbane.
Foto B. Pierini
?-Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. bulbosus GRESPINO BULBOSO
G bulb – Medit. - III-VI – Rarissima o scomparsa dal nostro territorio.
Erbacea a fusti eretti o ascendenti moncefali e semplici, ghiandolosi sotto il capolino, con lungo peduncolo afillo (con 1-2 squame), altezza 8-30 cm e caratterizzata dalla radice a lunghi rizomi terminati da bulbilli di 1-2 cm emettenti sottili e lunghi stoloni; foglie radicali glabre, lanceolate e picciolate; capolini a fiori gialli, squame involucrali in più ranghi; achenio a pappo sessile e 2 volte più lungo del corpo.
Habitat: zone sabbiose, incolte, in ambiente mediterraneo.
Distribuzione sul territorio:
- Pianura: Caruel 1860-66 (sub Crepis bulbosa L.): fra Signa e Poggio a Caiano...(Parl!).
Non più ritrovata.
-Sonchus oleraceus L. GRESPINO COMUNE
T scap (H bienn) – Subcosmop. - I-XII – Comune.
Erbacea molto simile a S. asper (vedi); se ne distingue per le foglie (roncinate, pennatifide o pennatopartite con lobo terminale triangolare e grande) lisce e non spinulose e le cauline con orecchiette acute e patenti, l’involucro glabro e gli acheni fortemente rugosi sulle creste; il fusto si presenta con poche ramificazioni in alto.
Habitat: zone marginali, ruderali, coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Vernio, Cantagallo; nuovi ritrovamenti: da sopra a Badia all’Alpe di Cavarzano (2018) (Vernio); via delle Cavallaie a Migliana (2024) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: osservato più di frequente di S. asper su serpentino (Montemurlo, Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: ben rappresentato anche in pianura.
Il genere Staehelina
(dedicato al botanico tedesco Benedikt Staehelin) conta ca. 4 specie mediterranee (solo 1 in Italia). Si tratta di cespuglietti sempreverdi e per lo più tomentosi ed assai ramificati a foglie alterne e ± lineari; i capolini - con solo pochi fiori tubulosi, ricettacolo con pagliette squamose, involucro cilindrico a segmenti ineguali ed inferiori alla corolla - possono presentarsi solitari o in gruppi poco numerosi; acheni quasi lineari con pappo caduco a a setole lisce su un solo rango.
-Staehelina dubia L. PENNELLINI
Ch frutt – W-Medit. - V-VIII – Abbastanza rara, localizzata.
Suffritice (ad uno sguardo superficiale fa pensare ad una Centaurea!) assai ramificato, pubescente, alto 15-40 cm; foglie allungate, a margine da intero-ondulato a finemente dentato, bianco-tomentose di sotto; i capolini, con fiori tubulosi porporini, lungamente peduncolati, si mostrano solitari o riuniti in corimbo povero; acheni lineari lunghi ca. 5 mm con pappo candido e assai lungo (da cui il nome volgare Pennellini).
Habitat: aree sassose e radure boschive per lo più su substrato calcareo (almeno da noi).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Pennellini): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: la Serra, Ginestre di Verghereto, bosco di Montalgeto (Carmignano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: su calcare sulla strada per l'ex-cava Guarino (Montemurlo).
Il genere Symphyotrichum
conta poco meno di un centinaio di specie presenti in America e in parte nelle Indie orientali (una decina di specie e due ibridi si sono naturalizzati in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni o bienni con foglie persistenti alla fioritura, capolino a ricettacolo nudo, involucro a squame in diverse serie e ligule mai colorate di giallo (come lo sono invece i fiori tubulosi centrali), acheni provvisti di pappo; simile ad Aster (vedi), genere a cui erano attribuite fino a poco tempo fa; si distingue soprattutto per le infiorescenze più lasse (panicoli ovoidi o piramidati) e con un alto numero di capolini che presentano le squame involucrali inferiori dritte e appressate (in Aster revolute in fuori). Dal genere Erigeron si distingue per il fatto che quest’ultimo presenta fiori ligulati ben sviluppati, raggianti, più lunghi dell’involucro e posti in 2-3 serie.
-Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom ASTRO LANCEOLATO
H scap – Neofita di orig. N-Americ. - VIII-X – Rarissima.
Erbacea a fusto eretto e ramificato, alta 50-120 cm; foglie non divise, lineari-lanceolate, le cauline medie e superiori non abbraccianti; capolini numerosi, di 1,2-2 cm di diametro, a fiori ligulati bianchi o lillà, involucro lungo 5,5-6 mm con squame diverse fra loro e in più serie e con le esterne lunghe meno della metà delle altre e biancastre almeno in basso.
Habitat: margine coltivi, luoghi erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 (sub Aster lanceolatus Willd.): al confine con la provincia di Firenze verso Travalle.
- Montalbano: GP13 (sub Galatella sedifolia (L.) Greuter): sponde dell’Arno alla Nave (Carmignano)*.
*è stata corretta la determinazione precedente sulla base ad una attenta revisione delle immagini della pianta del Montalbano.
?-Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom ASTRO DELLA NUOVA INGHILTERRA
H scap – Neofita naturalizzata di orig. N-Americ. - VIII-XI – Rarissimo o probabilmente scomparso.
Erbacea cespitosa, a fusti eretti, alta 30-120 cm; si caratterizza per la ricca presenza di ghiandole in alto sul fusto pubescente; per le foglie lanceolate-acute in alto e ridotte, cordato-amplessicauli e ciliate quelle delle rami laterali; squame involucrali in più serie, lineari-lanceolate; capolini del diametro di 2-4 cm, a ligule raggianti di colore dal rosa pallido, a rosa oscuro, al bianco, al viola, molto numerosi (50-100); i fiori tubulosi gialli.
Habitat: presso giardini e aree abitate (specie occasionale, sfuggita alle coltivazioni).
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: oliveta presso Casa Pianali (Montemurlo), dove evidentemente in passato veniva coltivata; Arrigoni & Viegi 2011 (sub Aster novae-angliae L.).
-Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom ASTRO AMERICANO
H scap – Neofita naturalizzata – IX-XI – Rara.
Erbacea di 50-150 cm, a fusto eretto, ramoso nella metà superiore, privo di ghiandole e pubescente in alto; foglie da ovali a lanceolate, glabrescenti, sessili con le superiori amplessicauli ad orecchiette acute; fiori – i ligulati violetti, più raramente rosei, o bianchi, i tubulosi gialli, con involucro lungo 5-9 mm a squame embricate – riuniti in capolini (diametro 20-30 cm) numerosi a formare infiorescenze a panicolo.
Habitat: presso corsi d’acqua, boschi umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Aster novi-belgii L.): presso l’Acqua (Cantagallo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: rr, argine dell’Arno alla Nave (Carmignano).
- Monte le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): sull’argine della Bardena a Figline (Prato).
-Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom. ASTRO ANNUALE
T scap/H scap – Neofita invasiva di orig. Americ. Trop. - IX-XI – Comune.
Erbacea alta fino a 1 m, con fusto eretto e ramificato nella metà superiore, a foglie alterne, lineari-lanceolate, le inferiori picciolate, le superiori sessili ed ancora più sottili; i capolini, molto numerosi, sono piccoli (1 cm o meno di diametro) e numerosi, con fiori tubulosi centrali gialli e ligulati periferici bianchi o violetti, molto brevi (superano di poco l’involucro); acheni di 1,5 mm con breve pappo.
Habitat: incolti, margini stradali, marciapiedi, aree ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Migliana (2022) (Cantagallo) e altrove...
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 ( sub Aster squamatum (Sprengel) Hieron) Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; Arrigoni & Viegi (Aster squamatus (Sprengel) Hieron).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Aster squamatus (Sprengel) Hieron): su terreno evoluto, es. Fonte della Cava ecc. (Montemurlo); Arrigoni & Viegi (Aster squamatus (Sprengel) Hieron)
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Brugnani loc Bocca Vittoria, incolti e campi fra Iolo e Caserane, incolto presso cimitero di Chiesanuova (2023) (Prato) e altrove...
-Symphyotrichum X salignum (Willd.) G.L. Nesom ASTRO A FOGLIE DI SALICE
H scap – Neofita naturalizzata di orig. N-Americ. - VIII-IX – Rara.
Erbacea a fusto eretto e ramificato, privo di ghiandole, alta 50-150 cm; molto simile S. novi-belgii, dal quale si distingue per le foglie (lanceolate) superiori sessili, ma a base ristretta e non abbracciante il fusto (le inferiori sono picciolate); le squame involucrali non appaiono embricate e le esterne superano almeno i 2/3 della lunghezza delle interne (in S. novi-belgii i 2/3 ne rappresentano la lunghezza massima); i fiori ligulati si presentano bianchi all’inizio per poi virare al blu-violaceo.
Habitat: zone umide e erbose.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: presso Carteano, a W di Cavagliano (Prato).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Aster x salignus Willd.): oliveta Casa Pianali (Montemurlo); Arrigoni & Viegi 2011 (sub Aster x salignus Willd.).
Il genere Tagetes
è costituito da una cinquantina di specie distribuite in America tropicale e caldo-temperata in particolare nel Messico (in Italia si possono incontrare solo due specie occasionali). Si tratta di erbacee spesso fortemente odorose, con fusto ramificato, le foglie si presentano pennatosette con le cauline a divisioni primarie dentellate, i capolini hanno squame involucrali saldate in un tubo cilindrico, i fiori ligulati del raggio possono essere gialli, rossi o aranciati, quelli tubulosi del disco da giallo-verdastri ad arancioni con la cima a volte purpurea; gli acheni presentano un pappo di piccole scaglie larghe e diverse fra loro.
-Tagetes erecta L. TAGETE ERETTA
T scap – Neofita occasionale di orig. C-Americ. - VI-X – Rara.
Erbacea maleodorante, di 10-150 cm, a fusto ramificato in alto; le foglie sono pennatosette a 11-15 foglioline; i capolini unici o pochi e portati da peduncoli lunghi 3-15, cm sono formati da pochi fiori gialli o arancioni.
Habitat: aree abitate, oliveti, argini del fiume.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: D’Antraccoli & al. 2016 e Gestri & Peruzzi 2016: a N di Colle (Vaiano): adesso scomparsa.
Alcune specie del genere Scorzonera (una decina distribuite in Eurasia, una sola in Italia) sono state collocate in un genere definito per la prima volta in un recente articolo del 1990 da Nazarova ("Biologicheskii Zhurnal Armenii. Erevan" ( Biol. Zhurn. Armenii 43(3): 179): genere Takhtajaniantha. Esso è caratterizzato soprattutto dalle ligule gialle venate di viola, il fusto in basso con residui fogliari, le foglie ad apice acuto, l’achenio con pappo bianchissimo ecc.
-Takhtajaniantha austriaca (Willd.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian (=Scorzonera austriaca Willd.) SCORZONERA BARBUTA
H ros – SE-Europ.-S-Siber. (Pontica) – IV-V – Localizzata al Monteferrato.
Erbacea glabra e glaucescente, con grossa radice verticale e con colletto circondato da abbondanti fibre filamentose brunastre, fusto di 10-40 cm, eretto, fistoloso in alto, semplice e monocefalo, generalmente senza foglie (a volte 1 o 2 scaglie superiormente); foglie radicali coriacee, lungamente lanceolate e attenuate in un picciolo, le eventuali cauline più piccole e sessili; capolino (3-4 cm di diametro) a soli fiori ligulati gialli lunghi 2-2,5 cm, squame involucrali in più serie, le superiori lineari; acheni subcilindrici a pappo piumoso bianco.
Habitat: incolti rocciosi, praterie aride (almeno da noi si tratta di una serpentinofita preferenziale).
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Caruel 1866 (sub Scorzonera austriaca Willd.): al M. Ferrato!; Baroni 1897-1908 (sub Scorzonera austriaca Willd.): presso Prato sul M. Ferrato (Car., Somm.herb.); Fiori 1914 (sub Scorzonera austriaca); Messeri 1936 (sub Scorzonera austriaca Willd. var. stenophylla Beck.); Arrigoni & al 1983 (sub Scorzonera austriaca Willd.); Ricceri 1998 (sub Scorzonera austriaca Willd.); Biagioli & al. 1999 (sub Scorzonera barbuta); Biagioli & al. 2002 (sub Scorzonera austriaca Willd.): su serpentino un po' in tutti gli ambienti.
Il genere Tanacetum
è costituito da più di 150 specie a distribuzione olartica (in Italia 7 specie ed alcune sottospecie). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni, generalmente aromatiche, a fiori tubulosi e ligulati, simili a Leucanthemum (vedi) dal quale si distinguono soprattutto per la forma convessa del ricettacolo, per gli acheni che hanno 5-10 coste poco evidenti, i capolini eretti anche prima della fioritura e disposti in corimbo lasso in alto sul fusto; per lo più le foglie sono da pennatifide a pennatosette.
-Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. achilleae (L.) Greuter ERBA-AMARA A FOGLIE D’ACHILLEA
H scap – SE-Europ. - VII-VIII – Non raro.
Erbacea a fusto eretto e ramificato, con peli appressati, alta 40-120 cm; foglie pennatosette a contorno oblungo-spatolato e a 5-15 coppie di segmenti lanceolati inciso-dentati, le basali lungamente picciolate, le cauline sessili; i capolini (2-4 cm di diametro) - a fiori ligulati bianchi, tubulosi gialli e squame involucrali a bordo brunastro - sono riuniti in un lasso corimbo; gli acheni sono lunghi 2-3 mm. La nostra sottospecie è caratterizzata soprattutto dalle foglie cauline medie profondamente incise, con foglioline di prim’ordine 2-pennatosette a segmenti acuti e assai sottili (inferiori a 2 mm di larghezza).
Habitat: boschi radi e aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005 (sub T. corymbosum (L.) Sch.Bip.): riserva naturale Acquerini-Cantagallo; nuovi ritrovamenti: da Vernio al Gorandaccio e oltre verso Montepiano (2022) (Vernio); Migliana a N della chiesa (2021) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Chrysantemum achilleae); Arrigoni & Bartolini 1997 (sub T. achilleae Sch. Bip. e sub T. c. (L.) Sch. Bip. s.l.); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; 2 oss. Jacopo 2020 Wikiplantbase#Toscana: Collina di S. Leonardo (Vaiano).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Erba amara): AMPIL del Monteferrato; Ricceri 2006 (sub Chrysanthemum achilleae L.) e Foggi & Venturi 2006 (sub Chrysanthemum achilleae L.): ambienti collinari pref. calcarei del Pratese.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Chrysantemum achilleae); Messeri 1936 (sub Chrysantemum corymbosum L. var. achileae (L.) Fiori); Arrigoni & al. 1983 (sub Chrysantemum corymbosum L. var. achileae (L.) Fiori); Biagioli & al. 2002 (sub Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.): boschi chiari su serpentino e non.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C ).
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: verso Schignano (2023) (Vaiano).
-Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. ERBA-AMARA VERA
H scap – Eurasiat. (per alcuni AA esotica di orig. Asiatica) – V-IX – Non comune.
Erbacea perenne, aromatica (odore di piretro), a fusto eretto (alto fino a 60 cm) e ramificato in alto; foglie bipennatosette a contorno ovato e con segmenti ottusi, incisi e larghi almeno 1 cm; le foglie superiori picciolate; capolini numerosi e costituiti da fiori tubulosi gialli al centro e ligulati (più brevi di 8 mm o nulli) bianchi alla periferia.
Habitat: zone marginali a mezz’ombra, radure di boschi chiari, ruderi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; oss. Gestri 2014 Wikiplantbase#Toscana: sopra Migliana verso Le Cavallaie (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: sopra Codilupo (2023) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Chrysanthemum parthenium); non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: ai Bifolchi (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: Rocca di Montemurlo (2008).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: Volpaia (Montemurlo), zona marginale non ofiolitica; Arrigoni & Viegi 2011.
NB: per alcuni Autori è specie originaria delle regioni mediterranee orientali che si è diffusa da noi anche per il fatto che in passato veniva coltivata per le sue supposte proprietà fitoterapeutiche; esse erano considerate legate soprattutto al parto e ai problemi di salute delle giovani donne (parthenos significa infatti, in greco latinizzato, “delle vergini”).
-Tanacetum vulgare L. ERBA-AMARA SELVATICA
H scap – Eurasiat. - VII-IX – Relat. raro.
Pianta eretta, aromatica, non o poco ramificata, alta 30-120 cm, con foglie grandi e fortemente segmentate e dentate, ad apice acuto, le basali sono lungamente picciolate, le cauline sessili; i capolini (0,7-1,3 cm di diametro), a soli fiori tubulosi di colore giallo oro e con squame involucrali membranose e sfrangiate al margine, sono riuniti in corimbo serrato più o meno piano; acheni lunghi sui 2 mm a 5 coste.
Habitat: ambienti marginali ed incolti con un certo grado di umidità.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Foggi & Venturi 2006: sopra Montepiano; nuovi ritrovamenti: da Montecuccoli alla Dogana (2021) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: tra Fabio e Savignano, sotto C. Sanico (Vaiano).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021: Cassa espansione dell’Ombrone.
- Colline di Montemurlo: Foggi & Venturi 2006: presso Montemurlo.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: presso ex-cava Guarino (Montemurlo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: sotto le vecchie cave della Gonfolina, v. Vergheretana, a W di S. Cristina a Mezzana (Carmignano).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Castelnuovo (2023) (Prato).
(All.3 LR 56/2000)
N.B: è specie aromatica e di sapore fortemente piccante che un tempo era molto utilizzata in cucina per la preparazione di omelette (in Francia specialmente) e in alternativa ad altre spezie molto costose: non risponde più ai gusti culinari attuali, ed è stata pressoché abbandonata.
Il genere Taraxacum
è molto complesso dal punto di vista sistematico, anche perché la maggior parte dei suoi taxa è apomittica e ciò comporta la formazione di microspecie numerose e spesso molto simili fra loro. A seconda degli Autori, infatti, il numero stimato di specie va da 60 a più di 2000; esse sono distribuite soprattutto in Europa ed Asia, ma anche in N- e S-America, Australia e Nuova Zelanda. Molte specie (o microspecie) vengono aggregate in settori molto più facilmente distinguibili senza la necessità di un esperto.
Il genere si caratterizza per le piante prive di caule, ovvero i peduncoli fiorali (a capolino unico terminale) nascono direttamente dalla radice, come le foglie (prive di spine) che sono tutte basali; i fiori sono solo ligulati e gialli e le squame involucrali sono disposte in due ranghi; gli acheni hanno un lungo becco sottile.
-Taraxacum F.H.Wigg sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. PISCIALLETTO A SEMI ROSSASTRI
H ros – Eurosib. - IV-VII – Non particolarmente raro.
I Taraxacum di questo settore (che contiene, come gli altri, numerose microspecie difficilmente differenziabili fra di loro) si caratterizzano per gli acheni di colore rossastro (dal greco: erythros, rosso e sperma, seme) e le foglie profondamente divise in segmenti sottili; hanno peduncoli radicali eretti o ascendenti e alti 3-20 cm.
Habitat:
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub T. laevigatum (Willd.) DC.): presso Roncomannaio (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: sopra Cantagallo verso La Rasa sentiero CAI 38 (2018), sopra Gricigliana, sopra Montecuccoli (2023) (Cantagallo); Alpe di Cavarzano verso la Scoperta, P. di Petto (2018) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub T. fulvum group) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub T. laevigatum (Willd.) DC.): parco di Galceti e lungo la Bardena (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2023) (Prato).
-Taraxacum sect. Palustria (H.Lindb.) Dahlst.
H ros – Eurosib. - V-VII – Relat. raro.
I Taraxacum di questo settore (che contiene, come gli altri, numerose microspecie difficilmente differenziabili fra di loro) si caratterizza per l’involucro ovale non ristretto in basso e con le squame verde-scuro e glabre; esse, anche all’antesi, si presentano con le esterne che restano appressate alle interne; le foglie appaiono per lo più intere o sinuato-dentate (non ± profondamente dentate come negli altri due settori); acheni spinulosi in alto e di colore dal bruno al giallo-paglierino; hanno peduncoli radicali eretti o ascendenti e alti 4-25 cm; la fioritura è esclusivamente primaverile e le sue specie vegetano solo in ambienti umidi.
Habitat: zone fresco-umide.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: verso l’Acquerino (2020) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 (sub T. palustre aggregato) e Gestri & Peruzzi 2016: S. Lucia (Prato), alle Ventose (Cantagallo).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la Fattoria di Javello (2021).
- Montalbano: PG13: Carmignano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): S. Lucia.
Di questo settore sono state riconosciute due “microspecie”:
Foto L. Peruzzi
-Taraxacum divulsifolium Soest TARASSACO CON FOGLIE LACERATE
H ros – C-Europ. - II-IV – Rarissimo.
Fa parte del settore Palustria (H.Lindb.) Dahlst. (vedi).
Habitat: zone fresco-umide.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Carlesi & Peruzzi 2010: Bosco di Bonistallo (P. a Caiano).
-Taraxacum olivaceum Soest TARASSACO OLIVACEO
H ros – SE- Europ. - II-V – Relat. raro.
Fa parte del settore Palustria (H.Lindb.) Dahlst. (vedi).
Habitat: zone umide.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 (sub T. palustre aggregato) e Gestri & Peruzzi 2016: M. Bologna (Vaiano).
- Monte Le Coste: Carlesi & Peruzzi 2010: rivolo a margine del sentiero che porta alla cima del Monte Le Coste (Prato); Gestri & Peruzzi 2013b: a E del passo di Cerreto (Prato).
-Taraxacum F.H.Wigg. sect. Taraxacum F.H. Wigg. PISCIALLETTO
H ros – Circumbor. - I-XII – Assai comune.
I Taraxacum di questo settore (che contiene, come gli altri, numerose microspecie difficilmente differenziabili fra di loro) sono quelli che una volta venivano riferiti genericamente a Taraxacum vulgare L. o officinale Weber: hanno acheni color grigio-brunastro, le squame involucrali esterne si presentano patenti o riflesse e i segmenti in cui si dividono le foglie (triangolari lanceolati o stretti e allungati, sempre assai profondi) sono più ampi di quelli dei precedenti “gruppi”; hanno i peduncoli radicali eretti o ascendenti e alti da 6 a 30 cm.
Habitat:
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005 (sub T. officinale Weber): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub T. officinale Weber): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: verso il passo della Crocetta (2017) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub T. officinale); Gestri 2009 (sub T. officinale group) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub T. officinale Weber); Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: BGM02 (sub T. officinale Weber): zone marginali, non osservato sulle serpentine.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C).
PS: se si escludono le aree a serpentino si può dire che questa specie è quasi ubiquitaria.
Il genere Tephroseris
conta una cinquantina di specie distribuite nell’emisfero settentrionale (4 in Italia con varie sottospecie). Si tratta di piante erbacee perenni a fiori ligulati e tubulosi, a foglie intere, allungate e con nervatura pennata; sono molto simili alle specie del genere Senecio (vedi), di cui facevano anche fatto parte fino a qualche anno fa; se ne distinguono soprattutto per i capolini che formano un specie di ombrella terminale al fusto e per le squame involucrali disposte in 1 sola serie. Presentano fiori ligulati del raggio femminili e fiori tubulosi centrali ermafroditi.
-Tephroseris italica Holub SENECIONE TOSCANO
H ros – Endemismo dell’Italia centro-settentrionale – V-VII – Abbastanza comune in Calvana, manca altrove.
Erbacea tomentosa a fusto robusto ed eretto, alta 30-70 cm; le foglie sono profondamente dentellate, a lamina ± ovale, troncata o quasi cordata all’inserzione del picciolo alato (aspetto panduriforme) e con lanosità persistente sulla pagina inferiore anche all’antesi (mentre la superiore è glabrescente e verde); le foglie basali hanno un lungo picciolo che si riduce via via in quelle cauline fino a divenire sessili sotto l’infiorescenza; anche le loro dimensioni si riducono progressivamente verso l’alto, mentre al contrario si fanno più erette; i numerosi capolini - con 21 squame involucrali verdi e fiori ligulati periferici e tubulosi centrali gialli - si riuniscono in un denso corimbo terminale a pseudombrella. I peli di questa specie hanno un aspetto particolare: la parte inferiore (lo stilo) è costituita da 5-8 cellule sovrapposte con una cellula allungata posta di sopra (la sterza); quando la sterza ad un certo momento cade si porta dietro alcune cellule dello stilo riducendone il numero a 2-4.
Habitat: boschi ombrosi, margini e radure boschive e prati ad una certa quota (oltre 500-600 m), almeno nel Praetese sempre su substrato calcareo.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2002 (sub Senecio brachychaetus DC.): Mandrioni (Vaiano); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
Il genere Tolpis
è costituto da oltre una ventina di specie erbacee distribuite in area mediterranea, in Africa del S e orientale (3 in Italia con alcune sottospecie). Si tratta di piante a soli fiori ligulati gialli, con ricettacolo senza pagliette e squame involucrali numerose, molto strette e disposte in più ranghi; le foglie cauline sono per lo più di piccole dimensioni, l’achenio ha pappo formato da una coroncina membranosa con poche setole filiformi.
-Tolpis umbellata Bertol. RADICCHIO OMBRELLATO
T scap – Medit. - IV-VI – Relat. rara.
Erbacea alta fino a 70 cm, eretta e ramificata in alto, a foglie dentate: le basali lanceolate e in rosetta, intere o divise, le cauline ± lineari; infiorescenza a capolini piccoli (1-1,5 cm), terminali o all’angolo di ramificazioni, portati da un peduncolo rigonfio e provvisto di numerose squame più lunghe dell’involucro; le squame involucrali (setacee) esterne si presentano più lunghe delle interne; fiori ligulati di colore giallo-pallido; acheni centrali con pappo, i periferici dotati in alto di una coroncina di squame.
Habitat: silicicola di ambienti incolti e prativi (in zone a clima mediterraneo o submediterraneo).
Distribuzione sul territorio:
Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub T. barbata var. umbellata); Gestri & Lazzeri 2021.
Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
Monteferrato: Messeri 1936 (sub T. barbata Gaertn. var. umbellata Bert. - monocefala e quasi glabra -); non ritrovata da Biagioli & al. 2002, ma successivamente (nel 2003) rinvenuta da uno degli autori (B. Acciai) nel Parco di Galceti a margine di un campo di grano (Prato).
-Tolpis virgata (Desf.) Bertol. subsp. virgata RADICCHIO VIRGATO
H scap/H bienn – Medit. - V-VII – Rara.
Erbacea a fusto eretto, ramificato, glabro e striato, alta 30-100 cm; foglie dentate o non, di forma lanceolata, con le cauline che si fanno più strette e più piccole verso l’alto; i capolini, a fiori ligulati gialli, privi di brattee o quasi, sono riuniti in pannicolo lasso alla sommità del fusto; hanno squame involucrali esterne più brevi delle interne e gli acheni sono tutti provvisti di pappo.
Habitat: silicicola di ambienti incolti e prativi, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri in Peruzzi & al.2024: Migliana, loc. Ghiffia in incolto a margine stradale ed in loc. il Santo in via di Codilupo (Cantagallo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
Il genere Tragopogon
è costituito da oltre un centinaio di specie erbacee a distribuzione europea ed asiatica (11 in Italia). Le sue sono piante a soli fiori ligulati (di colore diverso), presentano foglie intere e lineari, capolini a ricettacolo nudo e involucro con squame poste su un solo rango e riflesse alla fruttificazione, acheni a lungo becco e con pappo di setole tutte piumose.
-Tragopogon eriospermus Ten. BARBA DI BECCO A SEMI LANOSI
H bienn – NE-Medit. - V-VII – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, alta da 40 a 150 cm, con radice ingrossata e fusiforme; si caratterizza per le foglie strette (lineari-lanceolate) dilatate in basso e abbraccianti il fusto, per le ligule (soltanto le periferiche raggianti) di colore rosa o malva chiaro, con apice concavo e denti poco evidenti, quelle esterne dei capolini terminali poco più brevi (a volte anche molto!) delle squame dell’involucro e più lunghe delle interne; il corpo dell’achenio si restringe bruscamente in un becco sottile lungo ca. il doppio del corpo stesso (il pappo più breve).
Habitat: incolti erbosi, margini coltivi con un certo grado d’umidità.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: nuovi ritrovamenti: da Montepiano al Gasperone, strada fra Sassetta e Montepiano, dall'Alpe alla Scoperta (2018), sopra il Gorandaccio, da Carmignanello a Gricigliana, dal lago Verde a S. Ippolito in ambiente fresco-umido (2023) (Vernio).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Montemurlo su via E. Berlinguer (2022).
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: dalla Collina a Schignano (2024).
NB: non considerata come entità a sé stante fino a qualche anno fa da molti AA, non compare nelle varie flore locali del Pratese (con l’eccezione di Gestri & Lazzeri 2021), ma è sicuramente più diffusa di quanto detto sopra e presente in altri ambiti territori della nostra Provincia!
-Tragopogon orientalis L. BARBA DI BECCO ORIENTALE
H scap - Eurasiat. - V-VII - Raro.
Erbacea a fusto eretto, alta 30-80 cm, molto simile a T. pratensis (di cui è stata considerata anche una sottospecie) dal quale si distingue per le ligule di colore giallo-oro e più lunghe delle squame involucrali e gli acheni lunghi 2-2,5 cm a frutto granuloso e inferiore al becco e pappo di setole pennate giallastre (le foglie a volte sono un po' ondulate al margine e arricciate in alto).
Habitat: prati sopra una certa altitudine.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub T. dubius Scop.*): a W del Passo della Croce e al Crocicchio (Vaiano).
*Una attenta revisione delle foto ci ha portati a modificare la determinazione precedente nella quale era stata data soprattutto importanza ad un certo rigonfiamento del peduncolo sotto il capolino.
NB: si tratta di specie segnalata per la prima volta nella provincia di Prato.
-Tragopogon porrifolius L. BARBA DI BECCO VIOLETTA, SALSEFICA
H bienn/H scap – Euro-Medit. - IV-VI – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, alta 30-100 cm, simile ad T. eriospermum dal quale si distingue per le foglie cauline superiori a margini ondulati, le ligule di colore violaceo-scuro, le esterne più brevi delle squame involucrali fino al max del 70% (spesso fino solo alla metà) e non raggianti, con apice piano a denti evidenti biancastri o giallastri; achenio con becco più breve o uguagliante il corpo.
Habitat: prati, incolti erbosi, margini stradali e boschivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & a. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Appennino di Vernio e Cantagallo; nuovi ritrovamenti: Sassetta, Alpe di Cavarzano, sopra S. Ippolito (CAI 146), da Montepiano verso il Gasperone (2018) (Vernio); da Fabbro a Migliana (2020) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009, Gestri & Peruzzi 2016 (sub T. p. L. subsp. porrifolius): Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Centopini e i Bifolchi.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Barba di Becco): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub T. p. L. subsp. australis (Jord.) Nyman e subsp. porrifolius): Carmignano, P. a Caiano; oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: a S di Artimino (Carmignano).
- Monteferrato: Baroni 1897-1908 (sub T.p. L.var. australis (Jord.) Arc.): M. Ferrato sopra Prato (Somm. herb.); Fiori 1914; non ritrovato da Messeri 1936; Biagioli & al. 2002: Pian di Gello (Prato), ex-cava Guarino (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S/C) (sub T. p. L. subsp. porrofolius).
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: dalla Collina a Schignano (2024).
NB: sicuramente alcune segnalazioni bibliografiche di cui sopra, sono da riferire a T. eriospermum!
-Tragopogon pratensis L. BARBA DI BECCO COMUNE
H scap – Eurosib. - V-VIII – Rarissima.
Erbacea glabrescente a fusto eretto e fiori ligulati gialli, alta 30-80 cm; si caratterizza rispetto alle congeneri per le foglie canalicolate e larghe 4 mm con inserzione sul fusto allargata fino a 1-1,5 cm e abbracciante, il peduncolo alla base del capolino non è (o molto poco) rigonfio, i fiori ligulati lunghi ± come le squame involucrali (in numero di 8 e fino a 12 e ripiegate in basso dopo l’antesi) e l’achenio di 1,5-2 cm con becco ± di uguale lunghezza.
Habitat: prati e incolti erbosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: Alpe Cavarzano (13-7-18) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: versante N di Cantagrilli (Prato).
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
PS: la pianta ritrovata all'Alpe di Cavarzano nel 2018 (di cui possiediamo solo l'immagine fotografica) appartiene versosimilente alla subsp. minor (Mill.) Wahlenb. in quanto (pur non essendo il peduncolo ingrossato sotto il capolino) ha le ligule evidentemente inferiori alla squame involucrali; non è possibile però osservare gli altri caratteri differenziali!
-Tragopogon samaritani Heldr. et Sart. BARBA DI BECCO DI SAMARITANI
H bienn – Orofila SE-Europ. - VI-VIII – Localizzata.
Erbacea glabra a fusto eretto e poco ramificato, alta 30-100 cm; si caratterizza per i peduncoli non ingrossati sotto il capolino, i fiori ligulati completamente gialli, il becco inferiore al corpo dell’achenio; è simile a T. pratensis dal quale si distingue per le foglie (graminiformi e per lo più larghe 2-5 mm) che non si allargano all’inserzione sul fusto e il numero di squame involucrali 5-7 invece di 7-8. L’involucro è lungo circa come i fiori ligulati.
Habitat: zone erbose, sassose, sopra una certa quota (500 m ca.).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra Montecuccoli (2016), CAI 16 vers. S. Ippolito (2017), tra Cavarzano e l’Alpe (2018), Gasperone (2020) (Vernio); dal Castello di Luicciana al P. delle Pescine, strada dagli Acquiputoli al Faggione (2019), sotto la Rasa (2024) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo, Vaiano
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: è il più comune fra i Tragopogon a fiori gialli!
Il genere Tripleurospermum
conta una quarantina di specie distribuite in Europa, Asia temperata, N-Africa e N-America olartica (1 soltanto in Italia). Le sue specie (a fiori ligulati periferici e tubulosi centrali) sono molto simili a quelle del genere Matricaria (vedi), nel quale ancora molti Autori le collocano; se ne distingue soprattutto per per il ricettacolo pieno e non cavo e la mancanza di intenso aroma di camomilla. Come dice il nome si caratterizza per i semi che presentano 3 coste evidenti (dal greco treis = 3, pleura = lato, costola e sperma = seme) e due ghiandole resinose in basso. Le foglie si presentano profondamente divise (2-3 pennatosette).
-Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. CAMOMILLA INODORA
T scap – Europ. - VI-X – Relat. rara.
Erbacea priva di aroma, alta 30-80 cm, a fusto eretto o ascendente, foglie scanalate inferiormente, non carnose, sessili e alterne, 2-3 pennatosette a lacinie molto sottili e mucronate; capolini solitari o pochi (da 1,5 a 4 mm di diametro) hanno fiori ligulati bianchi e tubulosi gialli, ricettacolo nudo, lungo come largo, convesso e pieno; gli acheni, rugosi, scuri e lunghi 1-2 mm, a tre coste evidenti e due ghiandole resinose alla base.
Habitat: aree incolte, margini stradali, di sentieri e di coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006 (sub Matricaria perforata Merat): Limentra orientale presso Acqua; nuovi ritrovamenti: presso il passo della Crocetta (2017), da Montepiano a Poggio di Petto (2018) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: a Canneto (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): cassa d’espansione del Bardena a Figline (2013), non ritrovata in seguito!
- Pianura: nuovi ritrovamenti: campi presso Casale (2024) (Prato).
NB: si ha l’impressione che questa specie faccia la sua apparizione in una data area per uno o pochi anni e poi scompaia; questo soprattutto quando un terreno è stato “smosso recentemente dall’uomo” per poi stabilizzarsi.
Il genere Tussilago
conta una sola specie erbacea a distribuzione euroasiatica. Si caratterizza per le foglie suborbicolari e cordate alla base (si sviluppano dopo la fioritura), fusti con molteplici foglie squamiformi e terminati da un solo capolino a fiori gialli, tubulosi al centro e ligulati in periferia, ricettacolo nudo e con squame involucrali in una serie.
-Tussilago farfara L. FARFARA, PAPARACCHIO
G rhiz – Paleotemp. - I-IV – Relat. comune.
Piccola pianta (fino a 30 cm), a precoce fioritura (con fiori che precedono le foglie), eretta con fusto ricoperto di scaglie semiabbraccianti da ovali a lanceolate; capolini solitari (12-15 cm di diametro) e terminali, con fiori tubulosi al centro e a ligule sottili e numerose alla periferia; le foglie appaiono a fine fioritura, hanno lunghi piccioli e forma suborbicolare, cordata alla base, sinuato-dentata al margine.
Habitat: incolti umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sotto le Scalette (2018) (Cantagallo); da Cavarzano all’Alpe e oltre (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998.
- Montalbano: Baroni 1897-1908: Montalbano; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone umide anche su serpentino; Ricceri 1993.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: un tempo si riteneva un’efficace fitoterapico sedativo della tosse ed espettorante (da cui il nome generico Tussilago); si è scoperto in seguito che contiene prodotti tossici per il fegato (alcaloidi pirrolizidinici) e quindi è divenuta fortemente sconsigliata per uso interno.
Il genere Tyrimnus
è monospecifico. Erbacea spinosa a capolini con involucro emisferico e soli fiori tubulosi, fusto alato molto simile a Carduus dal quale si distingue per le foglie lungamente decorrenti sul fusto, i peduncoli nudi per lungo tratto sotto il capolino (in Carduus tutte le foglie anche le cauline superiori sono ben sviluppate), gli stami a filamenti concresciuti (non liberi) e gli acheni prismatici (non ovati).
??-Tyrimnus leucographus (L.) Cass. CARDO VARIEGATO
T scap – Medit. - IV-VII – Probabilmente determinata per errore.
Erbacea bianco-ragnatelosa a fusto eretto e alta 20-100 cm, fogliosa in basso e con ramificazioni lungamente nude in alto e terminanti in un capolino (ca. 2 cm di diametro); foglie pennatopartite, lungamente decorrenti, caratteristicamente macchiettate di bianco sulla pagina superiore e spinose; squame involucrali sottili e terminate in una debole spina; fiori tubulosi porporini ± scuri (raramente bianchi).
Habitat: garighe, zone soleggiate e calde.
Indicata in Biagioli & al. 1999 per l’Area Protetta del Monteferrato e non più ritrovata: si tratta in Toscana di specie presente solo sulle isole, presso la costa o nella sua più parte meridionale (grossetano e senese).
Il genere Urospemum
conta 2 sole specie a distribuzione euro-mediterranea, ambedue presenti in Italia ed anche nel Pratese. Deriva il proprio nome dal greco oura, becco, e spermum, seme: allusione al lungo becco di cui sono dotati gli acheni. Si tratta di specie erbacee prive di spine, a fiori tutti ligulati e gialli, con ricettacolo peloso e privo di pagliette, squame involucrali in un solo rango ed uguali fra loro; le foglie basali si presentano pennatosette e picciolate, le cauline lanceolate e sessili; acheni con pappo di peli piumosi.
-Urospermum dalechampii (L.) F.W.Schmidt BOCCIONE MAGGIORE
H scap – Euro-Medit. CW – III-VIII – Comune.
Erbacea perenne a fusto eretto o ascendente, fogliato in basso, alta 20-50 cm; si caratterizza per caule, foglie e squame dell’involucro (di forma lanceolata) tomentose, ma non ispide; il capolino spesso è unico (o pochi) e del diametro di 6-7 cm; i fiori ligulati sono di colore giallo pallido ed hanno i dentini del margine apicale rosso-nerastri; il becco dell’achenio non appare dilatato alla base e il pappo è di colore bianco-rossastro.
Habitat: incolti erbosi, zone marginali, campi e prati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Fabbro verso Migliana (2019) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: i Bifolchi (Prato).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; campione erbario PI: F. Roma-Marzio & P. Liguori: 25-3-17, sulle mura de la Rocca di Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub U. d. F.W.Schm. var. typicum Fiori); Biagioli & al. 2002: un po’ in tutti gli ambienti.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galcetello (2022), Iolo (2024) (Prato) e altrove...
-Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt BOCCIONE MINORE
T scap – Euro-Medit. - II-VII – Relat. comune.
Erbacea annuale a fusto eretto e ramoso, alta 15-40 cm; si caratterizza per fusto e foglie a peli rudi ed ispidi, brattee dell’involucro ovate e acuminate, ispide, ma non tomentose; capolini ± numerosi e del diametro di 2-4 cm; fiori ligulati di colore giallo vivo e con dentini apicali concolori; becco dell’achenio assai rigonfio alla base, pappo bianco candido.
Habitat: incolti erbosi e margini di coltivi, radure.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sotto Migliana e da Migliana verso Schignano (2023) (Cantagallo); strada per la Rocca di Vernio (2023) (Vernio).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Praoto, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908: Prato (Somm. herb.).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: nuovi ritrovamenti: sopra le ville di Bagnolo (2019) (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Il genere Xanthium
conta una decina di specie (per alcuni Autori molte meno) presenti nelle zone calde e temperate del globo (3 presenti – 2 naturalizzate-invasive ed 1 autoctona – in Italia). Si tratta di erbacee annue, per lo più spinose, a soli fiori tubulosi: i fiori maschili sono riuniti in capolini globosi, con involucro a squame libere e ricettacolo munito di pagliette, i femminili in capolini a 2 fiori; i capolini si presentano solitari alle ascelle fogliari assemblati per lo più in glomeruli o cime – i maschili sono collocati, poco numerosi, in alto; caratteristici i grandi frutti (con acheni privi di pappo) che hanno involucro spinoso, sono coriacei e presentano due protuberanze superiori, simili o dissimili fra loro; le foglie sono alterne, intere o variamente lobate.
-Xanthium orientale L. (Xanthium italicum Moretti) LAPPA ITALIANA
T scap – Neofita invasiva di origine Americana – VIII-X - Relat. comune, localizzato.
Erbacea alta fino a 70 cm, con foglie triangolari, cordate alla base, irregolarmente lobate, picciolate e senza spine inserite alla loro base; caratteristici gli involucri dei capolini, persistenti e induriti, coperti di spine sottili ricurve in alto e con le due apicali più grandi e ripiegate a uncino; il frutto è lungo 2-3 cm.
Habitat: soprattutto propria di aree ruderali e zone sabbiose.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub X. orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter): Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021 (sub X. italicum Moretti)
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub X. orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter): Carmignano, P. a Caiano.
- Pianura sugli argini melmosi dei fiumi (anche zone submontane): Foggli & Venturi 2009 (sub X. Italicum); nuovi ritrovamenti: da Galcetello a Maliseti (2019).
NB: gli uncini dei frutti servono alla dispersione dei semi nell’ambiente, ancorandosi a tutto ciò che li urta (pellicce di animali, indumenti ecc.).
-Xanthium spinosum L. LAPPA SPINOSA
T scap – Neofita invasiva di origine S-Americana – VII-X – Relat. raro, localizzato.
Erbacea a fusto ramoso dalla base, pubescente e prostrato-ascendente, alta 20-100 cm; alla base delle foglie (picciolate, intere o tri- penta-lobate, cuneiformi alla base) vi sono lunghe spine giallastre triforcate (caratteristica fondamentale per il riconoscimento); il frutto di 1-1,5 cm, si presenta ellittico-oblungo con involucro coperto da spine gracili e ricurve con all’apice due protuberanze non molto evidenti e diverse fra loro.
Habitat: aree ruderali, incolti assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Cantagallo.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: rio Balloni (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Xanthium strumarium L. LAPPA MINORE
T scap – Cosmop. - VII-X – Relat. raro e localizzato.
Erbacea alta 20-120 cm, eretto, ramoso, pubescente e con assenza di spine triforcate alla base delle foglie; queste si presentano a lamina ovato-triangolare, cordiforme all’inserzione del lungo picciolo; il frutto ovoide, verdastro, è lungo 1,2-1,8 cm e coperto di spine acute e non o poco uncinate, peli semplici e ghiandolari; in alto due protuberanze coniche, dritte, molto acute e abbastanza simili fra di loro.
Habitat: zone ruderali, incolti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cava di Gello (Prato); Gretaia (Montemurlo).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: via Brugnani loc. Bocca Vittoria, alveo del Bisenzio in zona Palco di Sotto (2023) (Prato).
Il genere Xeranthemum
conta 4-5 specie (un tempo ve ne erano incluse molte altre, che adesso fanno parte di altri generi) distribuite in area mediterranea e W-asiatica (3 in Italia). Si tratta di specie erbacee annuali e inermi, per lo più inferiori in altezza ai 50 cm, a fiori solo tubulosi (gli esterni pochi e sterili o maschili, gli interni numerosi ed ermafroditi); l’infiorescenza è costituita da numerosi piccoli capolini posti su esile peduncolo nudo; le squame involucrali sono poste in più serie, le esterne si presentano ovate e intere, le interne, liguliformi, lucide e colorate, sono molto più lunghe dei fiori; foglie biancastro-tomentose, a lamina intera e allungata, basali e cauline; gli acheni sono vellutati con pappo a 5-10 reste sottili poste in un solo rango.
-Xeranthemum cylindraceum Sm. SCOPARELLA
T scap – S-Siber-S-Europ. - VI-VIII – Raro.
Erbacea bianco-tomentosa, alta 20-50 cm, a fusto eretto, con ramificazioni sottili, nude in alto sotto i capolini; foglie lineari (le basali un po’ più larghe) e acute, intere, sessili; capolini piccoli (1-1,5 cm di diametro), terminali, a fiori tubulosi porporini o biancastri, con involucro cilindrico-oblungo a squame esterne tomentose dorsalmente e non mucronate (il simile X. inapertum le ha glabre e mucronate), le interne erette e ravvicinate; acheni lunghi 6-7 mm sormontate da 8-10 reste ineguali (inapertum lunghi 5-5,5 mm e sormontati da 5 reste).
Habitat: incolti erbosi, prati e praterie.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: sotto le Cave di Sofiganano (Vaiano).
NB: la specie congenere Xeranthemum inapertum (L.) Mill. è presente in Calvana, ma ritrovato solo però sul versante di Calenzano del Cantagrilli, ovvero in territorio fiorentino (Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016). vedi foto qui sotto.