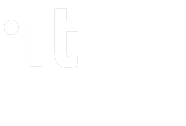Boraginaceae
Famiglia Boraginaceae
Famiglia costituita soprattutto da specie erbacee annuali o perenni (ai tropici anche piante legnose) in numero di circa 2.450, riunite in poco più di 140 generi. Hanno foglie alterne, ruvide-pungenti (per grosse setole), semplici, a margine intero o quasi, prive di stipole; i fiori – ermafroditi e per lo più attinomorfi a 5 sepali, 5 petali (sempre più o meno saldati) e 5 stami – sono quasi sempre riuniti in infiorescenze scorpioidi unilaterali e terminali; il frutto è secco e costituito da 2-4 nucule o drupeole.
Il genere Aegonychon
è costituito da 5 specie erbacee distribuite in Europa e nell’Asia occidentale (2 in Italia). Si differenzia da Buglossoides (a cui appartenevano tutte le sue specie fino a pochi anni fa) soprattutto per il fatto che le sue piante sono perenni invece che annuali; inoltre presentano corolla più lunga (12-20 mm invece che inferiore a 8 mm) e i frutti (mericarpi) quasi rotondi, bianco-lucidi e lisci (invece che piriformi, opachi e almeno un po’ bitorzoluti).
-Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub ERBA PERLA AZZURRA
H scap – S-Europ.-Pont. - IV-VI – Relat. comune.
Erbacea vellutata, a fusto eretto o ascendente, ramificato in alto e foglioso, alta 30-60 cm; le foglie si presentano intere a lamina lanceolata e acuminata, alterne e sessili (attenuate alla base) con diverse nervature salienti; i fiori – pedicellati brevemente, con calice a denti sottili e corolla (14-16 mm) da porporina a blu – sono riuniti in 2-3 cime nella parte terminale dei rami, queste si allungano dopo la fioritura; frutto a mericarpo di 3-4 mm, bianco-avorio e subgloboso.
Habitat: zone marginali erbose di boschi caducifogli e arbusteti, soprattutto su substrato calcareo.
Distribuzione sul territorio:
Calvana: Gestri 2009 (sub Lithospermum purpureo-coeruleum L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
Colline di Montemurlo: Baroni 1897-1908 (sub Lithospermum purpureo-coeruleum L.): Prato al Barone (Somm. herb.); nuovi ritrovamenti: strada bianca dalla Bicchieraia verso la Fattoria di Javello (2023).
Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 (sub Lithospermum purpureo-coeruleum L.) e Biagioli & al. 1999 (sub Erba perla azzurra): AMPIL del Monteferrato.
Montalbano: Baroni 1897-1908 (sub Lithospermum purpureo-coeruleum L.): m. Albano a Pietramarina (Somm. herb.); Gestri & Peruzzi 2013a (sub Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.): Carmignano.
Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.): boschi occidentali anche su gabbri (Patriarchi, Sassi Neri e le Croci) (Prato, Montemurlo).
Il genere Anchusa
conta poco meno di una trentacinquina di specie distribuite in Europa, Africa e Asia (in Italia 9, molte endemiche della Sardegna). Si tratta di piante erbacee che si caratterizzano per avere fiori zigomorfi a calice campanulato con 5 lobi lineari-lanceolati e corolla a 5 segmenti ottusi con tubo ricurvo e con alla fauce 5 squame occludenti e sporgenti; le foglie sono alterne, i fusti eretti o ascendenti.
-Anchusa azurea Mill. BUGLOSSA ITALICA
H scap – Euro-Medit. - IV-VII – Rara.
Erbacea a fusto eretto e ramoso, alta 30-80 cm, irta di setole lunghe 1,5-3 mm, rade e patenti; foglie semplici, lanceolate-acute, le inferiori picciolate e le superiori sessili; fiori a corolla azzurro-violacea, lunga 1 cm o poco più, con tubo inferiore al calice (6-8 mm e alla fruttificazione fino a 15), sepali lungamente triangolari e acuti, pedicello lungo come i sepali e le brattee, squame sporgenti dalla fauce della corolla in filamenti sottili; infiorescenza in cime dense che si allungano fino a 10 cm a maturità; mericarpi eretti e lunghi (6-7 mm) doppiamente che larghi.
Habitat: zone marginali di campi, prati, incolti e strade.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908 (sub A. italica Retz.): Prato (Somm. herb.); Biagioli & al. 1999 (sub Buglossa azzurrea): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub A. italica Retz.); Messeri 1936 (sub A. italica Retz.); Biagioli & al. 2002 (sub A. italica Retz.): campi di Villa Ciabatti (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): Cerreto.
Il genere Borago
conta 5 specie erbacee (annuali o perenni) a distribuzione S-europea, W-asiatica e N-africana (3 in Italia). Si caratterizza, all’interno della Famiglia, per i peduncoli lunghi fino a 3 cm, i fiori con corolla a petali aperti all'esterno, con breve tubo, antere dotate di mucrone e filamenti ad apice appendicolato; le scaglie della fauce sono conniventi, brevi e bidentate; si tratta di piante ispide, il nome infatti deriva probabilmente dal latino “borra”: tessuto grossolano e ruvido.
-Borago officinalis L. BORRAGINE
T scap – Euro-Medit. - I-XII – Abbastanza comune.
Erbacea molto ispida, con fusto eretto e ramoso, alta 20-80 cm, a foglie intere, ovato-lanceolate e dentellate al margine, alterne, picciolate le inferiori, abbraccianti le superiori; i fiori peduncolati, sono reclinati, hanno corolla grande (fino a 2,5 cm di diametro) con tubo subnullo, rotata e di colore azzurro, calice a segmenti sottili; sono riuniti in infiorescenze a ombrello; mericarpi bruni, ottusi, lunghi 7-10 mm.
Habitat: soprattutto in terreni coltivati, zone marginali e ambienti ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2020), presso Gricigliana (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Borragine): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: su terra di riporto...ex-cava di pian di Gello (Prato) e nei campi di C. Pianali (Montemurlo).
- Monte le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: è pianta ritenuta officinale (con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie) e commestibile da lunghissimo tempo, ma ormai da decenni si è scoperto che contiene piccole quantità di alcaloidi pirrolidazinici, tossici a livello epatico, che fanno sconsigliare il suo utilizzo sia terapeutico che alimentare per uso interno (soprattutto da cruda). L’olio di borragine sembra non contenga queste sostanze, ma è controindicato in chi fa uso di anticoagulanti o soffre di emofilia.
Il genere Buglossoides
conta una quindicina di specie distribuite in area euromediterranea (3 in Italia con diverse sottospecie). Si tratta di erbacee annuali che si distingue da Aegonychon per le foglie (intere ed alterne) ad una sola nervatura saliente, la corolla inferiore agli 8 mm, i frutti opachi, verrucosi, di forma trigona o a pera. E’ simile anche al genere Lithospermum da cui si distingue soprattutto per la corolla bianca, blu o porporina con assenza di scaglie alla fauce, sostituite da peli brevi disposti in 5 linee longitudinali ed infine per le infiorescenze solo terminali (in Lithospermum oltre a 2-5 cime terminali le piante ne presentano diverse ascellari).
-Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. subsp. arvensis ERBA-PERLA MINORE
T scap – Euro-Medit. - I-VI – Relat.comune.
Erbacea annuale, a peli appressati, con fusto eretto o ascendente poco ramificato, alta fino a 60 cm; le foglie si presentano semplici, oblungo-lanceolate, un po’ ondulate al margine, con una sola nervatura centrale in rilievo ineriormente; i fiori sono raggruppati in cime allungate, hanno corolla biancastra, lunga 6-9 mm e pubescente all’esterno; mericarpi a maturità di colore bruno e opachi, trigoni e rugoso-tubercolati, lunghi fino a 4 mm.
Habitat: coltivi e ambienti ruderali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub Lithospermum arvense L.): Montepiano (Somm. herb.); nuovi ritrovamenti: dintorni di Migliana (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Fiori 1914 (sub Lithospermum arvense); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908 (sub Lithospermum arvense L.): Prato (Somm. herb.); Biagioli & al. 1999 (sub Erba perla minore): campi di Villa Ciabatti e altrove nei coltivi (Prato, Montemurlo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Lithospermum arvense); Messeri 1936 (sub Lithospermum arvense L.); BGAM22: zone coltivate (Montemurlo, Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Colline sopra Prato: nuovi ritrovamenti: Fornaci sopra Figline (2024) (Prato).
Il genere Cerinthe
conta una decina di specie erbacee distribuite in Europa e Asia occidentale (4 in Italia). Le sue piante si caratterizzano per essere glabre o quasi, con foglie cauline semplici e amplessicauli, la corolla (a 5 lobi) priva di scaglie e peli alla fauce, il calice saldato in basso e con 5 denti, le infiorescenza in cime terminali ramificate e dotate di brattee fogliacee, infine per il frutto costituito da 2 nucule.
-Cerinthe major L. ERBA VAJOLA MAGGIORE
T scap – Steno-Medit. - XII-IV – Rarissima.
Erbacea a fusti ascendenti e assai ramificati, alta 20-70 cm; foglie intere, irsute e dotate di tubercoli bianchi, le inferiori ovato-spatulate e le superiori oblunghe, ottuse in alto e amplessicauli-cordiformi; fiori a corolla giallo-porporino, grande (15-20 x 6-8 mm) più del calice (a denti diversi fra loro, brevi e riflessi), antere violette lunghe circa quanto i filamenti; infiorescenze in cime fogliate; nucule grosse e lisce.
Habitat: incolti erbosi, margini di oliveti, vigne e aree coltivate.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
NB: è specie molto più comune presso la costa in Toscana.
-Cerinthe minor L. subsp. minor ERBA VAJOLA MINORE, SCARLATTINA
(T scap) H bienn – SE-Europ.-Pont. - V-VII – Rarissima.
Erbacea con radice emettente fascetti sterili di foglie e più fusti laterali, caule eretto e ramificato, alta 15-50 cm; foglie glauche, da ellittiche a oblanceolate, abbraccianti, lisce e prive o con pochi tubercoli bianchi, le superiori brevi; fiori a corolla breve (10-12 mm), giallastra a volte con macchie bruno-porporine alla fauce, divisa per metà in 5 lacinie sottili, acuminate ed eretto-conniventi; frutti piccoli (3-4 mm) e nerastri.
La nostra sottospecie si caratterizza per le foglie con macchie biancastre e i segmenti della corolla ad apice ricurvo e di colore giallo (a volte con macchie purpuree alla fauce).
Habitat: incolti e zone marginali erbose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Lazzeri & al. 2018: margine stradale erboso da Sassetta a Montepiano (Vernio); riconferma l’11-09-23: loc. La Cantoniera (Vernio).
Il genere Cynoglossum
conta oltre una sessantina di specie diffuse nelle aree temperate e subtropicali di Asia, Africa, Oceania ed Europa (13 in Italia). Le sue piante (erbacee per lo più bienni o perenni) si caratterizzano per la pubescenza non molto densa (a volte mancante), le foglie lanceolate o oblunghe, le cauline sessili o semiabbraccianti, i fiori – calice diviso profondamente in 5 segmenti uguali, corolla rossa, viola o bluastra (raramente bianca) con tubo breve e con 5 scaglie conniventi alla fauce, stami e stilo inclusi – si riuniscono in infiorescenze a panicolo terminale in genere privo di brattee; frutto caratteristico a 4 mericarpi aculeati su tutta la superficie superiore (che può essere convessa, piana o leggermente concavo e a volte bordata).
-Cynoglossum creticum Mill. LINGUA DI CANE A FIORI VARIEGATI
H bienn – Euro-Medit. - IV-VI – Relat. Comune.
Erbacea tomentosa, a fusto eretto e ramificato, alta 20-80 cm; le foglie, verde-grigiastre e lanceolato-lineari, si riducono di dimensioni verso l’alto; le basali hanno lamina di 2-3 X 8-12 cm; i fiori (corolla con tubo terminante in 5 denti uguali e calice a 5 lobi ottusi - che superano di poco il calice - di colore celestino chiaro con venature blu-violacee o rossastre) sono riuniti in grappoli terminali che si allungano per distensione dell’asse fino a maturità; il frutto è formato da 4 grossi carpelli ricoperti da strutture spinescenti adunche, senza margini ispessiti e con peduncolo (7-9 mm) rivolto in basso.
Habitat: aree incolte e marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: M. Bucciana vers. W, presso Le Barbe, presso il Faggione di Luogomano e verso gli Acquiputoli (2019) (Cantagallo); sopra il Gorandaccio (2022) (Vernio).
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: non ritrovato da Gestri & Lazzeri 2021, ma solo successivamente, da chi scrive (2022), sul terrapieno della cassa di espansione dell'Ombrone (“Piante vascolari” sul sito del comune di P. a Caiano). Stampi 1967 segnala la presenza di C. officinale L., che probabilmente è da ricondurre alla specie in esame.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Lingua di cane a fiori variegati): AMPIL del Monteferrato.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (S): Case Serilli (Vaiano)
-Cynoglossum officinale L. LINGUA DI CANE VELLUTINA
H bienn – Eurasiat. - V-VIII – Rara.
Erbacea pubescente, a fusto eretto, robusto e ramificato in alto, alta 20-60 cm; foglie intere, grigiastre per tomentosità, le inferiori picciolate, ovate e grandi, le superiori minori, lanceolate e semiamplessicauli; i fiori – calice di 6 mm che si allunga a maturità, corolla poco più lunga, purpurea e senza venature – sono riuniti in cime terminali (senza brattee o con poche alla base) inizialmente rotondeggianti, in seguito si allungano e distendono; frutto costituito da carpelli obovati di ca. 6 mm, con aculei centrali e con margine saliente.
Habitat: zone marginali e ruderali, incolti pascolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890: Poggio a Petto; Baroni 1897-1908: sopra Montepiano a Poggio di Petto (Somm. II) (Vernio); Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso il Tabernacolo di Gavigno (2017), sulla strada sopra il lago Verde verso S. Ippolito (2018) (Cantagallo).
- Cascine di Tavola: Stampi 1967, non ritrovato da Gestri & Lazzeri 2021, potrebbe essere stato confuso con la specie precedente.
Il genere Cynoglottis
conta 2 specie erbacee perenni distribuite in Europa e nell'Asia occidentale (1 in Italia). Le piante si presentano da pubescenti a ispide; i fiori - con calice a 5 segmenti interi ed uguali fra loro, corolla rotata a tubo breve (ca. 2 mm), con squame cilate e suborbicolari alla fauce - sono riuniti in cime numerose, ramificate e dotate di brattee; il frutto è secco, diviso in 4 mericarpi a superficie papillosa e con cercine basale. Si distingue dal genere Anchusa (molto vicino morfologicamente) soprattutto per i mericarpi eretti, il calice inciso più profondamente e il breve tubo corollino (inferiore al calice).
?-Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan subsp. barrelieri BUGLOSSA DI BARRELIER
H scap – Orofila NE-Medit. - V-VII – Rarissima o scomparsa.
Erbacea alta 30-60 cm, a fusto eretto e ramoso, con peli appressati; si caratterizza per le foglie ± dentellate o ondulate e le superiori amplessicauli, i fiori piccoli, numerosi e distanziati, riuniti in corimbo terminale; corolla di 5-7 mm, blu a tubo (1-1,5 mm) più corto del lembo e del calice; pedicelli e brattee più brevi del calice (a denti ottusi); frutti nerastri.
Habitat: ambienti freschi e ombrosi di montagna o di collina.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Buglossa di Barrelier): AMPIL del Monteferrato.
NB: è specie dedicata a Barrellier, frate domenicano e florista francese del XVII° sec.
Il genere Echium
conta una sessantina di specie erbacee ed arbustive distribuite in Europa, Macaronesia, N-Africa e Asia occidentale. Le piante si presentano ispide per setole dotate di tubercolo basale, le foglie sono intere, le cauline sessili, i fiori – calice profondamente diviso in 5 lobi ca. uguali, corolla di vario colore, campanulata a 5 lobi irregolari, tubo diritto e fauce priva di squame – sono riuniti in cime scorpioidi bratteate; i frutti sono costituiti da 4 carpelli tubercolati e rugosi di forma ovata o trigona.
NB: Il nome volgare “viperina” delle sue specie è legato al fatto che in passato alcune di esse si ritenevano efficaci contro il morso della vipera.
-Echium italicum L. subsp. italicum VIPERINA MAGGIORE
H bienn – Euro-Medit. - IV-VIII – Comune.
Erbacea ispida a fusto robusto, eretto, alto 30-120 cm; foglie ispide, intere e lanceolate, le basali riunite in una densa rosetta e la cauline di dimensioni inferiori e sessili; i fiori – calice ispido a 5 lobi, corolla imbutiforme, biancastra, rosea o giallastra, stami salienti – sono riuniti in una pannocchia all'apice del fusto da spiciforme a piramidata; frutto a mericarpi tubercolati e di forma quasi triangolare.
Habitat: incolti, zone ruderali, prati.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini (1997); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Sandri & Fantozzi (1895): presso Belvedere a San Giusto sotto Pietramarina (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: siti aridi...anche ofiolitici (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Echium plantagineum L. VIPERINA PIANTAGINEA
T scap/H bienn – Euro-Medit. - III-VII – Rara.
Erbacea a pubescenza soffice, fusto eretto o ascendente con peli emergenti da un piccolo tubercolo, alta 20-60 cm; le foglie basali, ovate e a venature, anche le laterali, evidenti, sono picciolate, disposte in rosetta e lunghe fino a 15 cm, le cauline, ridotte e più sottili, sono sessili-semiabbraccianti; i fiori - corolla lunga 25-30 cm, molto più del calice, di forma a ombrello, a peli radi e di colore inizialmente porporino e poi blu-violaceo, con 2 stami sporgenti - sono disposti in cime ascellari scorpioidi che si allungano a maturità.
Habitat: incolti e campi sabbiosi, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
NB: l'epiteto specifico si riferisce al fatto che le sue foglie ricordano quelle della piantaggine.
PS: sul Montalbano è presente anche in provincia di Pistoia (Monsummano, Serravalle) e Firenze (Vinci).
-Echium vulgare L. VIPERINA COMUNE
H bienn – Europ. - VI-IX – Comune.
Erbacea ispida, a fusto eretto e ramoso, dotato di peli densi e brevi e setole rade e allungate, inserite su un tubercolo rosso-bluastro, alta 20-100 cm; foglie basali lanceolate, senza venature laterali evidenti, picciolate, aderenti al suolo e lunghe fino a 10 cm, le cauline più brevi e sessili; i fiori - abbastanza grandi e a corolla zigomorfa (10-20 cm di lunghezza) di un bel colore blu-violaceo e con il tubo incluso nel calice - sono riuniti in spighe a volte un po’ ramose; dal tubo corollino fuoriescono gli stami (in numero di 4-5) e, più lungamente, lo stilo biforcato.
Habitat: incolti aridi, anche sassosi, oliveti, campi, margini stradali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Caverzano sopra Vernio (Somm. in Parl.); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Montepiano verso il Gasperonee (2018), Fonte del Romito (2019) (Vernio); da Schignano verso Migliana (2023) (Vaiano-Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori (1914); Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Rilievi a ovest di Vaiano: nuovi ritrovamenti: dalla Collina a Schignano (2024).
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al. 1999 (sub Viperina): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub E.v. L. var. pustulatum Coiney); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: comune, anche su serpentino; oss. Mo, Giacò, Pentassuglia 2023 Wikiplantbase#Toscana: base del Monteferrato, a N del parco di Galceti (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: non tutti gli Autori concordano nell'accettare, accanto alla sottospecie nominale, la subsp. pustulatum - caratterizzata dalla presenza sulla pianta di grandi setole inserite su un grosso tubercolo -. Se ce ne accetta l'esistenza, ambedue le sottospecie vanno considerate presenti nel Pratese, in particolare Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Bonnier & Layens si può incontrare sul Monteferrato e probabilmente altrove.
Il genere Heliotropium
conta oltre 250 specie distribuite in Europa e zone tropicali di quasi tutti i continenti (6 in Italia). Si tratta di specie erbacee e arbustive a foglie da lineari a lanceolate, fiori sessili e piccoli – corolla bianca o purpurea, a 5 lobi spesso separati da dentelli, con fauce priva di scaglie e peli, stami e stilo inclusi – riuniti in dense cime omolaterali senza brattee, frutti spesso a 4 mericarpi (a volte da uno soltanto) più o meno rugosi.
-Heliotropium europaeum L. ELIOTROPIO
T scap – Euro-Medit.-Turan. - VI-XI - Comune.
Erbacea tomentosa, a fusto eretto o ascendente, alta fino a 50 cm, odore fetido; ha foglie ellittiche, picciolate, pelose e di color cenerino; i piccoli fiori sessili, a corolla bianca e calice ciliato, profondamente diviso in 5 lobi e persistente, sono strettamente riuniti in cime scorpiodi che si allungano a maturità; frutto di 2 mm è finemente tubercolato.
Habitat: campi, ruderi, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sopra Migliana (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: diffuso, anche su ofioliti (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
Il genere Lithospermum
conta più di 80 specie distribuite in Europa, Asia, Africa e America del Sud e del Nord (1 in Italia). Le piante, erbacee o suffrutici, si presentano a fiori – calice accrescente a lobi profondi, corolla bianca a 5 lobi e con squame rudimentali alla fauce – riuniti in 2-5 cime terminali ed altre ascellari, fogliose; frutto a 4 nucule bianche, lucide e lisce (sembrano delle piccole pietre da cui il nome di derivazione greca: liythos = pietra e sperma = seme).
-Lithospermum officinale L. ERBA PERLA MAGGIORE
H scap – Eurosiber. - V-VII – Molto raro.
Erbacea a fusti robusti, eretti o ascendenti, ramificati e fogliosi, alta 20-80 cm; foglie sessili, lanceolate ed acuminate; fiori a corolla bianca di ca. 4-5 mm, numerosi e riuniti in cime fogliose che si allungano dopo la fioritura; nucule ovoidi biancastre e lucide, lunghe ca. 2,7 mm.
Habitat: boschi e boscaglie fresco-umide, sponde di corsi d'acqua, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: strada sopra Cavarzano verso l'Alpe (2018).
- Calvana: Gestri 2009: presso Rio Fornelli (Cantagallo).
Il genere Myosotis
conta più di 150 specie erbacee, distribuite nelle aree temperate del globo (una ventina in Italia). Si tratta di piante per lo più gracili e vellutate, con foglie alterne ad “orecchio di topo” (oblunghe-lanceolate), le cauline sessili, le basali picciolate; i fiori – calice campanulato a 5 lobi più o meno profondi, corolla azzurro-bluastra, giallastra, rosea o bianca, rotata o infundibuliforme e a tubo più o meno lungo – sono riuniti in cime che si allungano dopo la fioritura e si presentano generalmente prive di brattee; i frutti sono formati da 4 nucule ovoidi, lisce e lucide, spesso con un orlo e con, alla base, una cicatrice di inserzione più o meno piccola e appendicolata.
PS: alcune delle specie seguenti sono assai simili fra di loro e rimane qualche dubbio sull'esattezza di alcune identificazioni! Anche gli specialisti, nel caso di alcune entità, accennano ad evidenti difficoltà diagnostiche non ancora completamente risolte.
NB: il nome deriva dal greco: mus = topo e otis = orecchio, allusione all'aspetto delle foglie.
-Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis NONTISCORDARDIME COMUNE
T scap – Europ.-W-Asiat. - III-VII – Comune.
Erbacea alta fino a 40 cm, che si caratterizza per i peduncoli fruttiferi lunghi fino a 5-10 mm, per il calice (generalmente superiore a 3 mm) che si presenta a lobi chiusi dopo la fioritura e coperto di due tipi di peli: in basso uncinati, in alto dritti; infine per le nucule nere e con un orlo evidente.
Habitat: prati, campi, incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Migliana a N della chiesa, strada bianca da Migliana a Le Cavallaie (2018) (Cantagallo); sopra il Gorandaccio, da Carmignanello a Gricigliana (2023) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra la Bicchieraia (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Nontiscordardime minore): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: soprattutto in aree marginali, ma anche su sfatticcio o in anfratti rocciosi ofiolitici.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Myosotis decumbens Host subsp. florentina Grau NONTISCORDARDIME FIORENTINO
H scap – Endemismo italiano (Italia centrale e Basilicata) – VI-VIII – Relat. rara.
Erbacea perenne – questo è uno dei motivi che la distingue da M. sylvatica (specie molto simile) che è annua – a rizoma spesso strisciante, fusto ascendente, alta 20-50 cm; ha il calice più breve del tubo corollino e coperto di densi e robusti peli uncinati, lunghi 0,4 mm; si caratterizza inoltre per i peduncoli fiorali lunghi 2-3,5 mm, i fiori con corolla azzurra più o meno chiara e del diametro di ca. 7 mm; nucule lunghe 2 mm. La nostra sottospecie si contraddistingue per la lunghezza di 7-8 mm del calice a maturità (superato di poco dal tubo corollino), e per i segmenti assai stretti.
Habitat: boschi umidi e presso i corsi d'acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Cantagallo e Vernio; nuovi ritrovamenti: passo di S. Giuseppe, sopra Montecuccoli, da Cavarzano all'Alpe (2018) (Vernio); sotto Le Scalette (2017), a W tabernacolo di Gavigno (2018), CAI 32 sopra Acquiputoli (2022) (Cantagallo).
- Calvana: campione d'erbario di Martelli 22 Mai 1892 (det. Grau): Valibona (Calvana di Vaiano); Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; Arrigoni 2019.
-Myosotis discolor Pers. NONTISCORDARDIME CANGIANTE
T scap – Medit.-Atlant. - IV-VI – Raro.
Erbacea gracile a fusto prostrato, ascendente o eretto, alta 5-30 cm; presenta peli uncinati riflessi sul calice, mentre sull'asse dell'infiorescenza solo peli appressati, la corolla ha il diametro di ca. 4 mm e il tubo, a fine fioritura, è lungo 2 volte il calice; somiglia a M. arvensis, ma le foglie basali sono lanceolate-ottuse e con soli peli patenti, inoltre – caratteristica peculiare che da anche il nome alla pianta – i fiori all'inizio dell'antesi sono biancastro-giallastri, virano poi al roseo, al violaceo o all'azzurro.
Habitat: prati e pendii umidi, sabbiosi soprattutto silicei.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al. 2005: Le Barbe nella riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Ricceri 2006: Appennino.
- Colline di Montemurlo: Ricceri 2006 (substrato siliceo).
- Montalbano: Ricceri 2006 (substrato siliceo).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: osservati nei campi di Villa Ciabatti (Prato), e anche all'ex-cava Guarino (Montemurlo) su terra di riporto.
-Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. NONTISCORDARDIME CESPITOSO
H bienn/T scap – Europ.-Subatlant. - VI-VIII – Rarissimo.
Erbacea alta 20-50 cm, a fusto eretto o ascendente con peli appressati in basso; le foglie superiori presentano peluria quasi appressata sulla pagina superiore, i peli del calice (precocemente caduco dopo la fioritura) sono ca. della stessa lunghezza, dritti, setolosi e rivolti verso l'alto, i sepali sono più lunghi che larghi e profondi al massimo la metà del calice, nella zona di adesione del frutto è presente un ingrossamento spugnoso. La nostra sottospecie ha fusto eretto, peduncoli che non superano 1 cm e sono, alla fruttificazione (almeno quelli in basso), più lungi del calice, le nucule sono, al più, lunghe 2 mm. Va distinto dal simile M. sicula che presenta le nucule (brune) lunghe al massimo 1 mm, i peduncoli circa della stessa misura del calice, che mostra un tubo lungo il doppio dei segmenti.
Habitat: zone fresco-umide, soprattutto su substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale.
- Cascine di Tavola: nuovi ritrovamenti (2019 e revisionato nel 2024).
NB: la sottospecie nominale è ritenuta attualmente presente solo in N-America.
-Myosotis nemorosa Besser NONTISCORDARDIME A PELI RIFLESSI
H bienn – Eurasiat. - VI-VIII – Raro.
Erbacea stolonifera, alta 20-70 cm, con fusto a peli riflessi o subglabro, ascendente o eretto; le foglie inferiori presentano sulla faccia dorsale peli lunghi 0,6-1 mm e riflessi verso la base; calice (non più lungo di 5 mm) a peli simili fra loro, non uncinati, setolosi e rivolti verso l'alto, esso non è precocemente caduco ed i suoi segmenti (ca. tanto lunghi che larghi) sono più brevi del tubo; corolla azzurro-chiara con lembo del diametro massimo di 6 mm; nucule lunghe fino a 1,8 mm. Molto simile a M. scorpioides che è perenne, presenta i peli sulla faccia inferiore delle foglie basali lunghi 0,3 mm e rivolti verso l'alto, la parte superiore del fusto ha peli patenti, il calice è lungo alla maturità fino a 6 mm e presenta brevi lobi (massimo 2/5 di profondità).
Habitat: boschi e prati fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002: Fonte Acerelli, da Casina le Barbe a Vespaio (Cantagallo); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: bosco misto di castagno da Fossato verso Chiapporato (2020), dall'Acqua alla Rasa a margine del bosco o in radure (2024) (Cantagallo); M. Scoperta a margine del sentiero CAI 00 che scende all'Alpe (2024) (Vernio).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
-Myosotis ramosissima Rochel NONTISCORDARDIME RAMOSISSIMO
T scap – Europ.-W-Asiat. - III-VI – Comune.
Erbacea vellutata-irsuta, alta 5-40 cm, con fusto per lo più eretto e gracile; si caratterizza per i peduncoli fruttiferi lunghi fino a 1-4 mm (più brevi del calice), la corolla azzurra e del diametro inferiore a 2 mm, il calice, superiore al tubo corollino e che si presenta a lobi profondi fino alla metà, non chiusi dopo la fioritura e coperto di due tipi di peli: in basso uncinati e riflessi, in alto dritti; inoltre per la nucule brune, lunghe 1-2 mm e senza orlo evidente.
Habitat: incolti erbosi, zone marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2017), Cantagallo e dintorni, L. Verde, Migliana, Terrabianca (2018), presso Gricigliana (2023) (Cantagallo); Alpe Cavarzano (2019) (Vernio).
- Bargo di P. a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914 (sub M. arvensis var. collina); Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: verso La Rocca, sopra La Bicchieraia. (2024)
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub M. arvensis var. collina).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub M.r. Rochel subsp. ramosissima) (C/S).
-Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides NONTISCORDARDIME PALUSTRE
H scap – Europ.-W-Asiat. - VI-IX – Non molto comune.
Erbacea alta 15-50 cm o più, a fusto per lo più ascendente e radicante, con peli appressati, rivolti in alto superiormente e patenti in basso, che si caratterizza per i peduncoli fruttiferi lunghi 6-10 mm, il calice è coperto di soli peli dritti e appressati, i lobi profondi circa un terzo sono aperti dopo la fioritura; la corolla appare azzurro-chiara di 5-8 mm di diametro, le foglie sono lanceolato-ovate (larghe fino a 1-1,5 cm) e sessili-attenuate, con la faccia inferiore delle basali con peli (tutti o quasi) antrorsi.
Habitat: ambienti umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1980: Montepiano (Somm. herb.); Arrigoni & al. 2002 (sub M. palustris (L.) Hill.): presso il ruscello alle Barbe; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Terrabianca sotto le Scalette (2018), CAI 64 sopra Gavigno, presso F. Acerelli (2019), dall'Acqua alla Rasa (2024) (Cantagallo); sopra Badia (2014), CAI 16 vers. S.Ippolito, Alpe Cavarzano (2018) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub M. nemorosa Besser) e Gestri & Peruzzi 2016: zona il Pozzino (Vaiano).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Nontiscordardimé palustre)
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub M. palustris (L.) Hill. var. strigulosa Rchb. e var. pseudocespitosa Fiori); Biagioli & al. 2002 non ritrovato.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b: vers. Est.
- Pianura: Caruel 1860-64 (sub M. palustris Lam.): P. a Caiano.
-Myosotis sicula Guss. NONTOSCORDARDIME SICILIANO
T scap (H. bienn) – N-Medit. - IV-VII – Raro.
Erbacea a fusto per lo più prostrato, glabra o a peli appressati, alta 20-50 cm; il calice presenta peli dritti del medesimo aspetto e lobi (più lunghi che larghi) lunghi quanto o meno della metà del tubo; le foglie basali larghe da 6 a 8 mm e per lo più scomparse all'antesi; il peduncolo (di 5-7 mm e spesso ricurvo) è a maturità generalmente lungo come il calice (4-6 mm e presto caduco); corolla a lembo concavo (blu chiaro o bianco) e del diametro di 2-4 mm; cime non fogliose; nucule inferiori al mm. Ricorda M. scorpioides che però è perenne, ha foglie larghe più di 1 cm, i peduncoli lunghi 6-10 mm, il calice 2,5-4 mm a fruttificazione con lacinie lunghe al max 2/5.
Habitat: prati e schiarite umide.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Gavigno al Tabernacolo (2018), L'Acqua, Spuntoni sotto le Cavallaie (2024) (Cantagallo); sopra Risubbiani e P. Crocetta (2019) (Vernio).
NB: sebbene raro, è presente anche sul Montalbano, ma solo nella provincia di Pistoia (Gestri & Peruzzi 2013a)!
-Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica NONTISCORDARDIME DEI BOSCHI
H scap (H bienn) – Paleotemp. - IV-IX – Raro, ma a volte abbondante nei luoghi di crescita.
Erbacea alta 20-50, a fusto eretto o ascendente molto ramoso e foglioso, gracile con peli patenti (nell'infiorescenza appressati); foglie picciolate le basali e sessili le cauline; il calice (arrotondato alla base) presenta sparsi peli uncinati, è caduco e i denti sono sottili e aperti a maturità; la corolla (larga 6-10 mm) è di colore azzurro (abbastanza chiaro) o più raramente rosa con scaglie gialle alla fauce; l'infiorescenza non è bratteata e si allunga in maniera sinuosa; peduncoli di 3-5 mm; nucule acute di 1,4-1,6 mm.
Habitat: nemorale e di prati pingui.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagalo; Venturi 2006: Limentra orientale; oss. Pinzani 2019 Wikiplantbase#Toscana: bosco presso Cantagallo; nuovi ritrovamenti: verso Ponte a Rigoli, da Migliana verso le Cavallaie (2019); sopra L'Acqua (2024) (Cantagallo); sopra Montepiano verso il Gasperone; da S.Giuseppe a Montepiano (2019) (Vernio);
- Calvana: segnalato da Gestri 2009 per il territorio di Vaiano e Cantagallo ed invece per Gestri & Peruzzi 2016 da riferire a M. decumbens Host subsp. florentina Grau. In realtà sembra presente anche in Calvana, sebbene raro (boscaglie del M. Maggiore, Vaiano).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: crinale presso Le Cavallaie numerose colonie di piante nel sottobosco (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Nontiscordardimé dei boschi): AMPIL del Monteferrato.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): versante Sud.
Il genere Phacelia
appartiene alla sottofamiglia Hydrophylloideae (per l'ovario uniloculare e il frutto capsulare) ed è distribuito soprattutto in America settentrionale e meridionale, con un numero di specie che si aggira sulle 200. Si tratta piante erbacee perenni o annuali, con foglie pennatosette, fiori a corolla azzurro-violacea con ovario uniloculare e pistillo a stilo doppio o profondamente bipartito (circa fino a metà); frutto a capsula.
-Phacelia tanacetifolia Bentham FACELIA
T scap – Occasionale (altrove naturalizzata) di orig. N-Americ. - V-IX – Rara.
Erbacea tomentoso-ispida a fusto eretto, alta 20-70 cm, ramificato in alto; ha foglie alterne, amplassicauli, verde scuro, imparipennate a segmenti dentati (simili a quelle del tanaceto volgare, da cui il nome); i fiori - brevemente pedicellati, a corolla imbutiforme, color lavanda e del diametro di 6-7 mm, con stili sporgenti - sono riuniti in dense cime terminali.
Habitat: si incontra spesso in olivete e campi per il suo diffuso utilizzo come pianta da sovescio (è coltivata anche a fini ornamentali).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: presso Fabio (Vaiano); Arrigoni & Vieci 2011: confermata la presenza nel 2023.
- Montalbano: nuovi ritrovamenti: Gestri 2023a: vigneto fra le Barche e Seano (Carmignano).
Il genere Pulmonaria
conta una quindicina di specie erbacee perenni (e alcuni ibridi) distribuiti nella aree temperate europee e asiatiche (5 in Italia). Si tratta di piante con foglie basali che si sviluppano dopo l'antesi (alcune dotate di chiazze più o meno chiare e grandi); fiori con corolla imbutiforme, priva di scaglie alla fauce, sostituite da 5 ciuffi di peli, rosea, blu, o violacea, con tubo ben delimitato dal lembo, calice a segmenti profondi molto più della metà; infiorescenze riunite in cime dotate di brattee; frutto a nucula.
-Pulmonaria hirta L. POLMONARIA CHIAZZATA
G rhiz – Specie subendemica (Italia nordoccidentale e Francia sudorientale) – III-VI – Relat. comune.
Erbacea densamente pelosa, a radice rizomatosa, alta 20-30 cm, con foglie ovato-lanceolate, verdi, spesso a chiazze più chiare confluenti o non, le basali ca. della stessa misura del fusto e con lungo picciolo scanalato ed alato, le cauline si presentano più piccole e sessili; i fiori – a corolla infundibuliforme a 5 petali, inizialmente di colore rosato che poi vira al porpora o al viola, calice a lunghi segmenti che superano il tubo corollino – sono riuniti in dense cime che si allungano nella maturazione; nucule lisce e compresse, lunghe ca. 4 mm.
Habitat: margini boschivi, zone marginali di prati e incolti, spesso almeno ad un altitudine di bassa collina.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Ricceri 2006 (sub P. picta Rouy); Venturi 2006 (sub P. picta Rouy): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Fonte di Canapale (2017), Alpe di Cavarzano e sopra (2018), strada da Cavarzano all'Alpe (2019) (Cantagallo); da Montecuccoli alla Dogana (2018), Gorandaccio (2019) (Vernio).
- Calvana: Ricceri 2006 (sub P. picta Rouy); Gestri 2009 (sub P. picta Rouy) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub P. h. L. subsp. hirta): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Polmonaria chiazzata): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub P. h. L. subsp. hirta): Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub P. apennina Cristof. & Puppi): localizzata in pochi siti del versante orientale (Pianali, Patriarchi) (Montemurlo).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub P. h. L. subsp. hirta) (S).
NB: questa specie, fino a poco tempo fa, era stata suddivisa in almeno tre entità distinte adesso confluite sotto la stessa denominazione.
Il genere Symphytum
conta ca. 35 specie distribuite in Europa, Siberia e Asia occidentale, Iran (8 in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni e solitamente ispide; foglie per lo più ovate e grandi, le cauline più o meno decorrenti; i fiori – a calice accrescentesi e diviso profondamente in 5 segmenti uguali fra loro; a corolla con tubo cilindrico lungo e lembo campanulato a 5 brevi denti, di colorazione variabile, munita alla fauce di 5 scaglie lineari e papillose; le antere sono incluse e intercalate alle scaglie, stilo sporgente – sono riuniti in brevi cime terminali prive di brattee; nucule erette, di forma ovata e più o meno verrucoso-rugose.
-Symphytum bulbosum K.F. Schimp. CONSOLIDA MINORE
G rhiz – SE-Europ. - III-IV – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto, non alato, radice rizomatosa sottile che produce tubercoli più o meno globosi distanziati fra loro, alta 15-40 cm; foglie inferiori e medie ovato-lanceolate e picciolate, le superiori minori, subsessili e poco o non decorrenti; i fiori presentano una corolla giallo pallida, con lobi eretto-patenti, lunga 8-12 mm, dotata alla fauce di scaglie di 5-9 mm che fuoriescono dal tubo per 1-4 mm; nucule verrucose.
Habitat: boschi freschi, incolti erbosi, zone marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2019) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub S. b. K.F. Schimp. subsp. bulbosum): Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sentiero dei Patriarchi (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
NB: presumibilmente più diffuso di c.s.
-Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A.Kern.) Nyman CONSOLIDA FEMMINA
G rhiz – SE-Europ. (sub-Pontica) – III-IV – Relat. comune.
Erbacea a fusto eretto in parte alato e rizoma robusto nodoso-tubercoloso nella zone del colletto, alta 20-60 cm; foglie ovato-lanceolate, le inferiori picciolate e scomparse alla fioritura, le medie brevemente decorrenti sul fusto; i fiori - a corolla giallo-pallida, lunga tre volte il calice (fino a 20 mm), lobi ricurvati all'esterno, con scaglie triangolari-lanceolate incluse alla fauce, stilo sporgente – sono riuniti in dense cime; nucule finemente tubercolate. La nostra sottospecie (quella presente in Italia) è più gracile della nominale, con un numero inferiore di fiori, inoltre la radice è un po' più sottile, le foglie cauline in numero di 3-7 (la nominale 6-12) e squame un po' più larghe e triangolari.
Habitat: boschi e ambienti fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub S. t. L.): Montepiano (Somm. herb.); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo (sub S. t. L.); Venturi 2006 (sub S. t. L.): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sentiero Cai 38 verso la Rasa, sopra il Fabbro, da Fossato al Tabernacolo di Gavigno (sopra fonte) (2018) (Cantagallo); dall'Alpe verso la Scoperta (2018), Montepiano, Badia; Risubbiani (2019), da Fabbro verso Migliana (2020) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 (sub S. t. L.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Consolida femmina): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub S.t. L. subsp. nodosum (Schur) Soò): solo sulla sponda del Bardena.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
PS: presente anche altrove.