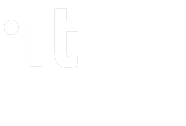Caryophyllaceae
FAMIGLIA CARYOPHYLLACEAE
Ricca ed interessante Famiglia formata da oltre 2600 specie riunite in oltre 80 generi, che abita prevalentemente la zona olartica centrata sul mediterraneo e la regione irano-turanica. Generalmente si tratta di piante erbacee (raramente suffrutici) che presentano foglie opposte (più raramente alterne o verticillate); i fiori per lo più hanno il calice tubuloso a 5 lobi e la corolla a 5 petali dotati di una, più o meno lunga, unghia basale e spesso di scaglie alla fauce; per lo più gli stami sono 10 e gli stili 3; il frutto è una capsula a tre logge con numerosi semi (raramente una bacca). In base all’aspetto del fiore e alla presenza o assenza di stipole si riconoscono tre sotto-famiglie: Alsinoideae (a sepali divisi), Silenoideae (a sepali saldati) e Paronychioideaea (con foglie dotate di stipole e fiori poco evidenti).
PS: di questa Famiglia la pianta più conosciuta è il garofano, coltivato in tutto il mondo come fiore reciso o pianta da giardino.
Il genere Agrostemma
conta due specie di area paleotemperata (1 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali, appartenenti alla sottofamiglia Silenoideae (sepali saldati fra loro e foglie senza stipole) e caratterizzate dai fiori a 5 stili, calice fogliaceo con 10 nervi e sepali dotati di appendici sottili superanti i petali (che sono privi di scaglie alla congiunzione lembo-unghia); frutto a capsula terminante in 5 denti.
?-Agrostemma githago L. GITTAIONE
T scap – Archeofita Europ.-Centrosib. - V-VI – Presenza incostante (compare quando vengono utilizzati semi, soprattutto di frumento, “inquinati”).
Erbacea pubescente, a fusto eretto, semplice o ramificato, alta 20-100 cm; le foglie (lunghe 5-8 cm) lineari-lanceolate sono opposte e sessili; i grandi fiori (3-5 cm ca. di diametro) si trovano isolati all'apice del fusto: corolla a 5 petali roseo-violacei e calice fogliaceo a lungo tubo che si prolunga in 5 appendici sottili superanti i petali; il frutto, una capsula ellissoidale, è lungo 3-4 cm e contiene numerosi semi nerastri, molto velenosi (contengono, in quantità assai superiori al resto della pianta, gittagina, un glucoside altamente tossico).
Habitat: campi di frumento, zona marginali alle colture.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Ricceri 2002: Vaiano; Gestri 2009: Vaiano; non ritrovato in Gestri & Peruzzi 2016.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Gittaione): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Ricceri 2002: Carmignano e S.Martino in campo, campi di cereali nei dintorni del paese; Ricceri 2009: Carmignano.
Il genere Arenaria
conta circa 150 specie distribuite nell'emisfero settentrionale, S-America e Africa nord-orientale (13 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni (a volte a fusto lignificato in basso) appartenenti alla sottofamiglia delle Alsinoideae (sepali divisi e foglie prive di stipole); sono caratterizzate da fiori a 5 petali evidenti, 3-4 o 5 stili, capsula deiscente con peduncoli eretti e con un numero di denti doppio rispetto agli stili; semi senza strofiolo.
-Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. ARENARIA A RAMI CORTI
T scap – Paleotemp. - III-X – Comune.
Erbacea a fusto eretto e ramoso, alta fino a una ventina di cm; foglie opposte, ovate ed acute, lunghe 2-8 mm; fiori piccoli, a 5 petali bianchi, riuniti in infiorescenze a brevi ramificazioni e cime dicotome; calice di 2-3 mm, capsula liscia, conico-cilindrica, ovvero poco dilatata in basso, facilmente compressibile fra le dita; semi di 0,3-0,5 mm. E' più termofila di A. serpyllifolia (la specie successiva).
Habitat: prati, radure ed incolti sassosi e aridi dalla pianura alla bassa montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: letto del Bardena a Galcetello (2024) (Prato).
-Arenaria serpyllifolia L. ARENARIA A FOGLIE DI TIMO
T scap – Subcosmop. - III-X – Abbastanza comune.
Erbacea simile ad A. leptoclados, si distingue soprattutto per il calice dei fiorellini più lungo 3-4 mm, la capsula conica e rigonfia in basso, coriacea (non si lascia comprimere facilmente fra le dita), precocemente opaca e i semi di 0,5-0,7 mm.
Habitat: incolti e campi, ambienti ruderali e coltivi fino a 1800 m slm.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Grigliana (2024) (Cantagallo); dall'Alpe verso il Tabernacolo di Gavigno (2024) (Vernio-Cantagallo); da Montepiano al Gasperone e oltre (2024) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1947; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: M. Buriano (Prato).
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908: Prato (Somm. herb.); Biagioli & al. 1999 (sub Arenaria a foglie di serpillo): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Poggio a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub A. s. L. var tenuior M. et K.); Biagioli 6 al. 2002: su sfatticcio e ghiaie di serpentino.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C).
Il genere Atocion
conta 5 specie a distribuzione euro-siberiana (2 in Italia). Erbacee appartenenti alla sottofamiglia delle Alsinoideae (sepali divisi e foglie prive di stipole), caratterizzate dall'indumento del fusto (almeno in basso) e delle foglie glabro e glauco, dai fiori con calice a 10 nervature e con 3 stili, dal frutto a capsula deiscente priva di papille e con 6 denti. Molto simile al genere Silene (di cui ha fatto parte fino a qualche ann fa) dal quale si distingue per le foglie e il fusto glabri e glauchi e per i denti della capsula inferiori a 1,5 mm di lunghezza.
-Atocion armeria (L.) Raf. SILENE A MAZZETTI
T scap (H bienn) – C-Europ. - V-VI – Abbastanza rara.
Erbacea glabra e glauca, con radice a fittone e fusto eretto semplice o poco ramoso superiormente, alta da 20 a 70 cm; foglie opposte, amplessicauli e di forma ovato-lanceolata e acute in alto; i fiori – calice allungato e ristretto all'apice dove si continua in 5 brevi dentelli ottusi, corolla a petali roseo-purpurei (rar. bianchi) lunghi fino a 2 cm e con alla fauce una serie di scaglie allungate e concolori – sono riuniti in corimbi dicotomi; frutto a capsula oblunga (ca. 6 mm) lunga ca. come il carpoforo e glabra.
Habitat: incolti e radure sassose (da noi si comporta da serpentinofita preferenziale e calcifuga).
Distribuzione sul territorio:
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra la Fattoria di Javello (2010).
- Montalbano: Sandri & Fantozzi 1987 e Baroni 1897-1908 (sub Silene armeria L.): Pietramarina di M. Albano (Carmignano); non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2013a (sub Silene armeria L.).
- Monteferrato: Caruel 1860-64 (sub Silene armeria L.): al M.Ferrato (Parl.); Parlatore 1892; Fiori 1914 (sub Silene armeria); Messeri 1936 (sub Silene armeria L.): oltre alla forma tipo segnala S. a. f. angustifolia Rchb. non reperita da Fiori; Biagioli & al. 1999 (sub Silene a mazzetti); Biagioli & al. 2002 (sub Silene armeria L.): soprattutto su pietraie serpentinose.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: ai Renai su diaspro.
Il genere Cerastium
conta un centinaio di specie distribuite in quasi tutto il globo (più di una trentina presenti in Italia). Si tratta di piante erbacee appartenenti alla sottofamiglia delle Alsinoideae (sepali divisi e foglie prive di stipole) caratterizzate da fiori piccoli a petali assenti o presenti (nel caso in numero di 5, da bifidi a bisetti), (3-)5 stili, 10 stami e capsula subcilindrica, lunga 2 volte il calice, a denti in numero doppio rispetto agli stili. Infiorescenza per lo più a cime dicotome; foglie intere, opposte e sessili.
-Cerastium arvense L. subsp. arvense PEVERINA A FOGLIE STRETTE
H scap/Ch suffr – Subcosmop. - V-VIII – Comunissimo.
Erbacea di 10-50 cm, ± pubescente (ma non tomentosa!), spesso ghiandolosa in alto, a fusti ascendenti o eretti e ramificati; foglie opposte, le inferiori spatolate e le superiori lanceolate fino a lineari (spesso con fascetti ascellari di foglioline); fiori – petali bianchi bifidi, lunghi (1,5-2,5 mm) il doppio o più dei sepali, su peduncoli eretti spesso anche alla fruttificazione, brattee ± scariose al margine – riuniti in cime lasse di 3-7; frutto a capsula di 7-10 mm, cilindrica e spesso un po' ricurva all'apice. Almeno in alcune zone della Toscana sembra predominante una varietà (etruscum Lacaita) assai elevata in altezza e caratterizzata dalle brattee strettamente scariose in alto, dalle foglie oblungo-lanceolate e dalla presenza di peli brevi (meno di 0,6 mm), appressati o a volte riflessi sul fusto.
Habitat: ambienti marginali di boschi e sentieri, incolti aridi, zone pietrose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano (Somm. herb.); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Alpe di Cavarzano (2018) (Vernio); dall'Acqua alla Rasa, Grigliana (2024) (Cantagallo); da Migliana a Le Cavallaie (2024) (Cantagallo, Montemurlo).
- Calvana: Fiori 1914 (sub C. a. var. etruscum); Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: I Bifolchi (Prato).
- Colline di Prato: nuovi ritrovamenti: sopra “Le Svolte” di Figline e alla Collina (2024) (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub C. a. L. subsp. arvense var. etruscum Lacaiata): Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ambienti ruderali e bordi stradali.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub C. a. L. subsp. arvense var. etruscum Fiori) (C/S).
NB: le piante presenti sull'Appennino pratese oltre i 1000 m hanno la pagina superiore delle foglie glabra o quasi (exs. 14-4-24) (soprattutto se confrontate con le piante di pianura) potrebbe trattarsi delle subsp. strictum (W.D.J.Koch) Gremli, oppure di un adattamento ambientale (salendo in altitudine le foglie tendono a divenire glabrescenti?).
-Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Sl PEVERINA A PETALI BREVI
T scap – Euro-Medit. (subpont.) - III-V – Poco comune.
Erbacea alta 5-30 cm, coperta di peli semplici patenti, a fusto eretto o ascendente e priva di rigetti sterili; foglie opposte a lamina da ellittica ad ovata, lunga fino a quasi 1,5 cm, acuta; fiori – sepali di 4-5 mm, lanceolati, acuti e pelosi fino in alto, petali bilobi o bifidi, lunghi come o più brevi dei sepali e ad unghia ciliata, filamenti pure ciliati, peduncoli alla fruttificazione (8-15 mm) ricurvi a 45° a 90° al di sotto della capsula e 2-3 volte più lunghi dei sepali e delle brattee (erbacee e senza bordo membranoso) – riuniti in cime pauciflore e lasse; capsula cilindrica di 6-8 mm, lunga fino a 2 volte il calice.
NB: le piante del Pratese sembrano appartenere (almeno in parte) alla sottospecie tenoreanum (Ser.) Soó, che è caratterizzata soprattutto dalla presenza di peli semplici ripiegati in basso negli internodi inferiori del fusto e dai peduncoli lunghi 5-17 mm e con peli eretto-appressati.
Habitat: praterie e ambienti rocciosi o sabbiosi aridi (spesso su calcare).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009: Prato, Vaiano, Cantagallo; Ricceri 2010; Gestri & Peruzzi 2016 (sub C. b. Desp. ex Pers. subsp. tenoreanum (Ser.) Soó): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub C. b. Desp. ex Pers. subsp. tenoreanum (Ser.) Soó): Carmignano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub C. b. Desp. ex Pers. subsp. tenoreanum (Ser.) Soó) (S).
-Cerastium glomeratum Thuill. PEVERINA DEI CAMPI
T scap – Subcosmop. – I-XII – Comunissimo.
Erbacea assai pubescente a peli patenti, fusticini ascendenti o eretti e ramificati dicotomicamente, alta 5-30 cm; foglie opposte, sessili, con lamina ovata e ottusa in alto; è caratterizzata dai fiori – petali ciliati all'unghia, di dimensioni circa uguali ai sepali (lanceolato-acuti e pelosi fino alla sommità), così come il pedicello del frutto (eretto) - raggruppati in glomeruli serrati per la brevità dei pedicelli (1-3 mm); brattee erbacee; capsula dritta e cilindrica, lunga 7-8 mm superante il calice.
Habitat: ambienti incolti ed aree coltivate.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale;
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline di Prato: nuovi ritrovamenti: sopra “Le Svolte” di Figline (2024) (Prato).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: strada bianca dalla Bicchieraia verso Reticaia (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Peverina dei campi): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano e P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone ruderali e bordi stradali.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Cerastium glutinosum Fr. PEVERINA GLUTINOSA
T scap – Euro-Medit.-Subpont. – III-VI – Non comune.
Erbacea a fusti ascendenti o eretti, vellutato-ghiandolosa, alta da 5 a 25 cm, molto simile a C. pumilum Curt. (vedi), dal quale si distingue essenzialmente per le brattee con faccia superiore glabra e ad apice membranoso e per i petali inferiori, uguali o poco maggiori dei sepali) e bilobati al max. fino a ¼ della lunghezza totale; inoltre gli stili sono inferiori al mm e la parte inferiore del fusto è priva di peli ghiandolari.
Habitat: incolti, prati aridi, aree ruderali aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Sommier 1890: Poggio a Petto (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Montalbano: Caruel 1860-64: tra Signa e Poggio a Cajano; per Baroni 1897-1908: deve escludersi la località di Firenze citata nel "Prodromo" per questa pianta, giacchè si riferisce al C. campanulatum Viv. (cfr. Tanf. in Parl. Fl. ital. vol. IX, p. 473) (ovvero al C. ligusticum Viv.); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936; Biagioli & al. 2002 (sub C. pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fries) Jalas): suoli aridi, anche sulle pietraie serpentinose.
-Cerastium holosteoides Fr. PEVERINA DEI PRATI
H scap – Cosmop. - IV-X – Relat. comune.
Erbacea a fusto ascendente esile, alta 10-40 cm, con peli diritti e priva (quasi sempre) di ghiandole, che si caratterizza, nel genere, per essere pianta perenne con presenza di rigetti sterili e infiorescenze abbastanza ricche in forma di racemi terminali dicotomi; ha petali spatolati, lunghi (3-7 mm) da poco più a poco meno dei sepali (4-6 mm) e capsula di ca. 1 cm; inoltre può contemporaneamente presentare fiori e frutti a vario stadio di maturazione nella stessa infiorescenza.
Habitat: incolti, ambienti, ruderali, prati, radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005 (sub C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet): presso le Barbe, riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso Gavigno (2019), Grigliana (2024) (Cantagallo); strada bianca da Migliana a Le Cavallaie, da Montepiano a P. di Petto (2018), Alpe di Cavarzano (2020), da Badia a S. Stefano (2014) (Vernio).
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Gestri Lazzeri 2021.
- Colline di Montemurlo: nuovi reperimenti: strada bianca dalla Bicchieraia verso Reticaia, Pian dei Massi (2024).
- Colline di Prato: nuovi ritrovamenti: sopra “Le Svolte” di Figline (2024) (Prato).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C).
-Cerastium ligusticum Viv. PEVERINA LIGURE
T scap – W-Medit. - I-VI – Relat. comune.
Erbacea pelosa e ghiandolosa, a fusti eretti (lungamente nudi in alto e a volte con ramificazioni basali prostrato-ascendenti), alta 5-30 cm; foglie lunghe 12-27 mm da subspatolate a lanceolate; le caratteristiche principali sono rappresentate dai petali glabri, bifidi con profondità di 1/3 della lunghezza totale e soprattutto lunghi più di una volta e mezzo i sepali (questi di 3-8 mm), il sepalo più esterno ha punta glabra e scariosa , inoltre le brattee si presentano solo strettamente membranose in alto; la capsula è lunga fino a 8 mm.
Habitat: incolti, aree ruderali, radure, prati.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub C. campanulatum); Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Peverina ligure): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub C. campanulatum); Messeri 1936 (sub C.campanulatum Viv. e C. campanulatum Viv. f. exile Messeri); Biagioli & al. 2002.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Cerastium pumilum Curtis PEVERINA MINORE
T scap – Euro-Medit. - III-V – Relat. rara.
Erbacea ghiandolosa e pubescente (vischiosa) a fusti eretti o ascendenti, alta 5-25 cm; foglie lunghe fino a 1,5 cm, ovato-lanceolate; petali su peduncoli inferiori al cm, bilobi per 1/3 della lunghezza totale, in genere più brevi dei sepali (lunghi 4-5 mm) al più di poco superiori; capsula lunga 7-8 mm. Si distingue dall'affine C. glutinosum Fr. (vedi) soprattutto per le brattee pelose su entrambe le pagine (come le foglie) e prive di margine scarioso e per gli stili più lunghi di 1 mm (il fusto in basso può avere o non avere peli ghiandolari).
Habitat: prati, pascoli, incolti, zone marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Cerastium semidecandrum L. PEVERINA ANNUALE
T scap – Cosmop. - II-VI – Relat. rara.
Erbacea verde pallida, peloso-vischiosa, a fusto eretto o ascendente, alta 3-30 cm; foglie ovato-ellittiche ad apice ottuso e lunghe fino a 2 cm; fiori a petali (smarginati o bilobi) inferiori ai sepali (4-5 mm) e con unghia glabra, sepali e brattee con largo margine scarioso; pedicelli fruttiferi spesso ripiegati e assai più lunghi delle brattee e sepali (fino a volte); capsula di ca. 6 mm, cilindrica e diritta, più lunga del calice.
Habitat: campi e zone aride e luminose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016 (sub C. s. L. subsp. semidecandrum): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Peverina annuale): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (anche se non lo cita, per errore, nell'elenco floristico, ma solo sui rilievi vegetazionali); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: anche sulle rocce scure di serpentino.
-Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. PEVERINA A GRANDI FOGLIE
H scap – C.-Europ. - V-VIII – Abbastanza raro.
Erbacea perenne irsuta e ghiandolosa, a fusti fioriferi ascendenti e gracili, alta 15-60 cm; le foglie cauline inferiori ovato-ellittiche e con picciolo di 5-7 cm, quelle dei cauli fioriferi lanceolate, lunghe fino a 5 cm, larghe (6) 10-12 mm e sessili; fiori – sepali lanceolato-acuti di 5-6 mm e petali bilobi, più lunghi (fino al doppio), pedicelli (15-20 mm) pure più lunghi del calice – riuniti in infiorescenza abbastanza ricca; capsula di ca. 1 cm e ricurva.
Habitat: terreni ricchi e umidi in ambienti boschivi o arbustivi protetti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Caruel 1893: Montepiano; Baroni 1897-1908: Montepiano (Car. herb. e Car. 1893); Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005 (a monte delle Barbe, da passo Acandoli a cascina Vespaia. Pellacchia strada di Luogomano): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Badia di Montepiano (2014 e 2021), Sasseta (2022) (Vernio).
- Cascine di Tavola: Stampi 1967, non ritrovato da Gestri e Lazzeri 2021.
-Cerastium tomentosum L. PEVERINA TOMENTOSA
Ch suffr – Endemica del CS-Italia (sotto la Toscana) e Sicilia, da noi coltivata e a volte naturalizzata – V-VIII – Rara.
Suffrutice bianco-tomentoso, a fusti ascendenti e ramificati già dal basso, alta 5-40 cm; foglie sottili (2-5 x 10-30 mm), uninervie a margini revoluti; fiori – sepali di 5-7 mm a largo margine bianco, petali glabri e più lunghi (fino al doppio) dei sepali, peduncoli di 1-2 cm – in infiorescenze ramose; il frutto è una capsula cilindrica, lunga da 3 a 12 mm e che termina in 10 denti ripiegate ai lati e non all'apice.
Habitat: in ambiente naturale in aree sassose soprattutto calcaree, da noi su muretti e pendii rocciosi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: a Le Cave e a M. Bucciana (riserva naturale Acquerino-Cantagallo); nuovi ritrovamenti: Sasseta, su pendio roccioso (2024) (Vernio).
NB: Arrigoni & Bartolini 1997 hanno ritrovato questa specie sulla Calvana, ma nel comune di Calenzano (Fi), segnalazione riportata anche in Arrigoni & Viegi 2011.
Il genere Cherleria
deriva dallo smembramento del genere polifiletico Minuartia, che comprendeva 11 cladi principali tutti elevati a rango generico; Cherleria è di recente introduzione (Moore & Dellingberger 2017), conta una ventina di taxa presenti in Europa (soprattutto nella penisola balcanica), nelle montagne N-Americane e nell'Artico (4 specie e 2 sottospecie in Italia). Dal punto di vista morfologico il nostro genere presenta foglie lineari assai sottili e fiori con i sepali ottusi e arrotondati all'apice, inoltre sulla pianta sono presenti ghiandole e peli monocellulari semplici e non ghiandolari.
-Cherleria laricifolia (L.) Iamonico subsp. ophiolitica (Pignatti) Iamonico MINUARZIA DEL SERPENTINO
Ch suffr – Endemismo italiano del serpentino – V-VII – Rara e localizzata.
Suffrutice a rami inferiori lignificati e prostrati sul terreno, i fioriferi eretto-ascendenti, si nota la presenza di numerosi rigetti sterili a foglie appressate, è alta da 8 a 30 cm ca.; le foglie sono opposte, sottili (larghe 0,5 mm ca.) e lunghe 7-12 mm; i fiori - a petali bianchi superanti i sepali trinervati e pelosi - sono riuniti in numero di 2-6 in cime terminali; la nostra sottospecie, oltre ad avere in generale dimensioni un po' ridotte, si caratterizza per i petali lunghi 5-7 mm (ovvero superanti i sepali (4-5,5 mm) per meno del doppio della lunghezza), per la glaucescenza e per il fatto di vegetare su substrato ofiolitico.
Habitat: in anfratti rocciosi o su sfatticcio di serpentino.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: Caruel 1860-64 [sub Alsine striata Gren (Bert.)]; Parlatore 1892 (sub Alsine laricifolia L.); Bertoloni 1897-1908 in add. Emend. (Alsine laricifolia Crantz.): m.Ferrato (Micheli in Baroni II); Fiori 1914 (sub Alsine laricifolia); Messeri 1936 (sub Alsine laricifolia Crantz. e Alsine laricifolia Crantz. var. glandulosa Ruoy & Fouc.: Locus classicus al Monteferrato); Arrigoni & al. 1983 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti); Gestri & Biagioli 1992 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti); Ricceri 1993, 1998 e 2006 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti); Biagioli & al. (sub Minuarzia del serpentino); Biagioli & al. 2002 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti): sulle pietraie serpentinose; Foggi & Venturi 2009 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti): fra Monteferrato e M. Piccioli; Ricceri 2010 (sub Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Tell. subsp. ophiolitica Pignatti).
Il genere Dianthus
(dal greco Dios, Giove, e anthos, fiore: fiore degli dei, per la particolare bellezza) conta circa 300 specie distribuite in Europa, Asia e Africa (una quarantacinquina di specie e molte sottospecie sono presenti in Italia). Si tratta di piante erbacee quasi sempre perenni, ben riconoscibili dalle foglie cauline lanceolato-lineari, opposte e connate su un fusto rigido e poco flessibile; i fiori - calice lungamente tubuloso e circondato in basso da scaglie o brattee (epicalice); 5 petali con unghia allungata (per lo più di colore rosso) - si presentano terminali al fusto, singoli, gemini o in capolini; il frutto è una capsula aperta in 4 denti. Si distingue dal simile genere Petrorhagia per avere il calice cilindrico con brattee erbacee almeno al centro (verde) e la capsula pure cilindrica, Petrorhagia invece presenta il calice a 5 angoli con brattee scarioso-biancastre e la capsula ovoide.
-Dianthus armeria L. subsp. armeria GAROFANINO A MAZZETTI
H scap (T scap) – Europ.-Caucas. – V-VIII – Comune e diffuso.
Erbacea di 20-50 cm, pubescente, a fusto rigido ed eretto, ramificato in alto, priva di rigetti sterili; foglie opposte, sessili, lineari-lanceolte e dotate di guaine lunghe e larghe ca. 4 mm; i fiori - a petali rossi maculati di bianco e ad apice dentellato, subsessili - sono riuniti in densi fascetti terminali di 4-7 e circondati da lunghe brattee; le scaglie dell’epicalice sono completamente erbacee e i petali, lunghi fino a 6 mm, a lembo che tende ad allargarsi verso l'alto al di sopra dell'unghia assumendo l'aspetto di un triangolo isoscele allungato (in Dianthus balbisii Ser. assume quasi l'aspetto di triangolo equilatero).
Habitat: radure boschive di latifoglie.
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 e Arrigoni & al. 2005, Ricceri 2006: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Ricceri 2006: Appennino di Montepiano; nuovi ritrovamenti: presso Gavigno (2019), strada bianca da Migliana a Le Cavallaie (2018) (Cantagallo); da Montepiano al Gasperone e oltre (2024).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline a N di Prato: Ricceri 2006.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofanino a mazzetti): AMPIL del Monteferrato, Ricceri 2002; Ricceri 2006.
- Montalbano: Ricceri 2006; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: ex-cave.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S)
-Dianthus balbisii Ser. subsp. balbisii GAROFANINO DI BALBIS
H scap – Medit.-mont. - V-IX – Comune.
Erbacea, a fusto semplice ed eretto, alta 30-50 cm; è simile a D. armeria L. dal quale si distingue per la radice legnosa, per la presenza di rigetti sterili, per le foglie con guaina 2 volte più lunga che larga, per i petali rossi a volte maculati di porpora, per le scaglie dell’epicalice (glabre e coriacee) con solo l'apice erbaceo il resto scarioso e per i petali che si allargano nel lembo rapidamente andando verso l’alto (quasi a forma di triangolo equilatero).
La sottospecie in questione (la nominale) si caratterizza per le foglie piatte, larghe 2-3 mm ed il petalo con lembo lungo 8-10 mm.
Habitat: prati e radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Ricceri 2006 (sub D. b. Ser. sl): Alta valle del Bisenzio.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub D. carthusianorum var. liburnicum); Gestri & Lazzeri 2021 (sub D. b. Ser. sl).
- Calvana: Ricceri 2006 (sub D. b. Ser. sl); Gestri 2009 (sub D. b. Ser. sl) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Colline di Prato: Ricceri 2006 (sub D. b. Ser. sl): passo della Collina.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofano dei certosini): AMPIL del Monteferrato
- Montalbano: Baroni 1897-1908 [sub D. carthusianorum L. var. balbisii (Ser.)]: fra Montelupo e Verghereto (Somm. herb.); Ricceri 2006; Gestri & Peruzzi 2013a (sub D. b. Ser. sl): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub D. carthusianorum L.): ex cava Guarino e pineta di Bagnolo (Montemurlo); Ricceri 2006 (sub D. b. Ser. sl).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
?-Dianthus deltoides L. subsp. deltoides GAROFANO MINORE
H caesp – Eurasiat. - V-VIII – Rarissimo o assente.
Erbacea a fusti finemente pubescenti, ascendenti e ramosi, con presenza di rigetti sterili ± prostrati, alta 10-40 cm; foglie piane, le inferiori e quelle dei rigetti sterili lineari-spatolate, più brevi e ottuse (1.5-2 X 6-15 mm), le cauline più distanziate e più lunghe (1 X 15-25 mm); fiori per lo più solitari in panicoli dicotomi; presentano petali a forma di “delta” (ovvero triangolari, da cui il nome), porporini, spesso maculati di bianco e/o di rosso, dentellati, lunghi fino a più di 2 cm e pelosi alla fauce; il calice è striato, pubescente almeno all'apice, a denti molto acuti; le scaglie dell'epicalice si presentano lanceolate e brevi (raggiungono al max. la metà del calice).
Habitat: aree prative e radure aride.
Distribuzione sul territorio:
- ?Appennino principale pratese: Ricceri 2002: Montepiano, prati a monte della strada di Malferra (Vernio); Ricceri 2006: ambienti prativi dell'alta valle del Bisenzio.
- ?Monteferrato: Biagioli & al. 2002: un individuo trovato sul versante N dei Sassi Neri (Montemurlo).
-Dianthus hyssopifolius L. (= D. monspessulanus L.) GAROFANO DI BOSCO
H scap – Orofila S-Europ. – V-VIII – Rara.
Erbacea glabra di 20-50 cm, a fusto a sezione rotonda, ascendente e ramoso in alto; foglie cauline lineari ed acuminate, poco consistenti e lunghe fino a 10 cm; fiori solitari, odorosi e grandi (2-5 per pianta) a petali lunghi ca. 2 cm compresa l'unghia, di colore roseo o bianco, terminanti in alto in sottili e profonde (fino a metà lembo) lacinie; calice è cilindrico e attenuato in alto con squame del'epicalice che raggiungono circa la metà del calice stesso.
Habitat: specie acidofila di ambiente nemorale.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Ricceri 2006 (sub D. monspessulanus L.): Gavigno.
- Colline di Montemurlo: nuove segnalazioni: presso le Stoppie (a SW della Quercia dei Termini) (2000).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofano di bosco): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Sandri & Fantozzi 1895 (sub D. monspessulanus L.): nelle cime più elevate di Mont'Albano; Baroni 1897-1908 ( sub D. monspessulanus L.): M. Albano (Martelli in Parl. I); Ricceri 2006 (sub D. monspessulanus L.): prati del Montalbano; Gestri & Peruzzi 2013a (sub D. monspessulanus L.): Carmignano.
NB: fra le specie del genere si riconosce facilmente, perché nel Pratese è l'unico garofano ad avere i petali bianchi o roseo-chiari e profondamente laciniati! Sul Montalbano è presente anche in territorio fiorentino e pistoiese (Gestri & Peruzzi 2013a)!
-Dianthus seguieri Vill. subsp. seguieri GAROFANO DI SÉGUIER
H scap – C-Europ. – VI-VIII – Localizzato e abbastanza ben rappresentato nei luoghi di crescita.
Erbacea glabra a fusti ascendenti, gracili, semplici o ramosi, alta 10-60 cm; foglie piane e sottili (larghe 1-5 mm), con guaine di 1-2 mm; i fiori sono grandi e terminali alle ramificazioni, solitari oppure in fascetti pauciflori (max. 12); il calice appare cilindrico a denti acuti, a volte arrossati, i petali sono ravvicinati, di colore roseo ± carico, a lembo di 5-14 mm di lunghezza, profondamente dentellati, pelosi alla fauce che appare spesso più chiara e screziata di porpora; le scaglie del'epicalice (in numero di 2-6) spnp lunghe ½ o ¾ del calice e a punta eretto-patente.
Habitat: prati e radure aride, zone pietrose.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Ricceri 2002, Arrigoni & al. 2005, Ricceri 2006: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sopra Migliana (2009), presso gli Acandoli (2011), M. Scalette e presso Tab. Gavigno (2024) (Cantagallo).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: Massacorbi (2010), a N della fattoria di Javello (2018).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofano di Séguier): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano (raro).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): in castagneti.
-Dianthus virgineus L. GAROFANO LUNGICAULE
H scap – Medit. – IV-VII – Non raro nei territori di crescita.
Erbacea di 20-70 cm, a cauli, glabri ed eretti; essa fa parte del complesso D. sylvestris caratterizzato da fiori isolati (rar. 2) al culmine di ogni fusto fiorifero, petali a denti ridotti e brevi e squame dell'epicalice non più lunghe di 1/3 del calice. Il nostro si diversifica per il fusto lignificato in basso, le foglie larghe 1-2 mm e canalicolate, i petali glabri alla fauce, il calice a segmenti acuti e lunghi ca 5 mm, le squame dell'epicalice appressate con le interne lunghe 6-7,5 mm.
Habitat: pietraie, incolti e praterie aride (almeno da noi) soprattutto su serpentino e calcare.
Distribuzione sul territorio:
- ?Appennino principale pratese: Ricceri 2002 (sub D. lonicaulis Ten.).
- Calvana: Ricceri 2006 (sub D. longicaulis Ten.); Foggi & Venturi 2009 (sub D. longicaulis Ten.): praterie; Gestri 2009 (sub D. sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) Greuter et Burdet) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub D. longicaulis Ten.): Prato.
- Colline a W di Vaiano: Ricceri 2002 e 2006 (sub D. longicaulis Ten.): Passo della Collina.
- Monteferrato: Tozzi 1702 (sub cariofillo sil.[vestre]); Caruel 1060-64 (sub D. sylvestris Wulf.): M. Ferrato (Bar. ec.); campione d'erbario (FI) di T. Caruel 6-7-1863 sub D. sylvestris Wulf. (rividit Arrigoni: D. virgineus L.: M. Ferrato agrii Fiorentinii (Montemurlo); Fiori 1914 (D. caryophyllus var. virgineus); Messeri 1936 (sub D. virgineus L. var. brevifolius Rouy (più frequente) e var. longifolius Rouy); Arrigoni & al 1983 (D. sylvestris Wulfen); Biagioli & al. 1999 (sub Garofano silvestre); Biagioli & al. 2002 [sub D. sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) Greuter et Burdet)]: frequente nelle praterie aride e nelle pietraie serpentinose; Ricceri 2002 e 2006 (sub D. longicaulis Ten.).
- Monte Le Coste: Gestri 2013b (sub D. longicaulis Ten.) (C/S).
Il genere Gypsophila
conta oltre 150 specie a distribuzione Eurasiatica e E-mediterranea (9 specie in Italia, di cui 5 esotiche). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni, a sepali concresciuti (sottofamiglia Silenoideae) che vanno a formare un calice a tubo campanulato con le sole 5 nervatura mediane dei sepali, lungo da 2 a 17 mm; i 5 petali si presentano da rosei a violacei, gli stili sono 2(-3) e gli stami 10, manca il calicetto; le foglie sono opposte e, almeno le superiori, sessili; i fiori sono posti su pedicelli eretti e vanno a costituire infiorescenze a dicasio, a corimbo o panicolo; il frutto è una capsula da globosa ad ovata, a oblunga, dotata di carpoforo, almeno nella nostra specie; i semi sono reniformi, tubercolati e compressi.
L'entità in esame è stata reinserita nel genere Gypsophila da poco tempo, precedentemente veniva considerata appartenere al genere Vaccaria (ora soppresso) per dei caratteri morfologici limitati soprattutto alla capsula lunga 12-17 mm (invece di 2-4 mm) e che presenta, alla commissura fra i sepali, 5 ali (invece di avere una commisura bianco-scariosa e priva di ali).
-Gypsophila vaccaria (L.) Sm. (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert) CETINO
T scap – Archeofita W-Asiat. - IV-V – Molto rara (a comparsa discontinua).
Erbacea glabra, a fusto eretto e ramoso, alta 30-60 cm; foglie opposte, sessili, a lamina lanceolata; i fiori - a 5 petali rosei, senza scaglie, calice a 5 sepali concresciuti, alato alle commissure e piriforme -sono posti su lunghi peduncoli a costituite un'infiorescenza dicotoma lassa; la capsula è dotata di 5 ali commessurali, ovatae e possiede un breve carpoforo; i semi sono numerosi, tubercolati e neri a maturità.
Habitat: soprattutto infestante le colture su terreni pesanti, a volte si comporta come ruderale.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016 (sub Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): sotto Villa del Palco a margine strada/campo (Prato).
- Monteferrato: Ricceri 2006 (sub Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert) (su segnalazione di B. Acciai); riconfermata da chi scrive anche qualche anno dopo in zona marginale (Prato).
Il genere Herniaria
conta ca. 45 specie originarie delle aree paleotemperate del globo e poi diffuse anche altrove per opera dell'uomo (9 sono presenti in Italia). Si tratta di erbe annuali o perenni a foglie opposte (almeno le inferiori) con stipole piccole (= sottofamiglia Paronychioideaea) e non aristate all'apice (questo le distingue dalle piante appartenenti al genere Paronychia); fiori a petali senza unghia o quasi, sepali erbacei e liberi, ad apice ottuso, con 2 stili; brattee piccole ed erbacee; frutto ad un solo seme (rinchiuso nel calice persistente).
PS: curiosa la derivazione del nome: si pensava che queste erbe potessero curare la patologia erniaria.
-Herniaria glabra L. subsp. glabra ERNIARIA GLABRA
T scap – Paleotemp. - V-VIII – Non comune e localizzata.
Erbacea glabrescente a fusto prostrato e molto ramificato, lunga fino a 5 cm e con giovani rami glabri o con peli irregolarmente distribuiti per lo più in tutti i sensi; si caratterizza: per le foglie (dotate di piccole stipole) a lamina lanceolata, glabre o con peli marginali, lunghe fino a poco più di 0,5 cm; per i fiori sessili - a 5 petali biancastri, più brevi dei 5 sepali che appaiono verde-giallastri, uguali fra di loro o quasi, glabri o con peli sparsi – riuniti in glomeruli ascellari o a volte terminali; il frutto è una nucula sferica contenete 1 seme nerastro.
Habitat: terreni incolti sabbiosi o rocciosi (anche su serpentino).
Distribuzione sul territorio:
- ?Appennino principale pratese: Ricceri 2006: riserva naturale Acquerino-Cantagallo.
- Monteferrato: Caruel 1860-64: presso Prato al M. Murlo (Bert.) e al M. Ferrato!; Fiori 1914; Messeri 1936 (nella var. ciliata Bab.); Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 2002: su fine sfatticcio e zone rocciose di serpentino.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S): sulla cima.
-Herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta ERNIARIA IRSUTA
T scap/H scap – Paleotemp. – V-VIII – Rara.
Erbacea pelosa e grigiastra, a fusti gracili e prostrati, lunghi fino a 20 cm; foglie lanceolate, lunghe fino a 12 mm, ispido-irsute (a volte glabrescenti), le inferiori opposte e le superiori alterne, con stipole piccole ovato-oblunghe; fiori - piccoli, sessili, a sepali lanceolati un po' ineguali nel frutto e con all'apice una setola robusta - riuniti in glomeruli ± densi e opposti alle foglie.
Habitat: incolti su terreni sabbiosi o sciolti soprattutto acidi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato (rara).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: a Prato Rosello (Carmignano).
Il genere Illecebrum
è monospecifico (vedi sotto). Appartiene alla sottofamiglia Paronychioideae (foglie con stipole) e si distingue dai generi affini per le foglie opposte almeno in basso, i fiori verticillati all'ascella delle foglie, a piccolissimi (o nulli) petali, con il calicepiù lungo delle brattee (scarioso-argentee) e costituito da sepali divisi fra loro, bianchi e spugnosi; frutto ad un solo seme.
-Illecebrum verticillatum L. CORRIGGIOLA VERTICILLATA
T scap – Subatl. – V-VII – Rarissimo e localizzato.
Erbacea a fusticini ramificati dal basso e prostrati di 5-30 cm (a volte sommersa e a fusti molto più allungati); foglie opposte, carnosette, a lamina ovata, ottusa e glabra; fiori piccoli, riuniti in numero di 4-6 in peudoverticilli all'ascella fogliare, a petali molto piccoli o nulli e calice a sepali (2 mm ca.) bianchi, spugnosi e ricurvo-concavi verso l'interno; il frutto è una capsula contente 1 solo seme.
Habitat: luoghi fangoso-umidi, stagnetti temporanei, pozze d'acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2009 e Gestri & Peruzzi 2013a: Prato Rosello (Carmignano); 2 oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: Carmignano.
NB: si tratta di una delle specie più interessanti e rare presenti sul territorio pratese; questa è la segnalazione più recente di questa specie in Toscana, le altre risalgono ad oltre cento anni. La pianta è presente a Prato Rosello in due localizzazioni distanti qualche centinaio di metri l'una dall'altra: in una vegeta in stagnetti temporanei e nell'altra in uno specchio d'acqua (in gran parte semisommersa!) che secca quasi tutti gli anni in piena estate.
Il genere Lychnis
conta una venticinquina di specie, presenti allo stato spontaneo nelle zone temperate di Europa, Asia e Africa (3 spontanee più una occasionale in Italia). Si tratta di specie erbacee biennali o perenni appartenenti alla sottofamiglia delle Silenoideae (calice con sepali concresciuti a tubo) a fusti eretti, foglie lanceolato-ovate e acute, fiori solitari o a dicasio, a 5 petali, 5 sepali con 10 nervature e 5 stili; frutto a capsula deiscente con 5 dentelli all'apice. Si distingue dal genere Silene (molto simile) perché le piante di quest'ultimo (con alcune eccezioni) presentano il frutto a 6 denti ed il fiore a 3 stili; da Agrostemma si distingue per avere i sepali evidentemente più brevi dei petali.
-Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-cuculi CROTONELLA FIOR DI CUCULO
H scap – Eurosib. - V-VIII – Comune, a volte comunissima.
Pianta erbacea, stolonifera, a fusto eretto e ramificato, alta 30-60 cm; le foglie si presentano opposte e glabre, le basali lineari-spatolate, le superiori più strette (0,3 x 4-5 cm); i fiori (2-3 cm di diametro), a 5 petali roseo-violetti divisi in 4 sottili segmenti ± allungati e divergenti, sono riuniti in cime dicotome lasse; il frutto è una capsula ovata.
Habitat: incolti erbosi e freschi, prati, radure.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantangallo; Arrigoni & al. 2002 (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.): riserva naturale Acquerino-Cantangallo; Venturi 2016: Limentra orientale; Gestri 2018: Cantagallo, Vernio; nuovi ritrovamenti: fra l'Acqua e la Rasa (2024) (Cantagallo); sopra Montecuccoli, da Fabbro a Migliana (2022) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1947; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.); Gestri 2009 (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.): Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: Tra Centopini e I Bifolchi (Prato).
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Fior cuculo): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Biagioli & al. 2002 (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.).
- Monte le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub Silene flos-cuclulii (L.) Claiv.) (C/S).
PS: l’epiteto “fiore di cuculo” è dovuto al fatto che spesso sulla pianta si trova una schiuma prodotta dalla larva di un insetto che era chiamata volgarmente “saliva del cuculo”.
NB: la specie è presente anche in altre localizzazioni anche di pianura un po' in tutti i comuni.
Il genere Moehringia
conta una trentina di specie distribuite nelle zone temperate dell'emisfero boreale, soprattutto in Europa con alcune presenze in N-Africa e N-America (16 in Italia più una dubbia); un discreto numero di entità sono accantonate sulle Alpi, alcune hanno distribuzione puntiforme. Si tratta di erbacee annuali o perenni a volte difficilmente determinabili senza un approfondito esame dei semi; le foglie mancano di stipole (sottofamiglia Alsinoideae), i fiori hanno 4 o 5 petali ben evidenti e interi, calice dialisepalo e (2) 3 stili, il frutto è una capsula deiscente a 4 valve e con 6 denti; caratteristici i semi reniformi e dotati di uno strofiolo, ovvero di una appendice di colore biancastro.
-Moehringia muscosa L. MOERINGIA MUSCOSA
H caesp – Orofita SC- Europ. - V-VIII – Rarissima.
Erbacea cespugliosa, glabra, alta 8-30 cm, a fusti esili, prostrati o ascendenti e generalmente un po' ingrossati ai nodi; le foglie sono opposte, sottili ed allungate (0.5-1 X 20-40 mm) e presentano una sola nervatura; fiori - a lungo pedicello sottile (fino a 12 mm), per lo più tetrameri a petali (ca. 7 mm) bianchi, più lunghi degli acutissimi sepali (ca. 3 mm) - sono riuniti, in numero di 2-6, alla sommità dei fusti; semi ad insenatura stretta, lunghi 1,2-1,5 mm, con piccolissimo strofiolo.
Habitat: boschi e luoghi rocciosi fresco-umidi di montagna, soprattutto su suoli calcarei e ricchi di humus.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo.
- ?Monteferrato: Biagioli & al. 2002: un solo esemplare su affioramenti calcarei presso la cava del Guarino.
-Moehringia trinervia (L.) Clairv. MOEHRINGIA A TRE NERVI
T scap/H scap – Eurasiat. - IV-VII – Poco frequente.
Erbacea pubescente, a fusti striscianti o ascendenti (10-40 cm), priva di rigetti sterili; le foglie (sessili le superiori, picciolate le inferiori) si presentano ovate, acute, opposte e sulla faccia inferiore presentano tre evidenti (a volte 5) nervature (“trinervia”); i fiori, finemente peduncolati, mostrano i 5 petali bianchi più brevi dei sepali (4-5 mm di lunghezza), che sono trinervati e con un ampio margine cilato e membranoso; i semi sono piccoli e di colore bruno ± scuro.
Habitat: boschi (soprattutto di latifoglie ) e arbusteti fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano verso Poggio di Petto (Somm. herb.); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2002: da Casina le Barbe a Vespaio (Cantagallo); Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Foggli & Venturi 2009: Alta val di Carigiola; nuovi ritrovamenti: Poggio la Zucca (2017), zona Faggione di Luogomano (2020), sentiero CAI 16 versante Migliana (2021), Le Cavallaie (2024) (Cantagallo); M. Scoperta (2022), sentiero 58 Cai dal Gorandaccio verso Montepiano (2023) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: in castagneto, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Moeringia a tre nervi): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: P. a Caiano.
PS: i semi attirano le formiche attraverso il loro strofiolo oleoso così da provvedere alla diffusione della specie.
Il genere Moenchia
comprende 3 specie (con alcune sottospecie) a distribuzione euromediterranea (2 presenti in Italia con 2 sottospecie). Si tratta di piante erbacee generalmente annuali e glauche, con foglie (da lineari a lanceolate) prive di stipole con calice dialisepalo (sottofamiglia Alsinoideae), fiori terminali solitari o pochi, tetrameri o pentameri, a petali evidenti, interi o smarginati, sepali a margine membranoso-biancastro, 4-5 stili; capsula non più lunga del calice, a pedicelli eretti, deiscente e a numero di denti doppi rispetto agli stili.
-Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B. Mey et Schreb. subsp. erecta PEVERINA ERETTA
T scap – Submedit.-Subatlant. - V-VI – Rara.
Erbacea con rametti basali ascendenti e i fruttiferi eretti, alti da 2 a 10 cm; foglie opposte da lineari a lanceolate, le inferiori picciolate e le superiori sessili, lunghe fino a poco più di 1 cm; fiori riuniti in cime di 1-4, a 4 petali (a volte assenti), interi, bianchi, lunghi di meno o come i 4 sepali (3-4 mm) e con 4-8 stami; capsula a 8 denti, lunga come o poco più del calice.
Habitat: praterie e incolti erbosi con un certo grado di umidità, soprattutto in terreni acidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Cascina di Spedaletto (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: presso il Tabernacolo di Gavigno (2018) (Cantagallo); presso Montepiano (2014), Alpe di Cavarzano su prato (2014, 2019 e 2024) (Vernio).
- Montalbano: Carta & al. 2009 e Gestri & Peruzzi 2013a: Prato Roselle (Carmignano).
-Moenchia mantica (L.) Bartl. PEVERINA DI MANTICO*
T scap – N-Medit. - V-VI – Rarissima.
Erbacea alta 10-30 cm, a fusti gracili, eretti e divisi dicotomicamente, con le foglie precocemente essiccantesi alla fioritura; è molto simile alla specie precedente (un po' più robusta), dalla quale si distingue per le cime più ricche (3-9 flore), ma soprattutto per i petali (bianchi, di 6-14 mm) e i sepali (6-8 mm) in numero di 5, gli stami sono 10, gli stili 3-5; la capsula, a 10 denti e ± ovata, è inferiore al calice.
Habitat: zone prative e incolti umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
*Il lucus classico (dove venne descritta per la prima volta) di questa specie è il bosco di Mantico nei pressi di Verona.
l genere Paronychia
è diffuso in quasi tutto il globo con oltre 100 specie erbacee (6 in Italia). Fa parte della sottofamiglia Paronychioideae in quanto le foglie (opposte e aristate) hanno stipole (scariose) ben evidenti; i fiori sono piccoli e per lo più ascellari, con i sepali, subuguali, divisi o saldati solo in basso fra loro e con margine scarioso (anche le brattee hanno margine scarioso); il frutto è un achenio ad un solo seme.
Foto di M. Ziletti
??-Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern. subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. PARONICHIA DELLA KAPELA
H caesp – Medit.-Mont. - V-VII – Da eliminare dalla nostra flora (determinata per errore!).
E' specie montana (oltre i 1300 m) di dubbia presenza in Toscana e sicuramente assente sulle ofioliti del Monteferrato dove fu segnalata da Messeri 1936 (sub P. kapela var. haquetii Fiori)!
NB: anche in Pignatti 1982 a questo proposito si afferma “è segnalata in Toscana sul M. Ferrato, ma per errore”!
Il genere Petrorhagia
conta una trentina di specie erbacee (annuali o perenni) presenti allo stato spontaneo in Europa, Asia e Canarie (5 in Italia). Si tratta di piante appartenenti alla sottofamiglia Silenoideae per i sepali saldati fra loro a tubo; i fiori hanno 2 stili, 5 petali superanti il calice a 5 denti, con linee commissurali scariose biancastre e circondato in basso da un calicetto di bratteole scariose; il frutto è una capsula ovoide deiscente a 4 denti. Le specie del genere Petrorhagia sono assai simili a quelle del genere Dianthus (vedi); si diversificano soprattutto per avere il calice a 5 angoli (invece che cilindrico) e le brattee scariose (invece che erbacee).
-Petrorhagia dubia (Raf.) G.Lopez et Romo GAROFANINA VELLUTATA
T scap – S-Medit. - IV-VII – Comune.
Erbacea a fusti eretti con almeno gli internodi medi pubescenti e ghiandolosi, alte 10-30 cm; le foglie lungamente lanceolate (lunghe fino a 4,5 cm), non dentellate sul margine scarioso, opposte con una guaina 2 volte più lunga (quella delle foglie mediane superiore fino a 4,5 mm) che larga; fiori terminali da 1 a pochi, dotati di petali bilobati a lembo di 1-2,5 mm e unghia assi lunga, di colore da purpureo a roseo, a bianco; semi di 1-1,3 mm, coperti da tubercoli cilindrici.
Habitat: radure e incolti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Fabbro verso Migliana (2022) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofanina vellutata): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Parlatore 1892 (sub Tunica velutina Fisch.et Mey); Baroni 1897-1908 (sub Dianthus velutinus Guss.): al M. Ferrato (Martelli in Parl. I); Messeri 1936 (sub Tunica velutina Fisch.et Mey var. laevicaulis Rouy e Tunica velutina Fisch.et Mey var. uniflora Rouy et Fauc.); Biagioli & al. 2002 (sub Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball. & Heyw.).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Petrorhagia prolifera (L.) Ball. et Heyw. GAROFANINA ANNUALE
T scap – W-Medit. (Subatlant.) - V-IX – Comune.
Erbacea a fusto eretto, ramificato soprattutto in basso, glabro, alto 10-40 cm; foglie lineari lunghe fino a 2 cm, dentellate, con guaina saldata per meno di 3 mm (circa larga come lunga); i fiori - a petali rosei di 10-13 mm e calice quasi ricoperto dal calicetto a brattee scariose – sono inseriti pochi o solitari all'apice dei fusti; capsula clavata, con semi lunghi 1,3-1,9 mm e privi di tubercoli.
Habitat: campi, prati, incolti, radure aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub Dianthus prolifer L.): Montepiano (Somm. herb.); Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Terrabianca (2020), vers. W M. Bucciana, Scalette (2023), dall'Acqua alla Rasa, presso il Tabernacolo di Gavigno (2024) (Cantagallo); sopra il Gorandaccio (2022), Alpe di Cavarzarzano, sentiero da Badia verso S.Giuseppe (2023) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016; Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Garofanina annuale): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub Tunica prolifera Scop.var. uniflora Rouy et F.); Biagioli & al. 2002: sporadica.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Petrorhagia saxifraga (L.) Link GAROFANINA SPACCASASSI
H caesp – Euro-Medit. - VI-IX – Non comunissima.
Erbacea glabra e a fusti ascendenti o eretti, ramificati ed esili, alta 10-40 cm; foglie cauline opposte, sottili ed acute (0.3-0.4 X 10-15 mm); i fiori – petali smarginati, ad unghia breve, di colore rosato con venature più scure; calice lungo la metà circa della corolla (ca. 3,5 mm) a denti ottusi e ciliati, calicicolo membranoso a bratteole che raggiungono la metà del calice – si presentano solitari o in fascetti di 2-3 all'apice dei fusticini; capsula ovata di ca. 3 mm.
Habitat: prati, incolti aridi e assolati.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; 2 oss. Franzoni 2020 Wikiplantbase#Toscana: Calvana (Vaiano).
- Colline a W di Vaiano: nuovi ritrovamenti: da Usella verso il Santo (2022).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Tunica saxifraga); Messeri 1936 (sub Tunica saxifraga Scop.); Biagioli & al. 2002: aridi versanti orientali, su terreno gabbrico scosceso, ma abbastanza profondo, e su pietraie serpentinose.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S); 2 oss. Cataldo 2017 Wikiplantbase#Toscana: M. Le Coste (Vaiano).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: argine del Bardena a Galcetello (2013)
Il genere Polycarpon
è costituito da 7 ad una quindicina di specie distribuite un po' in tutto il globo (1 con 4 sottospecie in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni a fusti ascendenti o eretti, appartenenti alla sottofamiglia Paronychioideae perché le foglie sono dotate di stipole; queste ultime si presentano da ovate a subrotonde, da opposte a verticillate; i fiori, riuniti in cime, sono piccoli (1-2 mm) con calice dialisepalo a sepali interi, senza ariste e con 3-5 stili; le brattee si presentano scariose; i frutti sono capsule che contengono più semi.
-Polycarpon tetraphyllum L.subsp. diphyllum (Cav.) O.Bolòs & Font Quer MIGLIARINA A DUE FOGLIE
T scap – Medit. - V-VII – Abbastanza comune.
Erbacea annuale, alta da 5 a 20 cm; la nostra sottospecie ha fusti semplici e foglie ovate o subrotonde (spesso di colore violaceo almeno quelle situate in basso) con le inferiori generalmente opposte e le superiori verticillate a quattro; i fiori presentano 1-3 stami e sono riuniti in dense cime paucifore.
Habitat: incolti assolati e sabbiosi, margini di strade e sentieri.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub P. t. var. alsinaefolium); Messeri (sub P. t. L. var. alsinifolium Arc.); Biagioli & al. 2002 (sub P. t. L. sl).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b: sopra Figline su roccia di diaspro.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: letto del Bardena e su alcuni marciapiedi a Galcetello (Prato).
- Vernio: nuovi ritrovamenti: in una piazza del paese (2023).
PS: le piante presenti sul Monteferrato (a seguire Fiori 1914 e Messeri 1936) potrebbero appartene alla sottospecie alsinifolium (Biv.) Ball, contraddistinta da foglie opposte e carnose (mai membranose), stipole fogliari non acuminate, internodi quasi sempre inferiori a 5 mm e sepali lunghi 3-3,5 mm (generalmente è pianta arrodssata in basso): necessita una ricerca specifica!
Il genere Rabelera
è monospecifico (vedi sotto), costituito pochi anni fa (Sharples & Tripp 2019), per ragioni filogenetiche, estrapolato dal genere Stellaria. Appartiene alla sottofamiglia Alsinoideae in quanto le sue piante mancano di stipole fiorali ed hanno il calice a sepali divisi. Morfologicamente si differenzia da Stellaria per le foglie tutte sessili (opposte e decussate), le brattee erbaceee ed i petali lunghi fino a 2 volte i sepali.
-Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp
Ch scap – Europ.-Caucas. - IV-VI – Rara e localizzata ad una certa altitudine.
Erbacea alta 20-50 cm, con rami a sezione quadrangolare, prostrato-ascendenti; foglie lunghe 3-8 cm, tutte sessili, opposte e decussate, a lamina lanceolata e margine ruvido; fiori lungamente peduncolati, del diametro di 2-3 cm, a 5 petali bianchi profondamente bilobati e più lunghi dei sepali (6-9 mm) fino a 2 volte.
Habitat: radure boschive, praterie, arbusteti sopra i 200-300 di altitudine.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sentiero 00 dalla Scoperta all’Alpe (2018), Alpe di Cavarzano (2024) (Vernio); dall'Alpe verso il Tabernacolo di Gavigno (CAI 464) (2024) (Vernio-Cantagallo).
- Calvana: Gestri (sub Stellaria holostea L.) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Stellaria holostea L.): Vaiano, Cantagallo.
Il genere Sabulina
conta una settantacinquina di specie proprie delle aree temperate e subtropicali di Europa, Asia, N-Africa e N-America (9 in Italia con alcune sottospecie). Il genere è stato estrapolato da Minuartia che, come si diceva a proposito di Cherleria (vedi), è polifiletico. Sabulina appartiene alla sottofamiglia delle Alsinoideae in quanto le foglie sono prive di stipole. Si tratta di piante erbacee prive di rigetti sterili, generalmente annuali o bienni, con fiori a 5 petali poco visibili e comunque inferiori ai 5 sepali, i peduncoli sono uguali o superiori fino a molte volte i sepali, gli stili sono 3; il frutto è una capsula a 3 valve ottuse.
-Sabulina tenuifolia (L.) Rchb. MINUAZIA IBRIDA
T scap – Paleotemp. - III-VII – Non comune.
Erbacea a fusto eretto e ramificato dal basso, alta da 3 a 20 cm; le foglie sono opposte, sottili (larghe ca. 1 mm e lunghe 6-10, meno dell'internodo) e acute; i fiori – a petali bianchi più brevi dei sepali e pedicelli più brevi del calice - sono riuniti in cime di 4-15; il frutto è una capsula cilindrica più lunga del calice.
Habitat: incolti e radure aride e assolate.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso Migliana (2018), sopra Grigliana su un muretto, a l'Acqua (2024 ) (Cantagallo); sopra il Gorandaccio di Vernio (2019).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021 (sub Minuartia hybrida (Vill.) Schisch.).
- Calvana: Gestri 2009 (sub Minuartia hybrida (Vill.) Schisch.) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. t. (L.) Rchb. subsp. tenuifolia): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Minuartia hybrida (Vill.) Schisch.): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub Alsine tenuifolia); Messeri 1936 (sub Alsine tenuifolia Crantz. var vailantiana DC. e var. conferta Jord. f. dunensis Rouy); Biagioli & al. 2002: falde meridionali del M.Chiesino (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (Minuartia hybrida (Vill.) Schisch. subsp. hybrida) (C/S).
Il genere Sagina
è diffuso in quasi tutto il mondo e conta una venticinquina di specie (10 in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali o perenni di limitate dimensioni (in genere sotto i 15 cm); le sottili foglie, prive di stipole (sottofamiglia Alsinoideae), sono opposte e connate, a volte dotate di mucrone apicale; i fiori – a 4 o 5 petali bianchi, interi, a volte piccolissimi, 4-5 sepali verdi e 4-5 stili – appaiono solitari o in cime pauciflore; il frutto è una capsula a 4-5 valve intere.
-Sagina apetala Ard. SAGINA APETALA
Erbacea alta 3-10 (-20) cm, che si caratterizza per essere annuale con fiori a 4 sepali e a 4 petali bianchi, spesso appena visibili e comunque sempre più brevi dei sepali (che a maturità sono appressati alla capsula) e con peduncoli eretti; le foglie sono sempre dotate di un mucrone ben evidente e si presentano glabre o ciliate solo al margine; i semi sono generalmente inferiori a 0,4 mm.
Habitat: zone incolte assolate e aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: strada sopra l’Alpe di Cavarzano verso il Sasso Bibbio (2018), vers. E della Scoperta, Alpe di Cavarzano (2019) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub S. procumbens var. apetala); Gestri & Lazzeri 2021.
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Colline a W di Vaiano: Baroni 1897-1908: M. Javello sopra Prato (Somm. herb.); nuovi ritrovamenti; riconferma presso Javello (2002).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub S. a. Ard. subsp. apetala) (S).
Foto B. Pierini
-Sagina glabra (Willd.) Fenzl. SAGINA GLABRA
H caesp – Orofita SW-Europ. - V-VII – Non più ritrovata da più di 100 anni (da ricercare).
Erbacea lassamente cespitosa, a fusti prostrati (radicanti) o eretti, alta da 2 a 15 cm; foglie opposte, sottili e mucronulate all'apice, della lunghezza simile a quella dell'internodo; i fiori, del diametro di 0,5-1 cm, a 5 petali bianchi lunghi da 2 a 1,5 volte i 5 sepali (questi ultimi ovati e ottusi all'apice), si inseriscono solitari su un lungo pedicello di 1-2 cm; il frutto è una capsula poco più lunga del calice.
Habitat: prati e radure di montagna su substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908: Montepiano (Somm. herb.).
- Colline di Montemurlo: Baroni 1897-1908: M. Javello (Somm. herb.).
-Sagina hawaiensis Pax SAGINA SUBULATA
H caesp – Submedit.-Subatlant. - Non comune.
Erbacea pubescente-ghiandolosa, di 2-10 cm, a fusticini prostrato-ascendenti; foglie lineari, le basali mutiche e le cauline aristate; fiori - a 5 sepali e 5 petali bianchi e lunghi come o poco più dei sepali (ottusi e di ca. 3 mm) – solitari, su peduncoli allungati (assai superiori alle foglie), eretti o poco ricurvi; capsula poco più lunga del calice e a 5 valve.
Habitat: incolti erbosi, prati, aree marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Parlatore 1892 (sub S. subulata (Sw.) C. Presl): Poggio di Petto (Somm.) (Vernio); Baroni 1897-1908 (sub S. subulata (Sw.) C. Presl): Montepiano (Car. herb.) e Poggio di Petto (Somm. in Parl. I) (Vernio); nuovi ritrovamenti: Alpe Cavarzano su prato (2019), sentiero CAI 16 versante S. Ippolito (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021 (sub S. subulata (Sw.) C. Presl).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub S. subulata (Sw.) C. Presl): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub S. subulata (Sw.) C. Presl); Biagioli & al. 2002 (sub S. subulata (Sw.) C. Presl): a monte della pineta di Bagnolo (Montemurlo).
-Sagina micropetala Rauschert SAGINA MICROPETALA o ERETTA
T scap – Euro-Medit. - II-VI – Rarissima.
Erbacea di 3-15 cm, a fusticini eretti, molto simile a S. apetala (da alcuni Autori è considerata una sottospecie di essa: S. a. Ard. subsp. erecta (Hornem.) F. Hermann), dalla quale si distingue soprattutto per le foglie con ciglia che arrivano a metà della lamina, per i fiori (tetrameri) a sepali ottusi, aperti a croce a maturità ed inferiori di 0,4 mm, almeno sui fiori superiori, alla capsula; semi spesso minori di 0,3 mm.
Habitat: praterie e incolti aridi.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano (Prato Rosello).
-Sagina procumbens L. SAGINA SDRAIATA
H caesp – Subcosmop. - IV-VIII – Abbastanza comune.
Erbacea glabra, di 2-15 cm, a numerose ramificazioni emergenti all'ascella delle foglie di una rosetta centrale e che formano dei piccoli cuscinetti verde brillanti soprattutto su suoli calpestati, con fusti fioriferi brevemente ascendenti; le foglie appaiono sottili, lunghe fino a poco più di 1 cm, acute e mucronate; fiori - a 4 petali piccoli o assenti e 4 sepali lunghi 1,5 mm, ottusi, aperti a croce a maturità – su peduncoli di 0,5-2 cm, ricurvi in alto alla fruttificazione; capsula di 2-3 mm, superiore ai sepali, e a 4 valve.
Habitat: soprattutto incolti, aree antropizzate e calpestate.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: verso l'Acqua (Cantagallo); nuovi ritrovamenti: Fossato (2007) (Cantagallo); dall'Alpe di Cavarzano alla Scoperta (2023) (Vernio).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: sopra il paese di Montemurlo (2024).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Sagina sdraiata): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sentiero per ex-cava Paci (Montemurlo).
NB: sicuramente anche altrove.
Il genere Saponaria
comprende una quarantina di specie a distribuzione Europea ed Asiatica (7 in Italia). Si tratta di specie erbacee (in maggioranza perenni) appartenenti alla sottofamiglia delle Silenoideae per il calice a sepali concresciuti; le foglie sono spatolate; il fiore si presenta a 2 (raramente 3) stili, 5 petali ad unghia lunga, 5 sepali ad una sola nervatura mediana, calice subcilindrico o a tubo senza coste evidenti, fino a 6 volte più lungo che largo e privo di calicetto; il frutto si presenta a capsula aperta a maturità in 4 denti.
ex-Saponaria ocymoides L. SAPONARIA ROSSA
H scap – Orofila SW-Europ. - V-VIII – Estinta (comparsa effimera).
Erbacea di 20-40 cm, pubescente e ghiandolosa in alto, a fusti prostrato-ascendenti, ramosissimi; foglie lunghe da 15 a 17 mm, lanceolato-oblunghe, opposte e sessili, ad una sola nervatura; i fiori inodori – su peduncoli di ca. mezzo cm con 2 piccole brattee a metà lunghezza, petali rossi ± vivaci e scuri, unghia di ca. 9 mm, calice cilindrico rosato e a denti allungati ed ottusi – sono riuniti in brevi cime all'ascella delle foglie superiori; capsula ovata più breve di 1 cm.
Habitat: ambienti assolati su terreni rocciosi, macerie ecc.
Distribuzione sul territorio:
- Monteferrato: fu trovata da chi scrive al Monteferrato diversi anni fa, introdotta con i lavori di rifacimento della strada per le Volpaie che richiese una stratificazione di pietre calcaree sul selciato; ne comunicammo la presenza a Ricceri che la inserì nel suo lavoro del 2006; è scomparsa dopo 1-2 anni dal ritrovamento.
NB: Venturi 2006, nel suo lavoro, ne ha segnalato la presenza in un'unica stazione in provincia di Pistoia (M. La Croce).
-Saponaria officinalis L. SAPONARIA COMUNE
H scap – Euro-siberiana – VI-VIII – Abbastanza comune.
Erbacea glabrescente a fusti robusti ed eretti, alta 30-70 cm; foglie opposte, sessili, lanceolato-oblunghe a 3-5 nervature; i fiori odorosi, del diametro di ca. 3 cm e dotati di un breve peduncolo, sono riuniti in dense cime fogliose; i 5 petali, da rosa ± carico a bianchi, hanno una lunga unghia (20 mm) e un lembo che può raggiungere i 13 mm; il calice è cilindrico, a volte arrossato almeno in alto, e termina in 5 denti acuminati di 1-2 mm; la capsula è oblunga a denti ripiegati all'esterno.
Habitat: incolti fresco-umidi, zone marginali.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: Montepiano verso il Gasperone (2023) (Vernio); sotto Codilupo (2023), da Migliana verso le Cavallaie (2023) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Collina di Prato: nuovi ritrovamenti: sotto il passo della Collina (2020).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Saponaria comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: sponde del Bisenzio presso la Pista ciclabile a Prato (2023)
-Saponaria officinalis L.”Rosea Plena” cultivar
Si tratta di un cultivar a fiori più grandi, petali petali più numerosi, fusti e foglie più robuste della specie di origine, che si è naturalizzato presso un fossetto a Cerreto di Prato (Gestri & Peruzzi 2013b).
Il genere Scleranthus,
distribuito nelle regioni temperate europee ed asiatiche, in N -Africa e in Australia, conta poco più di una decina di specie (6 in Italia con alcune sottospecie). Si tratta di piante erbacee, in genere di piccole dimensioni, annuali/bienni o perenni, a calice con sepali saldati solo alla base e con foglie (connate alla base) prive di stipole (sottofamiglia Alsinoideae); si caratterizza inoltre per i fiori che si presentano privi di petali e a 2 stili, e per il frutto indeiscente, con calice persistete e ad un solo seme.
NB: per le piccole dimensioni delle piante e dei loro organi e per la non completa conoscenza di certe forme, a volte è assai difficile giungere ad una sicura determinazione delle specie appartenenti a questo genere.
-Scleranthus annuus L. CENTOGRANI ANNUALE
T scap (H bienn) – Paleotemp. - III-X – Raro.
Erbacea annuale (o bienne), priva di rigetti sterili alla fioritura, a fusti per lo più ascendenti o prostrati, alta 2-20 cm; foglie sottili raramente superanti il cm, acute e ciliate in basso; fiori a sepali acuti, che sembrano quasi completamente verdi perché poco scariosi al margine (meno di 0,1 mm) e a punta non ripiegata a uncino: a maturità i sepali rimangono un po' patenti (aperti più di 40°); infiorescenza in dense cime a glomerulo; frutto lungo 3,2-4,5 mm.
Habitat: suoli acidi sabbiosi, presso coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908: Prato (Somm. herb.).
-Scleranthus verticillatus Tausch CENTOGRANI VERTICILLATO
T scap/H bienn – Euro-Medit. - II-VI – Raro.
Erbacea alta da 2 a 10 cm, simile alla precedente dalla quale si distingue classicamente per i sepali disuguali e conniventi (aperti per meno di 30°) e per l'infiorescenza, nei fusti mediani, costituita da un glomerulo superiore terminale e da 1-3 glomeruli a breve o assente peduncolo alle ascelle fogliari sottostanti; frutti lunghi 1-3,5 mm.
Habitat: suoli acidi dalla collina (500 m) alla montagna.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: a La Rasa; nuovi ritrovamenti: prato all'Alpe di Cavarzano (2005) e verso la Scoperta (2017) (Vernio).
NB: ritrovato da chi scrive anche sul confine del territorio pratese, a Ponte a Rigoli sul sentiero lungo il Limentra (Pistoia).
Il genere Silene,
assai ricco di specie (oltre 700!), è distribuito in gran parte del globo (Europa, America, Africa e Asia); in Italia sono presenti oltre 70 specie con molte sottospecie. Si tratta di piante erbacee annuali, bienni o perenni, che avendo i sepali concresciuti appartengono alla sottofamiglia delle Silenoideae; le foglie si presentano per lo più sottili e opposte (le inferiori spesso diverse dalla superiori); i fiori hanno 3 stili (a volte 5), calice più o meno tubuloso con 10 evidenti nervature (a volte fino a 50) e che si apre in 5-10 denti; la corolla conta 5 petali a unghia lunga e con a volte alla fauce alcune scagliette; il frutto è una capsula deiscente a 6(-10) denti e dotata di carpoforo (le cui dimensioni spesso sono importanti per determinare la specie); i semi sono numerosi e reniformi.
??-Silene apetala L. SILENE SENZA PETALI
Segnalata da Ricceri 2013: Monti della Calvana fra Casa Rossa e Casa al Piano (nuova stazione). Si tratta sicuramente di un refuso in quanto questa specie non è presente in Toscana (in Italia solo in alcune regioni meridionali e in Sicilia).
ex-Silene cretica L. SILENE CRETESE
T scap – E-Medit. - V-VI – Scomparsa dal nostro territorio (è specie infestante i campi in cui viene coltivato il lino!).
Erbacea a fusto gracile ed eretto, alta 30-80 cm; foglie superiori lineari ed acute, le inferiori obovate; fiori lungamente peduncolati (fino a 6 cm), a petali rossi poco più lunghi del calice (2 mm) a volte mancanti, calice subgloboso alla fruttificazione, lungo 10-16 mm a 10 venature violette e denti acuti; capsula di ca. 7 mm con carpoforo di 3-4.
Habitat: infestante i campi di lino.
Distribuzione sul territorio:
- Pianura: Caruel 1860-64: Poggio a Cajano presso Firenze (Bert.).
-Silene dioica (L.) Clairv. SILENE DIOICA
H scap – Paleotemp. - VI-IX – Relat. comune ad una certa altitudine.
Erbacea dioica (con fiori maschili e femminili su piante diverse), vellutata, a fusti eretti e ramosi, alta 20-50 cm; foglie intere ed opposte, le superiori ovato-acuminate e le inferiori a lembo spatolato e con picciolo di 4-6 mm; i fiori (si aprono solo di giorno) inodori e dioici – petali con scaglie alla base, purpurei, bifidi, con unghia di 12 mm e lembo lungo la metà; calice rosato, fusiforme e poi un po' rigonfio, a denti acuti – sono riuniti in cime lasse dicotome; capsula con carpoforo di ca. 2 mm e a 10 denti rivolti in fuori a maturità.
Habitat: dalla zona collinare alla montana in boschi e prati ricchi di materia organica.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Baroni 1897-1908 (sub Lichnis sylvestris Schk.): Montepiano (Somm. herb.); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sotto Castello di Luciana (2019) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaino, Cantagallo.
- Colline a W di Vaiano: Baroni 1897-1908 (sub Lichnis sylvestris Schk.): nel M. Javello presso Prato (Somm. herb.).
- Colline di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso la fattoria di Javello (2007).
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Silene dioica): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: sentiero dei Patriarchi a margine di bosco (Montemurlo).
-Silene gallica L. SILENE DI FRANCIA
T scap – Euro-Medit. - V-VII – Comune.
Erbacea vellutato-ghiandolosa, a fusti ascendenti o eretti, alta 10-50 cm; foglie inferiori oblunghe-ottuse e le superiori sottili e acute; i fiori – petali interi o poco smarginati, di colore da bianco a rossastro ± carico, calice (7-8 mm di lunghezza) irsuto, piriforme (ristretto all'apice) a 10 denti acuti di ca. 2 mm, su peduncoli di 2-5 mm e con brattee lunghe come il calice – sono riuniti in infiorescenze racemose lasse e monolaterali di 5-10 unità; capsula (lunga 6-9 mm) piriforme con carpoforo molto ridotto.
Habitat: incolti, praterie, radure, soprattutto su terreni non calcarei.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Silene gallica): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: Prato Rosello (Carmignano).
- Monteferrato: Parlatore 1892; Baroni 1897-1908: al M. Ferrato (Cherici in Parl.1); Fiori 1914: citata al M. Ferrato, ma da lui non ritrovata; Messeri 1936 (sub S. g. L. var. quinquevulnera Boiss.); Biagioli & al. 2002:...anfratti rocciosi e su pietraie e su sfatticcio di serpentino...
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Silene italica (L.) Pers. SILENE ITALIANA
H ros – Euro-Medit. - IV-VII – Abbastanza comune.
Erbacea vellutata, a radice emettente più fusti eretti, alta 20-60 cm; foglie sottili le cauline e oblunghe e picciolate quelle in basso, lunghe fino a 4 cm; i fiori - a petali bifidi e privi di scaglie, con unghia ciliata e di ca. 15 mm (lembo di ca. 8 mm), bianchi a volte venati di rosso al di sotto; calice pubescente - sono riuniti in infiorescenze allungate a piramide, con brattee più brevi dei pedicelli; carpoforo lungo pressoché come la capsula (ca. 8 mm).
Habitat: prati e radure boschive.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: da Fabbro a Migliana (2020), sopra Migliana (2021), Carmignanello (2022), Grigliana 2024 (Cantagallo); da Montecuccoli alla Dogana (2018); sopra Vernio (2020) (Vernio); dal lago Verde a S. Poto, da Vernio al lago Verde (2023), sentiero CAI 462b dall'Alpe al Tabernacolo di Gavigno (2024) (Vernio, Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. i. (L.) Pers. subsp. italica): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Silene italiana): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub S. i. (L.) Pers. subsp. italica): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Arrigoni & al. 1983; Ricceri 1998; Biagioli & al 2002: sporadica su prati steppici esposti a N.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub S. i. (L.) Pers. subsp. italica): (S/C).
-Silene latifolia Poir. SILENE LATIFOGLIA
H bienn (H scap/T scap) – Medit. -
Erbacea alta 30-80 cm, a radice a fittone e fusti prostrati o ascendenti e ramosi, pubescente in basso e vischiosa in alto; foglie ovato-lanceolate lunghe fino a 10 cm (spesso con fascetti fogliari ascellari); fiori del diametro di ca. 3 cm, unisessuali a corolla bianca o rosea (unghia ca. 16 mm e lembo ca. 13), a calice ghiandoloso con 10 nervature nei fiori maschili e 20 nei femminili; capsula subsferica (meno rigonfia nei fiori maschili) con 10 denti patenti o revoluti. Qualche anno fa questa specie veniva distinta da S. alba (Miller) Krause (o dalla sottospecie omonima) per avere i denti calici acuti (e non ottusi) e la capsula globosa a denti da patenti a revoluti (invece che piriforme a denti eretti): adesso viene considerata un'unica entità!
Habitat: aree ruderali, campi e incolti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005 (sub S. alba (Mill.) Krause): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub S. l. Poiret subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet): Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: strada bianca da Migliana a Le Cavallaie (2018) (Cantagallo); sopra Badia (2020) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 (sub S. l. Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet ) e Gestri & Peruzzi: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Stampi (sub Lychnis alba Mill. ); Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Silene bianca): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub S. l. Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet ): Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub S. alba (Mill.) Krause): Pian di Gello (Prato) su terra di riporto.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (sub S. l. Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet ) (C).
- Pianura: campi a Galcetello (2024), incolto in loc. il Pinzale (2024) (Prato).
-Silene nemoralis Waldst. & Kit. SILENE DEI BOSCHI
H ros – Orof. S-Europ. - V-VI – Rara (a volte difficile da individuare per la somiglianza con S. italica).
Erbacea assai robusta, alta 40-100 cm e con diametro del fusto agli internodi inferiori di 3-6 mm; morfologicamente è molto simile a S. italica (vedi), della quale è stata anche considerata una sottospecie (S. italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) Nyman); se ne differenzia, oltre che per le usuali maggiori dimensioni, per essere spesso bienne con assenza di rigetti sterili, e soprattutto per i petali con unghia glabra e per il carpoforo un po' più lungo della capsula.
Habitat: ambienti boschivi soprattutto oltre una certa altitudine (sopra i 200 m).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: sotto Migliana salendo dal Fabbro (2020) (Cantagallo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: sopra l'Arno (Carmignano).
NB: probabilmente è presente anche altrove!
-Silene nutans L. SILENE CIONDOLA
H ros – Paleotemp. - V-VIII – Non comune (a volte segnalata impropriamente per la somiglianza, ad un'osservazione superficiale, con S. italica).
Erbacea di 30-80 cm, vellutata e vischiosa in alto, a fusti ascendenti non o poco ramosi; la rosetta basale è costituita da foglie lunghe fino a 8 cm con peduncolo di ca. la metà, a lamina oblungo-spatolata, le cauline si presentanovia via più sottili fino a lineari; i fiori, un po' reclinati verso il basso, – petali da bianchi a rossastri, scagliosi, a unghia lunga ca. 1 cm e lembo (profondamente bilobo) 6-8 mm; calice pubescente-ghiandoloso, ovato, ristretto in alto e troncato in basso, bruno-porpora – sono riuniti in un lasso panicolo ± unilaterale e paucifloro; la capsula è piccola (7-10 mm), ovato-conica, da 3 a 4 volte più lunga del carpoforo pubescente (insieme alla presenta di scaglie alla base dei petali, è questo che la differenzia in maniera evidente da S. italica a carpoforo lungo quanto la capsula).
Habitat: boschi chiari, ma anche prati, da noi soprattutto oltre una certa altitudine.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso Cascina di Spedaletto (2009), da Migliana verso Le Cavallie (2019), Scoperta, presso il Tabernacolo di Gavigno (2024) (Cantagallo); sopra Montepiano (2018) (Vernio).
- ?Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946, ma non ritrovata da Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009: Cantagallo, non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2016.
- ?Monteferrato: Biagioli & al. 2002: su terreni gabbrici (C. Baylon) e caotici (Patriarchi, Parco Galceti, Pian di Gello) (Prato, Montemurlo).
-Silene otites (L.) Wibel. SILENE OTITE
H ros – Eurasiat. - V-VIII – Non rara ( localizzata soprattutto su terreni calcarei).
Erbacea di 20-50 cm, a radice un po' legnosa, fusti eretti, vischiosi in alto; la rosetta basale è costituita da foglie spatolate lunghe fino a 8 cm, le superiori assai distanziate e via via più sottili; i piccoli fiori, eretti e peduncolati, sono generalmente dioici e riuniti in cime glomerulari pseudoverticillate formanti un grappolo eretto; i petali, interi, lineari e privi di scaglie, si presentano di colore verde-giallastro, il calice è ovato, a denti ottusi e poco più breve dei petali; capsula (3,5-5 mm) a carpoforo brevissimo (ca. 1 mm).
Habitat: praterie, radure, arbusteti e boschi chiari (soprattutto su substrato calcareo).
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. o. (L.) Wibel. subsp. otites): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Sandri & Fantozzi 1895 e Baroni 1897-1908: M. Albano sotto Pietramarina (Sandr. e Fant.) (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C).
-Silene paradoxa L. SILENE PARADOSSA
H ros – Medit. - VI-XI – Localizzata e non comune.
Erbacea assai vischiosa, a radice legnosa e fusti eretti a volte ramosi, alta 20-60 cm; foglie inferiori da obovate a lanceolate, le altre più strette fino a lineari; fiori (si aprono al tramonto e nei giorni assai nuvolosi), riuniti in grappoli piramidali pauciflori, hanno petali profondamente bilobati, ad unghia glabra, da bianchi a giallastri, a rosati, dotati di scaglie acute; calice cilindrico, ristretto in alto, di 25-30 mm (la simile S. italica ha calice lungo al max. fino a 21 mm) e a denti lanceolato-acuti; capsula piriforme più lunga del carpoforo pubescente (lo supera di ca. 1/3).
Habitat: incolti aridi, assolati e pietrosi (da noi è serpentinofita preferenziale!).
Distribuzione sul territorio:
- Colline di Montemurlo: Biagioli & al. 1999 (sub Silene paradossa): Cave di Albiano.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Silene paradossa) e Ricceri 2006: AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Tozzi 1702 (sub licnide … noctiflora): Monteferrato; Caruel 1866; Parlatore 1892; Baroni 1897-1908: a Monteferrato (Car. I e Groves herb.); Fiori 1914; Messeri 1936: S.p. L. forma subhelvola Sagorski in ottobre la rifiorescenza a steli monocefali la fa avvicinare alla var. tenuifolia Seringe, mentre in primavera ha il portamento della typica Asch. et Gr.; Arrigoni & al. 1983; Biagioli & al. 1999 (sub Silene paradossa); Biagioli & al. 2002: relativamente comune.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano: sopra P. alla Malva e Fornia, presso Bacchereto su rupi assolate.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Biagioli & al. 1999 (sub Silene paradossa): Cerreto, Le Sacca; Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Silene viridiflora L. SILENE A FIORI VERDI
H ros – S-Europ.-C-Asiat. - VI-VIII – Abbastanza rara.
Erbacea pubescente-ghiandolosa, a fusto eretto, alta 30-60 cm, verde-scura; foglie inferiori spatolate e superiori lanceolate e acute; i fiori (almeno gli inferiori penduli) sono riuniti in ampia infiorescenza ramificata, hanno petali bianco-verdastri, bifidi con unghia ben più lunga del lembo, calice di 15-20 mm, subconico attenuato in basso, a 10 nervature e denti acuti; carpoforo subnullo.
Habitat: nemorale.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: sotto Codilupo (2023) (Cantagallo); dal lago Verde a Sant'Ippolito, Montepiano verso Badia (2024) (Vernio).
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
-Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. STRIGOLI, SILENE RIGONFIA
H scap – Subcosmop. - III-VIII – Comune.
Erbacea glauca, glabra o glabrescente, a fusti eretti, alta 20-70 cm; foglie glabre, da ovate a lanceolate ± assottigliate; fiori penduli, riuniti in cime dicotome pauciflore, a petali bianchi con lembo profondamente bifido, calice lungo 10-16 mm, rigonfio, a 20 nervature ± evidenti; capsula subglobosa tre volte più lunga del carpoforo. E’ pianta polimorfa di cui sono descritte numerose sottospecie. Nel Pratese ne sono state descritte due, che, anche se presentano vari aspetti differenziali, nella pratica a volte sono difficili da distinguere in maniera sicura (il contesto climatico-ambientale può modificare la sottospecie nominale (forme steniche) e farla assomigliare all'altra!):
-S. vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti
E' specie E-Medit. (quindi di ambienti più caldi ed aridi) che si caratterizza per essere sempre glabra, per la base del fusto un po' ingrossato e legnoso, le foglie a lamina lineare-lanceolata, larga 3-10 mm e un po' carnosetta, apice degli stili non ingrossati e capsula meno rigonfia.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Silene angustifolia Mill.); Gestri & Peruzzi 2016: Prato
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub S. inflata Sm. var. angustifolia DC.).
- Pianura: argine del Bardena a Galcetello (2024) (Prato).
-Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Dovrebbe vegetare nelle aree più fresche e si caratterizza per la base del fusto erbacea, le foglie a lamina ovata, larga 10-40 mm e di sottile spessore, con apice degli stili ingrossati e capsula rigonfia.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: presso il Tabernacolo di Gavigno (2022) (Cantagallo); Alpe di Cavarzano (2023) (Vernio).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-In molti casi non è stata indicata la sottospecie: Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. (probabilmente in gran parte da riferire alla sottospecie nominale):
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Cantagallo, Vernio.
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub S. cucubalus Wibel); Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Strigoli): AMPIL del Monteferrato.
- Monteferrato: Fiori 1914; Biagioli & al. 2002: comune nelle aree marginali, a bordo strade e presso i coltivi.
NB: per stabilire l'esatta distribuzione delle due sottospecie (e/o altre eventuali) nel nostro territorio andrebbe condotto uno studio ad hoc!
PS: Le foglie di di questa pianta sono molto apprezzate fra i radicchi selvatici: in Toscana è chiamata Strigoli perché i calici e le capsule rigonfie scoppiettano se compresse con le dita.
Il genere Spergula
conta da 5 ad una decina di specie distribuite in Asia e soprattutto in Europa in area mediterranea (3 in Italia). Si tratta di erbacee annuali a foglie sottili (spesso inferiori ad 1 mm di larghezza), apparentemente verticillate (in realtà più foglie opposte "raggruppate" ai nodi del fusto), sessili e con presenza di stipole non connate (sottofamiglia delle Paronychioideae), fiori riuniti in infiorescenze terminali povere, posti su peduncoli bratteati e che presentano 5 petali sempre bianchi e interi, 5 sepali liberi, erbacei, interi, da ellittici ad ovati e 5 stili; capsula a 5 valve opposte ai sepali, ovata, polisperma e priva di carpoforo.
-Spergula arvensis L. RENAIOLA COMUNE
T scap – Subcosmop. - V-VIII – Rara.
Erbacea pubescente e ghiandolosa a fusti ramificati dal basso, eretti o ascendenti, alta 10-40 cm; foglie mutiche, sottili, in pseudoverticili di 6-12, inferiormente con solco longitudinale (non presente in S. pentandra) e con stipole abbastanza larghe; i fiori, riuniti in cime irregolari, presentano 5 petali bianchi ovati e ottusi (acuti in S. pentandra), lunghi ca. quanto i sepali, nel frutto superati di poco dalla capsula ovata; ciò che differenzia in maniera ancora più evidente questa specie dalla successiva sono i semi: subglobosi e circondati da una sottilissima ala di 1/10 del raggio totale (in S. pentandra i semi sono circondato da una ala bianca larga come i semi stessi).
Habitat: campi, incolti su terreno ± sabbioso e siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano (presso il cimitero di Artimino).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: qualche esemplare a margine dei campi.
-Spergula pentandra L. RENAIOLA A CINQUE STAMI
T scap – Submedit.-Subatlant. - III-IV – Rarissima.
Erbacea glabrescente a fusto eretto e ramificato dal basso, alta 5-20 cm; molto simile a S. arvensis dalla quale si distingue (come già detto prima), per le foglie non solcate inferiormente, i petali acuti all'apice e per i semi largamente alati (ad ala bianca).
Habitat: incolti e prati sabbiosi e su substrato siliceo.
Distribuzione sul territorio:
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2009: macchia di Camaioni, sotto la Villa di Artimino (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: sopra Prato Rosello (Carmignano); oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: sopra Prato Rosello (Carmignano).
NB: si stratta di una delle specie vegetali floristicamente più importanti e più rare del territorio pratese!
Il genere Spergularia
conta ca. 25 specie (per alcuni AA di più) distribuite soprattutto in NCS-America e nella regione mediterranea di Europa ed Africa (13 in Italia). Si tratta di entità erbacee annuali o perenni (a fusto ramificato e legnoso), a foglie stipolate (stipole connate) (sottofamiglia delle Paronychioideae), molto simile a Spegula (vedi), dalla quale si distingue fondamentalmente per le foglie che si presentano opposte (non in pseudoverticilli), i fiori con 3 stili e la capsula a 3 valve alterne ai sepali (i petali possono essere bianchi o porporini).
-Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl SPERGULARIA ROSSA
Ch suff (T scap) – Subcosmop. temp. - III-VII – Abbastanza comune.
Pianticella a rami prostrati o ascendenti (2-20 cm di lunghezza), annuale o più raramente perenne, pelosa e assai ghiandolosa (soprattutto in alto); foglioline lineari e brevi, opposte, dotate di stipole argentate e acute; i piccoli fiori hanno 5 petali rossi e sono riuniti in brevi cime lasse; i pedicelli sono lunghi ca. quanto la capsula o di più; i semi non sono alati.
Habitat: ambienti sabbiosi e silicei.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale (tra Acquerino e il Faggione delle Valli); nuovi ritrovamenti: nel prato all'Alpe di Cavarzano (2018) (Vernio).
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Spergularia comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: zone boscose intorno alle ville di Bagnolo (Montemurlo).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (c): Cerreto presso Casa Tafanaia.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: presso il cimitero Chiesa Nuova, Cassa espansione del Bardena a Galcetello (2019) (Prato).
Il genere Stellaria
conta da 120 a 180 specie a distribuzione subcosmopolita (10 specie ed alcune sottospecie presenti in Italia). Si tratta di piante erbacee annuali, bienni o perenni, con foglie opposte e prive di stipole (sottofamiglia Alsinoideae); i fiori, per lo più terminali solitari o in cime pauciflore, presentano 3 stili, (4-)5 petali, bianchi e profondamente bilobi e (4-)5 sepali liberi o saldati solo in basso; il frutto è una capsula ovale, deiscente a 6 denti; semi numerosi, subrotondi, lisci o tubercolati.
-Stellaria aquatica (L.) Scop. CENTOCCHI ACQUATICO
H scap (T scap) – Eurosiber. - V-VII (rifioriture X-XI) – Rarissimo.
Erbacea pubescente-ghiandolosa almeno in alto, a fusto fragile e prostrato-ascendente, di 10-40 cm; foglie (1-3 X 2-6 cm) ovate, senza stipole e sessili (le inferiori a volte picciolate); fiori, posti su lungo pedicello (fino a 6 cm) riflesso a maturità, hanno un diametro di ca. 1,5 cm, i petali sono bianchi e profondamente divisi in 2 lacinie lunghe ca. 6 mm, sepali più brevi, 5 stili (carattere distintivo con altre Stellaria) ; il frutto è una capsula ovata un po' più lunga del calice e con 5 valve bifide in alto.
Habitat: zone umide, sponde fluviali, prati inondati.
Distribuzione sul territorio: Nuova segnalazione in corso di pubblicazione sugli Atti della Società Toscana di Scienze naturali di Pisa sulla rubrica “Contributi per una flora vascolare di Toscana” per il 2025.
-Stellaria graminea L. CENTOCCHIO GRAMIGNOLA
H scap – Eurasiat. - V-VIII – Localizzata pressoché solo sull'Appennino principale.
Erbacea glabra a fusti gracili, ascendenti e a sezione tetragona, alta 15-80 cm; foglie opposte, sessili, sottili e ciliate alla base; fiori piccoli (ca. 9 mm di diametro), su peduncoli di 8-20 mm e riuniti in cime terminali pauciflore aperte; petali bianchi, profondamente divisi e superanti i sepali che appaiono lineari, a tre nervature e lunghi fino a 4 mm; capsula (sui 5 mm) pendula, oblunga e superante il calice; semi rugosi di colore brunastro.
Habitat: radure, praterie, su terreno ricco e sopra una certa altitudine (assente in ambienti mediterranei).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Caruel 1860-64: Montepiano (Bertol.); Parlatore 1892); Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale; Ricceri 2006; nuove segnalazioni: presso il Passo di S. Giuseppe (2017), sopra Tavianella (2018), dall'Alpe verso Cavarzano (2020), M. Scoperta (2023), dall'Alpe verso la Scoperta (2024) (Vernio); prato prima delle Scalette (2018) (Cantagallo).
- ?Calvana: Gestri 2009: Vaiano, Cantagallo, non ritrovata da Gestri & Peruzzi 2016.
(All.3 LR 56/2000)
-Stellaria media (L.) Vill. CENTOCCHIO COMUNE
T rept/H bienn/T scap – Cosmop. - I-XII – Comunissima.
Erbacea a fusto gracile, a sezione rotonda, prostrato, diffuso e radicante ai nodi, lungo 5-50 cm, con 1-2 caratteristiche linee di peli longitudinali; foglie ovato-acuminate, le inferiori con lungo picciolo, le superiori sessili; i piccoli fiori, a petali bianchi, bifidi e più brevi dei sepali (questi lunghi 3-4 mm), sono riuniti in cime terminali lasse su peduncoli di 1-3 cm; la capsula piriforme è un po' più lunga del calice; semi in maggioranza di diametro inferiore a 1,2 mm (0,9-1,2 mm) e a tubercoli ± arrotondati: si tratta comunque di una specie assai polimorfa!
Habitat: incolti, campi, margini stradali, di bosco, coltivi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 (presso Lavacchio) e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1947; Gestri & Lazzeri 2021.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967 (sub S. m. Cyr.); Gestri & Peruzzi 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. m. L. subsp. media): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: comune nelle zone coltivate, in quelle umide e negli ambienti antropici...
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: è praticamente presente anche in pianura (compresi certi ambienti urbani) e un po' ovunque nel territorio (escluse le aree fortemente aride e assolate).
-Stellaria neglecta Weihe CENTOCCHIO NASCOSTO
T scap – Paleotemp. - III-VIII – Relat. comune.
Erbacea a fusti prostrato diffusi lunghi 30-80 cm, molto simile a S. media dalla quale si distingue per i petali lunghi quanto o più dei sepali (~ 6 mm), per i semi in maggioranza di diametro superiore a 1,2 mm e con tubercoli più o meno conici; spesso il fiore presenta 10 stami.
Habitat: occupa le aree più calde del territorio in sostituzione della specie precedente.
Distribuzione sul teritorio:
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub S. n. Weihe subsp. neglecta): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: pochi individui in pieno ambiente ofioliticopresso la cima del Monte Mezzano e a Pian di Gello (Prato).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (sub S. n. Weihe subsp. neglecta) (S).
-Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher CENTOCCHIO MONTANO
H scap – Europ.-Caucas. - V-VIII – Normalmente localizzata sopra una certa altitudine (600 m).
Erbacea con stoloni, con fusti a sezione circolare, prostrato-ascendenti e radicanti ai nodi, lunghi 30-60 cm; foglie a lamina cordata in basso e acuminata in alto, le inferiori picciolate e le superiori sessili; i fiori - lungamente peduncolati, con brattee erbacee, a petali bianchi, profondamente bilobati e lunghi fino a 3 volte i sepali di 5-6 m, lanceolato-acuti e pubescenti - sono riuniti in cime pauciflore; capsula di 8 mm ca., di forma cilindrica e superante sensibilmente il calice. La sottospecie presente nel Pratese si caratterizza per avere le foglie del solo paio superiore sessili, tutte le altre ± lungamente peduncolate, per le brattee che si riducono bruscamente di dimensioni andando verso l'alto ed inoltre per i semi che presentano sulla loro superficie tubercoli cilindrico-uncinati.
Habitat: boschi fresco-umidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005 (sub S. n. L. sl): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Foresta Demaniale Acquerino (2014, Cantagallo) in Acta Plantarum Notes 5: 75-78, 2017; nuovi ritrovamenti: zona M. Tavianella, sopra Badia di Montepiano (2014), M. della Scoperta (2018), sopra l'Alpe di Cavarzano (2020) (Vernio); dall'Acqua alla Rasa (2007), sul sentiero CAI 432, presso il Faggione di Luogomano (2021) (Cantagallo).
- Calvana: Gestri 2009 (sub S. n. L. sl) e Gestri & Peruzzi 2016: a NW del M. Maggiore (Vaiano).
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub S. n. L. sl): una sola stazione nel fresco bosco dei Patriarchi (Montemurlo).
- ?Pianura: Baroni 1897-1908 in add. ed emend.: Poggio a Caiano (Micheli in Baroni II)
-Stellaria pallida (Dumort.) Crép. CENTOCCHIO PRIVO DI PETALI
T scap – Paleotemp. - III-VI – Rara, ma più probabilmente sottostimata perché sfugge all'osservazione (assai simile a S. media!).
Erbacea spesso poco sviluppata, a fusti lunghi 10-40 cm, assai vicina a S. media L., dalla quale si distingue per i petali assenti o ridottissimi, i sepali lunghi 2-3 mm o quasi, stami 1-3, semi lunghi 0,6-0,9 mm, peduncoli eretti anche dopo la fioritura. Dove le due specie convivono la nostra di distingue abbastanza agevolmente perché foglie e fiori sono nettamente più piccoli!
Habitat: incolti e prati.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
NB: come si è già detto questa specie è sottostimata e probabilmente assai più diffusa nel nostro territorio.
-Stellaria ruderalis M.Lepší, P.Lepší, Z.Kaplan & P.Koutecký CENTOCCHI RUDERALE
T rept – Europ. - I-XII – Probabilmente abbastanza comune: da ricercare.
S. ruderalis è specie descritta assai recentemente (Lepšί, Lepšί, Koutechý, Lučanová, Koutecá, Kaplan 2019) ed è molto simile a S. media e neglecta; si tratta di una pianta erbacea assai ramificata e con fusti ascendenti lunghi fino a 80 cm e dotati di una linea di peli su ciascun internodo; foglie opposte, da ovate a ellittiche, le inferiori picciolate, le altre sessili; fiori – con pedicelli eretti alla fruttificazione e lunghi in media ca. 3 cm, petali profondamente bilobati, bianchi e lunghi poco meno o quanto i sepali, che si presentano in media di 5 mm, liberi, di forma ovato-lanceolata - sono riuniti in dicasio terminale lasso a maturità; frutto a capsula (5,5-7 mm) terminante in 6 denti e poco più lunga del calice; semi bruni ± scuri, appiattiti, quasi circolari, lunghi generalmente 1,2-1,3 mm e soprattutto dorsalmente con 5-6 file di tubercoli più lunghi che larghi con poche o nessuna papilla sulla parte apicale (carattere distintivo più evidente rispetto a S. media, ma da valutare al microscopio!).
Habitat: specie essenzialmente ruderale come sottinteso dall'epiteto specifico!
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: Gestri & Lazzeri 2021.
NB: il fatto di essere molto simile a S. media e neglecta, che si differenzi da queste praticamente solo per l'aspetto dei semi e che la sua descrizione, come specie autonoma, risale al 2019, la fa ritenere specie sottostimata e da ricercare.