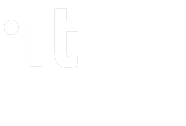Cupressaceae
FAMIGLIA CUPRESSACEAE
Questa Famiglia, subcosmopolita (manca nella foresta tropicale pluviale e nella tundra artica), è costituita da piante arboree e arbustive sempreverdi (ad eccezione del genere Metasequoia) e resinose: circa 130 specie riunite in 30 generi. Le foglie possono essere squamiformi o aghiformi, normalmente glabre, opposte o verticillate; i fiori, monoici o dioici, non sono avvolti da brattee, i maschili costituiscono infiorescenze ridotte a pochi stami squamosi opposti o verticillati, i femminili sono costituiti da scaglie che portano alla base 1 o più ovuli; il frutto è uno strobilo seminifero indeiscente a forma di cono a scaglie legnose, nel genere Juniperus il frutto è carnoso; i semi sono per lo più privi di ali.
Il genere Calocedrus
conta 3 specie a distribuzione N-Americana e E-asiatica (1 naturalizzata in Italia). Si tratta di grandi alberi sempreverdi con tronco eretto e ramificato dal basso, ultime ramificazioni appiattite e inserite a forma di ventaglio, foglie squamiformi, assai appiattite, opposte e disposte su 4 file (sembrano verticillate a 4), i coni allungati che a maturità si aprono in 2 scaglie (in realtà in 4, saldate 2 a 2) con semi a 2 ali disuguali.
-Calocedrus decurrens (Torr.) Florin LIBOCEDRO DELLA CALIFORNIA
P scap – Neofita occasionale e a volte naturalizzata di orig. N-Americana – V – Raro (o almeno poco osservato!).
Albero monoico sempreverde, alto, nei paesi d’origine, fino a 60 m: presenta una corteccia marrone solcata, chioma allungata e conica; le foglie (aromatiche se stropicciate) sono squamiformi, lunghe dai 2 ai 15 mm e aderiscono strettamente ai rametti a forma di ventaglio; le strutture riproduttive maschili sono coni (o strobili) di 4-6 mm terminali ai rami, le femminili coni allungati di ca, 2,5 cm poste sui rametti singolarmente o raggruppate; caratteristico è il frutto giallo-bruno che a maturità è rappresentato da 2 squame che si aprono divaricandosi a mostrare un setto centrale. Il legno odora d’incenso.
Habitat: ambienti montuosi senza ristagni d'acqua o troppo freddi.
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: pianta coltivata nella zona del Caciaio (ritrovata da chi scrive nel 2022 e inserita nel sito del comune di P. a Caino: Scopri la Città “Piante vascolari”).
Il genere Chamaecyparis
conta 5 (o 6) specie presenti sulle coste del N-America e dell'Asia orientale (1 coltivata e a volte naturalizzata è presente in Italia). Si tratta di alberi sempreverdi a rami cilindrico-appiattiti e foglie squamiformi opposte, lunghe 1-2 mm; il frutto è un cono di 2-4 cm formato da squame legnose a forma di scudo (con un processo spinoso al centro) e lungo circa quanto largo: è prodotto in estate e cade in inverno.
-Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. CIPRESSO DI LAWSON
P scap – Neofita occasionale e a volte naturalizzata di orig. N-Americana – II-III – Non comune o poco osservata (a volte utilizzata a fini decorativi o in rimboschimenti, soprattutto in Meridione).
Albero sempreverde che da noi può raggiungere i 10-15 m e nei luoghi di origine 50 e più; ha fusto eretto ramificato dal basso con la chioma che si presenta di forma conico-piramidata, la corteccia è bruno-rossastra e con gli anni si scurisce e si sfalda in placche o strisce; foglie squamiformi triangolari, opposte 2 a 2 e decussate, assai appressate; coni maschili ovoidi di 3-4 mm posti in posizione terminale ai rametti, i femminili sono globosi con 8 squame che a maturità hanno il diametro di 8-10 mm e colore brunastro.
Habitat: terreni profondi e drenati lontano dal mare e al riparo dai venti.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2002: Cerliano (coltivata) (Cantagallo).
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: coltivata (qua e la).
- Monteferrato: nuove segnalazioni: introdotta nel 2023 nel Parco di Galceti (2024) (Prato).
Il genere Cupressus
conta poco meno di una ventina di specie distribuite in area mediterranea, asiatica e N-americana (1 naturalizzata in Italia). Si tratta di alberi simili a quegli del genere Chamaecyparis (foglie squamiformi di 1-2 mm e opposte, frutto globoso a 3-8 paia di squame legnose), dai quali si distinguono per i rami cilindrici e i frutti a cono (circa tanto lunghi che larghi, da noi del diametro di 2-4 cm) praticamente sempre presenti sulle piante adulte, con squame dotate di un mucrone centrale.
-Cupressus sempervirens L. CIPRESSO COMUNEMENTE
P scap – Euro-Medit. orient. - II-V – Comunissimo.
Albero monoico a fusto eretto e ramificato dal basso (portamento colonnare a chioma conica) alto fino a 30-40 m; corteccia brunastra; foglie squamiformi e persistenti di 1mm o meno e strettamente embricate; i coni maschili di colore giallo a fine inverno hanno forma ovoide e sono lunghi 2-3 mm; i frutti sono di forma sferica (2-3 cm), prima di color verde e, dopo 2 anni di maturazione, brune, si fendono in forma di squame legnose per fare fuoriuscire i semi.
Habitat: inserito in molti rimboschimenti in aree non particolarmente fredde e coltivato a fini decorativi (anche nei cimiteri o a lato di viali!)
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021
- Calvana: Fiori 1914; Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Bartolini 1997: specie utilizzata per rimboschimenti e rinfoltimenti di boschi degradati,soprattutto nelle zone più basse; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: fra i Cento Pini e i Bifolchi (Prato).
- Cascine di Tavola: Cenni 1990; Boretti & al. 2006: Podere casa del Guardia; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al 1999 (sub Cipresso): AMPIL del Monteferrato; Foggli & Venturi 2009.
- Montalbano: Giunti 2011: tra Artimino e Limite sull'Arno; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914, Messeri 1936: specie antropocora limitata alle zone ruderali e culturali; Arrigoni & al. 1983; Ricceri 1993; Biagioli & al. 1999A; Biagioli & al. 2002: ambienti coltivati e su terreni ofiolitici.
- Monte Le Coste: Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993;
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
PS: il cipresso, nonostante sia considerato da molti un albero rappresentativo della Toscana, non è indigeno italiano: le sue origini sembrano essere mediterraneo-orientali. Probabilmente fu introdotto nella nostra Penisola dagli Etruschi o dai Fenici a scopo decorativo e in seguito si è naturalizzato e diffuso anche perché favorito dall’uomo.
Dal suo legno profumato, duro e compatto, si ottengono mobili o infissi assai resistenti all’attacco dei tarli.
Il genere Hesperocyparis
è rappresentato da una quindicina di specie arboree presenti nel N-America e fino a pochi anni fa incluse nel genere Cupressus: la sua costituzione è basata su consistenti basi filogenetiche (in Italia sono presenti 3 entità esotiche naturalizzate). Dal punto di vista morfologico è assai simile a Cupressus s.s.(aspetto generale e forma dei coni sono pressoché uguali; i caratteri distintivi non sono molto evidenti: lo distingue dalla maggior parte delle specie di Cupressus (ma non da tutti) il numero superiore di cotiledoni (3-5). Ancora non vi è concordanza sul numero di entità che lo compongono.
-Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel CIPRESSO DELL'ARIZONA
P scap – Neofita naturalizzata e coltivata – II-V – Non raro.
Albero monoico, sempreverde a fusto eretto e ramificato fin dal basso, con rami orizzontali e con folta chioma conica e glauca, alto fino a 30 m; foglie squamiformi acute di odore sgradevole se sfregate; infiorescenze maschili gialle e poi brune, ovate, di ca. 2 mm e terminali ai rami; le femminili sono riunite in piccoli coni globosi che evolvono in galbuli di 1-3 cm a 6-8 squame bruno-grigiastre.
Habitat: preferisce terreni profondi e senza ristagni d'acqua.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Cupressus arizonica E.L.Greene): rimboschimenti del M. Maggiore; Gestri 2009 (sub Cupressus arizonica E.L.Greene) e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Callitropsis arizonica (Greene) D.P.Little): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Boretti & al. 2006 (sub Cipresso dell'Arizona): parco delle Rimembranze.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a (sub Callitropsis arizonica (Greene) D.P. Little): coltivato assai diffusamente sul Montalbano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002 (sub Cupressus arizonica E.L.Greene): nel bosco a O di villa Ciabatti, vers. S (Prato): nuove segnalazioni: via Lungo la Bardena (2024) (Prato).
NB: per la sua adattabilità a molte tipologie di terreno e habitat è assai utilizzato a scopo ornamentale in parchi e giardini e a fini di rimboschimento.
-Hesperocyparis glabra (Sudw.) Bartel CIPRESSO GLABRO
P scap - Neofita naturalizzata e coltivata – II-V – Rara.
Albero monoico, sempreverde a chioma conica ± regolare che può raggiungere da noi i 15 m; la scorza lo differenzia dal simile H. arizonica: appare più liscia, brunastra con sfumature purpuree e a maturità si sfalda in squame o strisce più grandi che tendono ad arrotolarsi su se stesse; le foglie squamiformi sono piccole e fortemente embricate sui rametti, il colore presenta sfumature azzurrine e spesso una macchia bianco-argentata (in H. arizonica sono verde-grigiastre, più scure e prive di macchia); le strutture riproduttive sono simili a H. arizonica, con il cono che a maturità si presenta legnoso, di ca. 2 cm di diametro e bruno-porporino sfumato d'argento.
Habitat: come H. arizonica ma è più sensibile al clima rigido.
Distribuzione sul territorio:
- Cascine di Tavola: Cenni 1990 (sub Cupressus glabra Sudw.); non ritrovato da Gestri & Lazzeri 2021.
Il genere Juniperus
conta una sessantina di specie legnose (alberi e arbusti) distribuite nell'emisfero boreale (in Italia 8 specie spontanee e 2 esotiche occasionali). Le sue piante, in massima parte dioiche, si caratterizzano per avere rami cilindrici, foglie opposte o verticillate a 3, aghiformi in tutti gli individui giovani (a volte anche squamiformi nelle piante mature); i coni maschili, terminali o ascellari, sono piccoli e ovato-allungati, i femminili possiedono 3-4 squame e divengono carnosi e bluastri o rossastri a maturità, simili ad una bacca (galbulo); semi, da 1 a 12, di varia forma ma mai alati.
-Juniperus communis L. GINEPRO COMUNEMENTE
P caesp (P scap) – Circumbor. – II-IV – Comune.
Arbusto o albero alto da 2 a 12 m, sempreverde, dioico che può sopravvivere fino a 400 anni. Ha portamento variabile (se esposto al vento può apparire assai contorto); le foglie aghiformi, pungenti, verde-glauche, sono lunghe 1-2 cm, con sulla faccia superiore una banda centrale biancastra; i frutti (presenti ovviamente solo sulle piante femmina) sono rappresentati da coni carnosi e globosi, aromatici, di colore verde-glauco che diviene nerastro a maturità (normalmente di 4-5 mm, al max 10) detti galbule o coccole; contengono per lo più 3 semi.
Habitat: prati, pascoli, boschi e boscaglie aride.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 (dal Passo del Treppio alla Fregionaia, Bucciana ecc.) e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Cantagallo, Vernio.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021
- Calvana: Fiori 1914; Arrigoni & Bartolini 1997; Foggi & Venturi 2009: dorsale della Calvana; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al 1999 (sub Ginepro comune): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Maugini 1946: Poggio del Cerreto (p. a Caiano); Arrigoni & Viciani 2001 e Viciani 2001: R. Foria; Giunti 2011: Fornia; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub J. c. L. var. tipica Fiori); Arrigoni & al. 1983;
- Biagioli & al. 2002: pinete e fra le rocce serpentinose...(Prato, Montemurlo); oss. Roma-Marzio 2017 Wikiplantbase#Toscana: versante meridionale del Monte Piccioli in loc. i Colli (Prato).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
NB: le bacche di ginepro sono commestibili e possono essere utilizzate in cucina o per la preparazione di liquori.
??-Juniperus oxycedrus L.s.l. GINEPRO OSSICEDRO
P caesp/P scap – Euro-Medit. – II-IV – Segnalato per errore.
Arbusto o piccolo albero di 1-5 m, molto simile a J. communis, dal quale si distingue per un portamento più robusto, le foglie più lunghe (15-25 mm) con due strie bianche sulla faccia superiore ed il frutto del diametro di 8-15 mm e insipido.
Habitat: prati, radure e boscaglie aride.
Distribuzione sul territorio:
È stato indicato sul nostro territorio da Arrigoni & al 1983 e da Foggi & Venturi 2009 ("tra Monteferrato e M.Piccioli") e Ricceri 2013 per il Monteferrato, ma per errore come confermano approfondite e specifiche ricerche successive di Gestri & Roma-Marzio 2017:
Specie da escludere dalla provincia di Prato. Ad eccezione di un’indicazione generica a livello provinciale (Pozzi & Compiani, 1998), tutte le segnalazioni di Juniperus oxycedrus L. per la provincia di Prato sono riferite al Monteferrato (Ricceri, 2013), sebbene già Biagioli et al. (2002) non indicassero la specie per l’area. Dopo una verifica su campo nella zona del Monteferrato, e in particolare sul Monte Piccioli dove secondo Foggi & Venturi (2009) sarebbe presente una vegetazione a dominanza di J. oxycedrus su substrato serpentinoso, non siamo stati in grado di ritrovare la specie ricercata, mentre abbiamo potuto constatare la presenza di individui sparsi di Juniperus communis L. subsp. communis. A questo bisogna aggiungere che, dopo una ricerca nei tre principali erbari toscani (FI, PI, SIENA), non abbiamo trovato alcun campione riferibile a J. oxycedrus per la provincia di Prato (Roma-Marzio & al. 2016).
Il genere Taxodium
conta 2 specie (per altri autori 3) originarie del N-America (1 coltivata e a volte naturalizzata in Italia). Si tratta di grandi alberi caratterizzati dalle radici che emettono delle strutture respiratorie legnose (dette pneumatofori) che si ergono verticalmente sopra il terreno PALUDOSO E asfittico, dalle foglie lineari non pungenti, alterne, verde-chiare che cadono in autunno insieme ai loro ramettidai coni che invece di aprirsi a maturità si disgregano per liberare i semi (in inverno).
ex-Taxodium distichum (L.) Rich. CIPRESSO DELLE PALUDI
P scap – Esotica coltivata in ambienti umidi a volte naturalizzata originaria del N-America - II-IV – Estinta.
Albero eretto a chioma conico-piramidale, alto 30-40 m (nei luoghi d'origine molto di più), con radici che emettono pneumatofori, corteccia fibrosa a fissurazioni rosso-brune; foglie decidue, lineari, di colore verde-chiaro, inermi, di 1-2 cm, distiche sui rametti insieme ai quali cadono in autunno; coni lunghi 1,5-3 cm, tondeggianti che da verdi virano al bruno (i coni maschili sono riuniti in amenti all'apice dei rami e sono di colore purpureo.
Habitat: terreni paludosi o comunque terreni posti presso stagni o laghetti.
Distribuzione sul territorio:
Cascine di Tavola: Cenni 1990 e non ritrovato da Gestri & Lazzeri 2021.
NB: nel secolo scorso vi erano ancora presenti alcune piante coltivate e fra queste almeno una aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli (ricordo di aver veduto io stesso un grande albero alto ca. 20 m quarant'anni or sono insieme all'amico Bruno Acciai): sono scomparse ormai da diversi anni per l'abbassamento della falda freatica.
-× Cupressocyparis leylandii (A.B. Jacks. & Dallim.) Dallim. CIPRESSO DI LEYLAND
P scap - Si tratta di un ibrido intergenetico fra Cupressus macrocarpa e Callitropsis nootkatensis ottenuta casualmente da alcuni giardinieri nel 1880 e poi utilizzato a fini decorativi; è adatto soprattutto per la costituzione di siepi e come frangivento. Albero monoico, eretto a chioma piramidata e di colore diversificato a seconda delle varietà, alto fino a 35 m; foglie simili a quelle del cipresso di lunghezza di ca. 1 m e appressate nei rametti; fruttifica raramente, i coni femminili, posti singolarmente su un breve peduncolo, appaiono tondeggianti di ca. 2 cm, di colore marrone scuro e con rilievi a volte pronunciati sulle squame.
Distribuzione sul territorio:
Cascine di tavola: Boretti & al. 2006: Podere del Caciao.