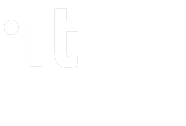Ericaceae
FAMIGLIA Ericaceae
Famiglia che ha incluso in questi ultimi anni varie altre Famiglie non più riconosciute valide in seguito alle ricerche genetiche (Empetraceae, Epacridaceae, Monotropaceae, Pyrolaceae e Vacciniaceae); conta adesso da 130 a più di 150 generi e più di 4000 specie. Si tratta in maggioranza di piante arbustive, ma anche erbacee, appartenenti alle Dicotiledoni, con foglie spesso alterne, fiori (solitamente penduli) con calice evidente, corolla a petali connati, 10 stami, ovario a 5 carpelli e supero, singoli riuniti in infiorescenze a racemo, grappolo o ad ombrella semplice; il frutto è una capsula, una bacca o una drupa.
Il genere Arbutus
conta una decina di specie ed è distribuito in Europa, in area Mediterranea e in N-America (1 specie in Italia). Si tratta di piante arbustive sempreverdi, alte a maturità più di 1 m, a foglie alterne picciolate e lunghe 10-12 cm; i fiori – pentameri, ad ovario supero, sepali saldati in basso, corolla di forma urceolata a lobi brevi e revoluti (divisa per meno del 30%) – sono riuniti in infiorescenze bratteata a pannocchia a più di 10 unità; il frutto è una bacca globosa, carnosa e granulosa all'esterno.
-Arbutus unedo L. CORBEZZOLO
P caesp/scap – Medit. - X-XII – Comune, ma localizzato su substrato non calcareo.
Arbusto o alberello sempreverde, alto da 1 a 10 m (può sopravvivere fino a 4 secoli!), con fiori ermafroditi a fioritura invernale. Il fusto, eretto, ha corteccia rosso-brunastra e fissurata, i rametti appaiono tomentosi; le foglie quasi sessili e alterne hanno forma ellittico-lanceolata, a margine dentellato, lucenti sulla faccia superiore; i fiori hanno corolla (5-8 X 6-10 mm) biancastra di forma campanulata e a lobi brevi e ricurvi; i frutti, commestibili, sono bacche (1-2 cm) globose, coperte di rigonfiamenti conici, prima gialle e poi rosse a maturità. Convivendo in inverno le foglie verdi, i fiori bianchi e i frutti rossi (pianta tricolore) è stata proposta quale essenza vegetale rappresentativa dell’Italia unita.
Habitat: boschi, arbusteti e macchie su suoli silicei.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1947; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Corbezzolo): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Biagioli 1992: Carmignano, P. a Caiano; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Biagioli & al. 2002: a monte delle Ville di Bagnolo … stradella per l'ex-cava Guarino (Montemurlo).
- Monte Le Coste: Tozzi 1998 (sub Corbezzolo): Natreta; Gestri & Peruzzi 2013b (S).
PS: il nome scientifico Arbutus è il nome latino di questa pianta e l’epiteto unedo deriverebbe da unum edo = ne mangio (solo) uno, o a causa del sapore allappante o perché un numero eccessivo di corbezzole potrebbe rilevarsi indigesto.
La farfalla del corbezzolo (Charaxes jasius L.) è una delle più belle in Italia e le sue larve si nutrono esclusivamente delle foglie del nostro albero (senza danneggiarlo più di tanto!).
Il genere Calluna
è monospecifico. Le sue piante si distinguono dalle altre specie della Famiglia (escluso quelle del genere Erica) per le foglie aghiformi, larghe meno di 2 mm e per il calice persistente nel frutto; dal genere Erica per essere arbusti di altezza inferiore al metro, per avere foglie opposte, embricate, aghiformi e lunghe 2-3 mm, inoltre per i fiori con calice a sepali rosati (o bianchi), petaloidi e più lunghi della corolla.
-Calluna vulgaris (L.) Hull BRUGO
Ch frut (NP) – Circumbor. - VIII-XI – Poco comune e localizzata su suoli acidi.
Arbusto o piccolo cespuglio sempreverde, alto al massimo fino a 1 m; ha fusto legnoso, ± tortuoso e ramificato, con corteccia arrossata; le foglie hanno la forma di scagliette lineari (lunghe 2-3 mm), disposte in 4 ranghi longitudinali ed embricate; i fiori, brevemente peduncolati, hanno 4 petali quasi liberi e rosati, calice petaloide a 4 sepali oblunghi, più lunghi della corolla, concolori ai petali e con brevi brattee alla base; sono riuniti in grappoli terminali lassi; il frutto è una capsula subglobosa e tomentosa, di 1-2,5 mm.
Habitat: lande, brughiere, margini e radure boschive su substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 (Acandoli, fra Acquiputoli e Cave ecc. su suoli acidificati), Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: presso il Tabernacolo Gavigno (2017), strada bianca da Migliana a Le Cavallaie (2018), M. Scalette (2020) (Cantagallo).
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Vaiano.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Brugo): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Maugini 1946: Poggio del Cerreto (a W del Bargo, P. a Caiano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936 (sub C. v. Hall. var. glabra Neilr.); Corti 1975; Arrigoni & al. 1979; Ricceri 1993 e 1998; Biagioli & al. 2002: sentiero degli Elefanti, stradella per ex-cava Guarino e soprattutto nel vasto ericeto-pineta della Gretaia (Montemurlo).
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
Il genere Erica
conta circa 850 specie distribuite in Europea, in area Mediterranea e nella Maraconesia (10 indigene ed 1 esotica in Italia). Le sue piante sono rappresentate da cespugli o arbusti a fusto e rami fragili, foglie persistenti, sottili, verdi, sessili o quasi, verticillate per 3-5, e revolute sul bordo; i fiori hanno il calice a 4 lobi, più breve della corolla, che ha forma campanulata terminata da 4 dentelli; i fiori sono riuniti in grappoli semplici o composti terminali. Si distinguono dalle altre specie della Famiglia (escluso quelle del genere Calluna) per le foglie squamose larghe meno di 2 mm e per il calice persistente nel frutto; da Calluna per essere arbusti alti 0,5-8 m con le foglie verticillate, lineari, non embricate, lunghe 4-13 mm e per i fiori con calice sepaloide, più breve della corolla.
-Erica arborea L. SCOPA, STIPA
P caesp (NP) – Medit. - III-V – Abbastanza comune su suoli acidi.
Arbusto alto 1-5 m, che si caratterizza per le foglie e il calice glabri, il fusto con numerose ramificazioni, i giovani rametti biancastri e vellutati (peli ineguali e per lo più ramificati), le infiorescenze piramidali a grappolo composto, il peduncolo dei fiori più lungo della corolla (bianca) e le foglie (aghiformi, 0.5 X 5 mm), verticillate per 3-4, con, sulla faccia inferiore, una sola banda chiara. Fiorisce più precocemente di E. scoparia.
Habitat: macchie, boschi chiari, radure, garighe su suoli acidi.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino pratese principale: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001 e Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peuzzi 2016: Vaiano.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998: Ampil del Monteferrato; Biagioli & al. 1999 (sub Stipa): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Grilli 1857 Campione d'erbario (FI): comune di Carmignano; Provasi 1921, campione d'erbario (FI): alla Gonfolina tra Signa e Montelupo; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; oss. Roma-Marzio 2017 Wikiplantbase#Toscana: lungo la via Madonna Madonna del Papa, dopo Bruceto (Carmignano).
- Monteferrato: Fiori 1914; Maugini 1936 (sub E. a. L. var. stylosa Kud.); Arrigoni & al. 1983; Ricceri 1993; Biagioli & al. 2002: frequente in tutta l'area ofiolitica soprattutto nelle pinete rade (Prato, Montemurlo); Foggi & Venturi 2009: tra Monteferrato e Monte Piccioli.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Rilievi a W di Vaiano: Foggi & Venturi 2009: Poggio Prato Tondo a E di C. alle Cave; nuovi ritrovamenti: sopra la Collina di Schignano (2024).
Foto B. Pierini
-Erica scoparia L. subsp. scoparia ERICA DA SCOPE
P caesp (NP) – W-Medit. - V-VI – Relat. comune su substrati acidi.
Arbusto alto da 30 a 150 cm, assai simile a E. arborea: si diversifica per la taglia ridotta, i giovani rami glabri, i fiori - piccoli (2 mm), penduli, a corolla verdastra (o screziata di bruno-porpora) e globosa - sono riuniti in racemi lassi terminati da un ciuffo di foglie; le foglie (aghiformi, 0,7-1 X 4-5 mm), lineari e a punta ottusa, presentano sulla faccia inferiore due bande chiare. Fiorisce in più tardi di E. arborea, in maggio-giugno.
Habitat: forre, macchie, boschi chiari su substrato acido e spesso in luoghi sottoposti a incendi.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub E. s. sl); Gestri & Lazzeri 2021 (sub E. s. L. sl).
- Calvana: Arrigoni & Bartolini 1997 (sub E. s. L. sl).
- Localizzazioni generiche: Baroni 1897-1908 (sub E. s. L. sl): Prato (Somm. herb.); Biagioli & al. 1999 (sub Erica da scope): AMPIL Monteferrato.
- Monteferrato: Fiori 1914 (sub E. s. sl); Messeri 1936 (sub E. s. L. sl); Corti 1975 (sub E. s. L. sl); Arrigoni & al. 1983 (sub E. s. L. sl); Ricceri 1993 (sub E. s. L. sl); Biagioli & al. 1999 (sub Erica da scope); Biagioli & al. 2002 (sub E. s. L. sl): frequente in tutta l'area ofiolitica soprattutto nelle pinete rade (Prato, Montemurlo); Foggi & Venturi 2009 (sub E. s. L. sl): tra Monteferrato e Monte Piccioli.
- Montalbano: Levier 1898 (sub E. s. L. sl) campione d'erbario (FI): summi collis Artimino supra Signa ad occid. Florentiae (carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a (sub E. s. L. sl): Carmignano, P. a Caiano; oss. Peruzzi 2023 Wikiplantbase#Toscana: comune di Carmignano.
- Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Rilievi a W di Vaiano: Foggi & Venturi 2009 (sub E. s. L. sl): Poggio Prato Tondo a E di C. alle Cave.
Il genere Monotropa
conta tre specie originarie delle aree temperate dell'emisfero boreale (2 in Italia). Si tratta di piante erbacee perenni prive di clorofilla di colore bianco-giallastro (micoeterotrofe: ovvero traggono nutrimento da micromiceti sotterranei) con scaglie che sostituiscono le foglie, distribuite lungo il fusto in maniera alterna e prive di picciolo; hanno rizoma carnoso e odoroso, fusto alto da 5 a 30 cm con la parte apicale rivolta in basso all'antesi ed i fiori, attinomorfi a 4 (-5) petali saccati, sono riuniti in racemo terminale paucifloro. Un tempo costituivano una Famiglia a parte (Monotropaceae).
-Monotropa hypophegea Wallr. IPOPITIDE GLABRA
G par – Europ. - V-VII – Molto rara (o poco osservata).
Vedi descrizione del genere. Si differenzia da M. hypopitys per avere i fiori ad ovario glabro (anche corolla sulla faccia interna, stami e stilo sono normalmente glabri, ma non sempre) e globoso, e così il frutto a capsula; lo stilo appare inoltre di lunghezza uguale o inferire all'ovario.
Habitat: boschi di conifere e latifoglie (in particolare pinete).
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: nuovi ritrovamenti: verso Gavigno in rimboschimenti a pino nero (2007) (Cantagallo).
- Rilievi di Montemurlo nell'AMPIL del Monteferrato: ritrovata anni fa da A. Messina e pubblicata sul sito Acta plantarum (?): sopra il bacino di Bagnolo.
-Monotropa hypopitys L. IPOPITIDE PELOSETTA
G par – Circumbor. - V-VII – Non particolarmente rara nei boschi di faggio o di conifere sopra una certa altitudine (500 m).
Vedi descrizione del genere. Si differenzia da M. hypophregea per la faccia interna della corolla, l'ovario, i filamenti e lo stilo coperti da pelosità irsuta; l' ovario ed il frutto (a capsula) hanno forma un po' più lunga che larga e lo stilo è alto come o più dell'ovario.
Habitat: boschi di conifere e latifoglie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Venturi 2006: Limentra orientale: M. Scalette e Pian della Rasa; nuovi ritrovamenti: faggeta sotto l'Alpe di Cavarzano (2014); M. Scoperta (2018) (Vernio); verso le Cavallaie nelle faggete (2024) (Cantagallo/Montemurlo).
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Cantagallo.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano.
Il genere Pyrola
conta da 30 a più di 40 specie distribuite nelle aree temperate ed artiche settentrionali dell'Europa, in Asia ed in America (4 in Italia). Si tratta di piante erbacee glabre, rizomatose e capaci di “nutrirsi” attraverso la sintesi clorofilliana, ma anche attraverso simbiosi micorrizica con specifici micromiceti sotterranei (organismi mixotrofi); hanno foglie a lembo ovato o suborbicolare e ottuso; sono disposte in rosetta basale lassa, con le cauline ridotte a squame; fiori si mostrano riuniti in racemi terminali, sono regolari con calice persistente a 5 sepali saldati in basso, calice a 5 petali liberi, 10 stami inferiori ai petali; il frutto è una capsula deiscente di forma subglobosa.
-Pyrola minor L. PIROLETTA MINORE
H ros – Circumbor. - VI-VII – Rarissima.
Erbacea alta 10-30 cm, a fusto eretto, semplice, munito di 1-4 scaglie alterne, biancastre e di forma triangolare; foglie basali con picciolo inferiore al lembo e che si presenta da ovato ad ellittico, lungo fino a poco meno di 5 cm, con margine finemente dentato-crenulato; i fiori - a corolla bianco-rosata con i 5 petali conniventi lunghi ca. 4 mm, il doppio dei sepali, ovato-triangolari e acuti in alto – sono riuniti in racemo non monolaterale di 15-20 unità; il frutto è una capsula pendula. Rispetto alle specie congeneri si caratterizza per avere lo stilo dritto, centrale rispetto agli stami e lungo 2,5 mm (incluso nella corolla globosa e solo un poco aperta in alto) e per i sepali verdi di 1-1,5 mm.
Habitat: boschi di sempreverdi e latifoglie (soprattutto faggete) sopra i 500 m e più di altitudine, su substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Gestri & Peruzzi 2009 e Gestri 2018: faggeta sul M. Scalette (Cantagallo).
Il genere Vaccinium
conta una centocinquantina di specie a distribuzione subcosmopolita, molte presenti nelle aree temperate e fredde dell'emisfero boreale (7 in Italia). Si tratta in maggioranza di piccoli arbusti a foglie decidue o persistenti, alterne, subsessili o brevemente picciolate; fiori – tetra- o penta-meri a sepali connati e corolla a petali saldati fra loro a forma di orciolo con i lobi riflessi; i frutti sono bacche a volte commestibili. Le specie europee vegetano su suoli acidi e rifuggono quelli calcarei.
-Vaccinium myrtillus L. MIRTILLO NERO
Ch suffr – Circumbor. - VI-VII – Non comune e localizzato.
Piccolo arbusto alto 20-60 cm, glabro, a rami verdi, angolato-alati ed eretti; foglie decidue dotate di breve picciolo (ca. 1 mm) e lamina ovato-acuta, piana e dentellata al margine, lunga 20-25 mm; i fiori sono penduli, solitari o a coppia all'ascella fogliare, con corolla bianco-verdastra e ± rosata di forma urceolata con apici petalici riflessi, calice a sepali brevi e ottusi; il frutto è una bacca nero-bluastra e globosa (ottimo commestibile).
Habitat: boschi, radure, brughiere, su terreno umido e acidificato.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002 (presso Fregionaia, presso Le Cave, Casina le Barbe verso Vespaio, presso Uccelliera, Lavacchio ecc.), Arrigoni & al. 2005: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; nuovi ritrovamenti: M. Scalette (2017), dall'Acqua alla Rasa (2024) (Cantagallo).
- Rilievi di Montemurlo: nuovi ritrovamenti: presso le Cavallaie (2021).